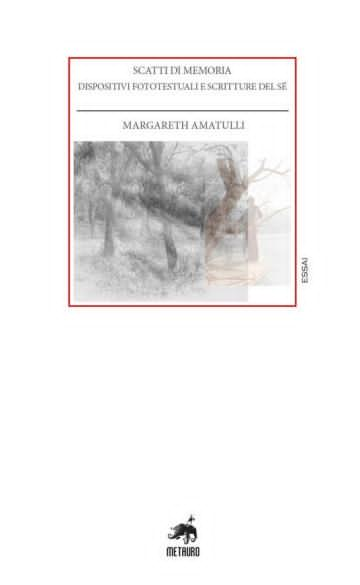
Il titolo del recente volume di Margareth Amatulli costituisce uno di quegli esempi di felice sintesi che consente, a chi si accosta alla lettura, di prefigurarsi esattamente cosa andrà incontrando nel testo. Scatti di memoria. Dispositivi fototestuali e scritture del sé (Metauro 2020) esibisce, infatti, i tre elementi attorno cui l’autrice costruisce una fitta rete di snodi –aperture verso un ventaglio di significati possibili – e nodi – punti di congiunzione, di contatto – a partire da quattro opere di autrici e autori francesi apparse negli ultimi trent’anni. Fotografia, memoria e letteratura del sé – quest’ultima interpretata volutamente in una costante oscillazione tra autobiografia e autofiction – costituiscono le chiavi interpretative per accedere a quattro testi che non esauriscono certo le modalità di interazione tra photolittérature – così come l’ha definita Jean-Pierre Montier, convocato da Amatulli nel primo capitolo del saggio – e memorialità, intesa in senso sia individuale che collettivo. D’altronde non è questo l’obiettivo del volume, che non mira tanto, o solo, a inserirsi all’interno del dibattito teorico sulla fototestualità, dibattito i cui esiti vengono comunque ben sintetizzati nel primo capitolo, che ripercorre le proposte classificatorie, fornite da numerosi teorici della semiotica e della letteratura, di un genere che per sua stessa natura elude ogni definizione eccessivamente restrittiva; scopo del saggio è piuttosto quello di prendere le mosse dagli apparenti confini caratteristici dei generi – non solo quello fototestuale, ma anche le forme molteplici riassumibili nelle ‘scritture del sé’ – per mostrarne la porosità nel momento in cui tali dispositivi devono fare i conti con una costante culturale, all’incrocio tra bíos e mimesis, come la memoria, tema che appartiene statutariamente tanto all’atto fotografico quanto alla scrittura dell’io.
Reliques di Henri Raczymow (2005), Le Voile noir di Anny Duperey (1992), Y penser sans cesse di Marie NDiaye (2011) e Mes bureaux di Jean-Philippe Toussaint (2005), qui proposti secondo l’ordine di trattazione dell’autrice, vengono presentati come un campionario multiforme e tuttavia paradigmatico. Attraverso un’analisi serrata che implica una serie di operazioni interpretative di volta in volta applicate al caso di studio, Amatulli procede a una disamina in cui la pregnanza del tema memoriale non è mai distinta da un’interpretazione attenta delle forme così come del layout, che nel caso di un fototesto costituisce un elemento strutturale imprescindibile. Per tutti i testi la studiosa, dopo aver dato conto dei tratti generali dell’opera, si sofferma sulla loro consistenza quasi materica all’interno di una sezione intitolata Leggere e vedere, che consente di figurarsi in modo chiaro le relazioni geometriche e spaziali tra scrittura e immagine. Segue poi un approfondimento in senso sia tematico che formale, teso a rintracciare soprattutto le declinazioni della funzione memoriale che tanto le parole quanto le immagini assolvono in un constante esercizio di mediazione tra storia personale e storia collettiva, tra tentativi di elaborazione del lutto e impossibilità di pieno superamento del dato traumatico, tra necessità di ricostruire quasi archeologicamente il passato e l’incursione prepotente del finzionale. I fantasmi della memoria popolano le pagine di opere in cui «la scrittura autobiografica non rispetta, a tratti, il patto mimetico con la realtà su cui tradizionalmente si costruisce, così come la memoria non stipula tassativamente un patto di fedeltà col passato, e la scrittura non necessariamente stringe un legame referenziale con le foto» (p. 43).
Quella in azione è dunque una «memoria impedita» (p. 44), per dirla con Ricoeur, in bilico tra rimozione e coazione a ripetere, ma è anche una «memoria dell’altro» (p. 45), capace di accogliere anche le tracce esperienziali di chi è altro da sé – il che, come ricorda Amatulli, è già preconizzato dallo stesso gesto fotografico, poiché dal momento dello scatto l’io «è già altro da sé» (ibidem) –, ed è pure una «memoria disseminatrice» (p. 47) che fa riverberare, nello spazio e nel tempo, l’eco del principale trauma della storia occidentale – l’Olocausto –, anche laddove esso non pare esplicitamente riferito. Se infatti la Shoah occupa il centro di Reliques di Raczymow – la voce narrante non l’ha vissuta direttamente, ma il suo processo di costruzione identitaria è stato fortemente influenzato dalle lacune, di parole e di vita, che la tragedia ha provocato – essa si fa anche «paradigma di lutti familiari o di situazioni personali» (ibidem). Nel caso di Le Voile noir di Duperey, l’autrice-narratrice tenta, a partire dal ritrovamento delle fotografie del padre, una mai del tutto possibile elaborazione del lutto per la morte accidentale dei genitori, avvenuta quando lei era bambina: l’origine del trauma personale – una fuga di monossido di carbonio che ha provocato il decesso per asfissia – trova consonanze esplicitate nell’opera con le camere a gas dei campi di concentramento nazisti. In Y penser sans cesse, Marie NDiaye racconta lo straniamento del trasloco dalla Francia a Berlino attraverso un doppio dialogo: quello con il figlio progressivamente posseduto dallo spirito di un bambino ebreo, deportato e ucciso in un lager, che un tempo abitava nella casa in cui NDiaye si trasferisce, e quello con le immagini di Denis Cointe, in cui i volti di anonimi passeggeri di treni si infrangono su un paesaggio berlinese che appare in esilio da sé stesso.
Si discosta un po’ dagli altri casi di studio l’ultimo testo analizzato da Amatulli, Mes bureaux di Jean-Philippe Toussaint. Oltre a essere l’unico testo pubblicato originariamente ed esclusivamente in lingua italiana, nonostante l’autore sia francese, esso appare meno ancorato all’urgenza testimoniale che apparenta le tre opere precedentemente esaminate, e sembra piuttosto gettare luce sulla dimensione metanarrativa intrinseca al fototesto. L’incontro tra le fotografie dei luoghi in cui l’autore ha composto le proprie opere nel corso della sua carriera e il racconto di quello stesso processo creativo, con tanto di citazioni tratte dai vari libri firmati dallo scrittore, mette in scena «l’itinerario vagabondo della scrittura e dei suoi attrezzi, delle persone e degli affetti di cui essa si nutre» (p. 167).
In chiusura di volume, Amatulli propone un’ulteriore apertura di senso rispetto alle forme della fototestualità contemporanea, rintracciando due tendenze epistemologiche che costituiscono un arricchimento importante, in chiave di problematizzazione, sul fronte della riflessione teorica, in particolare per quel che riguarda lo studio degli oggetti intermediali. Da un lato, è evidente, secondo la studiosa, la centralità del ruolo del «lettore quale agente del processo di interconnessione tra la scrittura e l’espressione artistica di riferimento» (p. 196): la frequenza di interrogativi rivolti a un immaginario interlocutore, il coinvolgimento attivo del pubblico, o il suo riferimento implicito, all’interno della costruzione del testo, sono alcune delle strategie adottate nelle opere prese in considerazione che possono costituire nuovi orizzonti privilegiati per sondare anche altre forme all’incrocio di più media. Dall’altro, è interessante osservare quanto Amatulli sostiene a proposito della «forza espansiva della parola rispetto all’immagine»:
Come già asseriva Barthes, è solo grazie alla parola che la fotografia si nutre di senso, è la parola che sublima l’immagine amplificandone l’insieme di connotazioni o contraddicendole al punto di generare una connotazione compensatoria […]. Uscendo dal “limite provvisorio” della cornice della fotografia, la parola travalica i confini del rappresentato per percorrere le ampie strade del rappresentabile (p. 195).
È la stessa autrice, tuttavia, a dimostrare, attraverso un percorso analitico condotto in modo puntuale per tutto il volume, quanto possa valere anche il contrario, e cioè che sia proprio l’immagine a proiettare la parola scritta verso direzioni altre e inusitate, alla luce di quell’essere entre-deux che giustamente Amatulli legge in modo unificante, sulla scorta di Montier, nel lessema ‘fotoletteratura’ privata di qualunque trattino al suo interno: «un type d’organisation dans lequel les éléments gardent leurs particularités tout en collaborant à une fin unique» (p. 25).