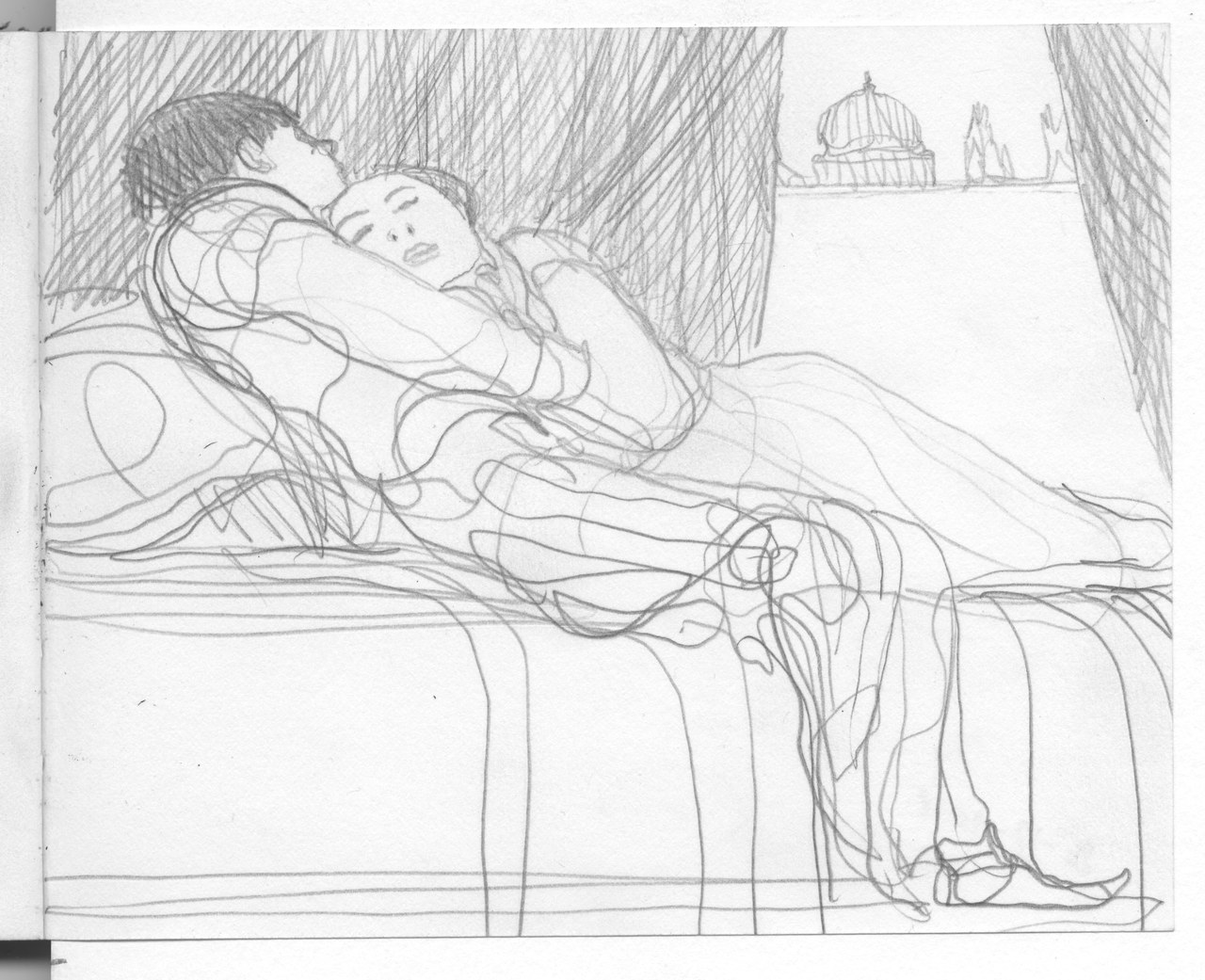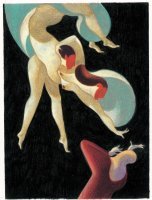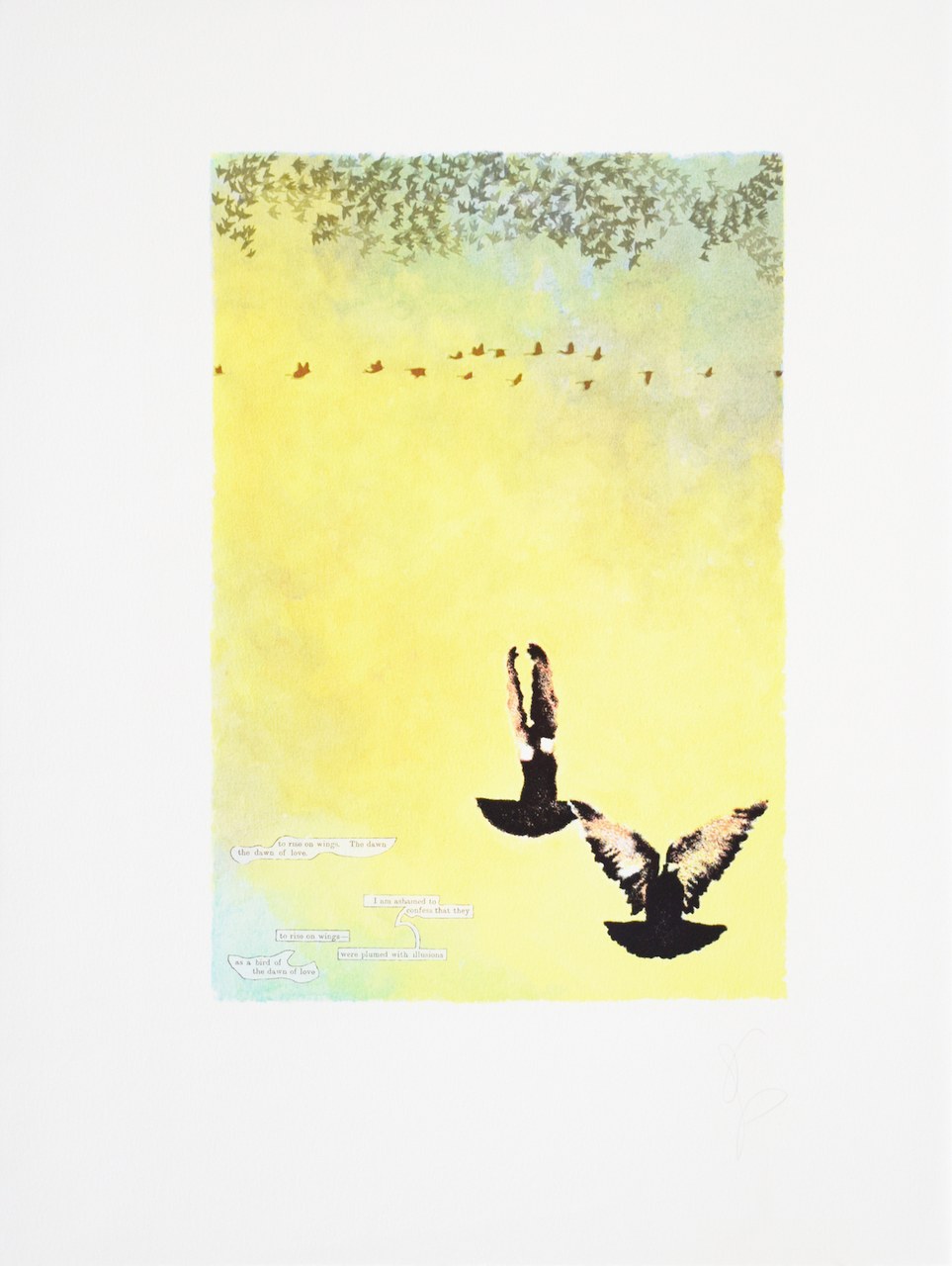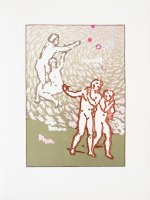La maternità: il vissuto informativo e mediale
La contemporaneità è caratterizzata dalla diffusione e dall’accessibilità di molti saperi differenti che spesso si sovrappongono in modo non sempre armonico. In particolare, con la diffusione di internet e dei social media, si è creato un panorama composito di propagazione dell’informazione che può generare un più facile e diretto accesso alle fonti informative ma al contempo anche causare la diffusione di fake news, notizie non verificate o fuorvianti (misleading information) e di panico morale conseguente. Il settore della salute, in modo esteso, è stato al centro di tali trasformazioni sin dalla prima decade degli anni Duemila con una brusca accelerazione durante la pandemia di Covid-19. La ricerca ha messo in luce aspetti positivi e negativi di questo processo.
Da una parte, fenomeno dell’apomediation (Eysenbach 2008), ovvero della consultazione diretta di notizie di salute senza la mediazione di un professionista della salute, è stato riscontrato a proposito di internet e social media nella misura in cui le persone si affidano a ‘Dr. Google’ (Lee et al. 2014) per individuare diagnosi e terapie. Dall’altra parte, internet e i social media rappresentano validi spazi per il supporto sociale, la diffusione di notizie controllate, la creazione di reti sociali legate a tematiche specifiche (Moorehead at al. 2013). Negli ultimi anni si è inoltre verificato un fenomeno di ulteriore intermediazione dal momento che anche i professionisti della salute hanno iniziato a usare i social media come spazi di promozione della propria attività libero-professionale e/o di divulgazione (Locatelli 2021).
![Fig. 1. Mamma e bambino [foto da banca dati Unsplash, ad uso gratuito; foto dell’utente Nathan Dumlao]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xlocatelli_sampietro_perinatale_g_fig1.jpg.pagespeed.ic.1licRnv6DT.jpg)
![Fig 2. La cameretta dei bambini [foto da banca dati Unsplash, ad uso gratuito; foto dell’utente Sven Brandsma]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xlocatelli_sampietro_perinatale_g_fig2.jpg.pagespeed.ic.uwMCskyh-X.jpg)