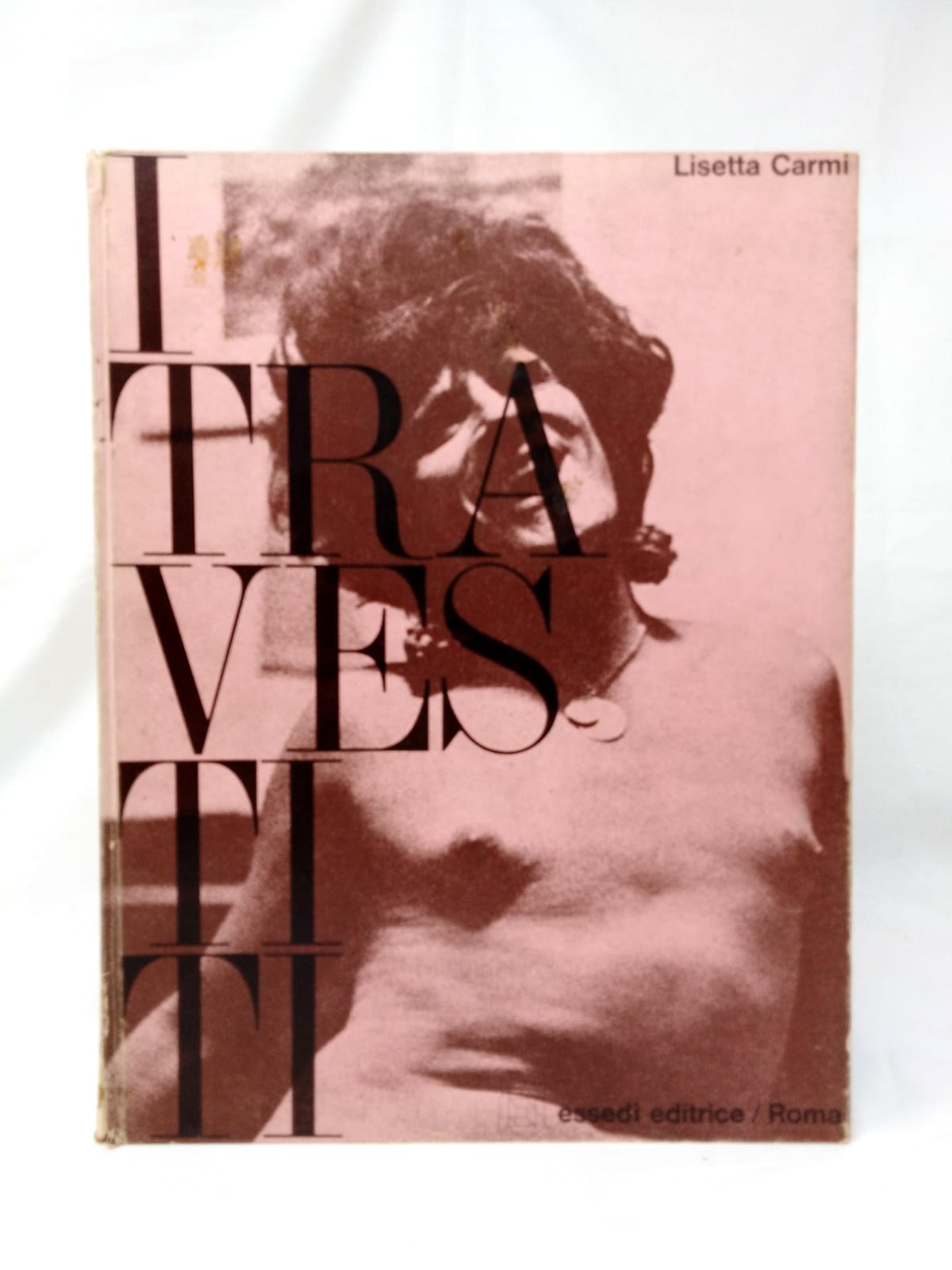Nel 1974, a un mese di distanza, escono i due film di Rainer Werner Fassbinder Martha e Fontane Effi Briest. Il primo girato in 16 millimetri per la televisione, ispirato a un racconto di Cornell Woolrich, il secondo trasposizione dal romanzo omonimo di Theodor Fontane per il cinema. Durante il protrarsi delle fasi di ripresa di Effi Briest a causa della malattia di uno degli attori, Fassbinder decide di realizzare Martha, sorta di versione horror e di parafrasi moderna, come da lui stesso dichiarato (Trimborn, 2014, p. 177), dei temi già presenti in Effi Briest.
Forgiati al pari di due facce della medesima medaglia, i due lungometraggi possono facilmente essere accostati per la rilevanza accordata a un tema costante del cinema di Fassbinder: i rapporti di dipendenza e di potere in una coppia. In entrambi sono anche presenti componenti stilistiche riconducibili al melodramma, con specifiche declinazioni, tra le altre la scelta di disegnare le traiettorie delle dinamiche amorose all’interno degli spazi chiusi di una casa, che assume i connotati di un luogo concentrazionale (Salvatore, 2018, p. 146). Il melodramma, scelto dal regista quale codice elettivo per le due pellicole dopo la folgorante visione dei film di Douglas Sirk nel 1971, secondo Elsaesser è il genere «capable of reproducing more directly than other genres the patterns of dominance and exploitation existing in a given society, […] by emphasizing so clearly an emotional dynamic whose social correlative is a network of external forces directed oppressingly inward, and with which the characters themselves unwittingly collude to become their agents» (Elsaesser, 1991, p. 86). La ricorrenza figurativa di specchi, finestre, soglie, scale, oggetti d’arredo, non è al servizio di una funzione decorativa, non è scena inerte, manifesta piuttosto metaforiche allusioni al vissuto dei protagonisti e all’accentuazione delle dinamiche affettive che vedono nell’incontro d’a-mur tra donna e uomo, nel caso in particolare di Martha, protagonista del film omonimo, un oscillare tra obbedienza e inconsapevole dominio sull’altro. Uso intenzionalmente il termine a-mur, ovvero la pronuncia in francese del lemma amour per evocare, sulla scia di Lacan, come le dinamiche dell’amore possano a volte richiamare una lotta contro un muro.