Qualsivoglia discorso critico intorno alla figura di Elsa de’ Giorgi non può prescindere da una considerazione preliminare: nella vicenda biografica e artistica di quest’attrice e scrittrice, attorialità e autorialità appaiono come due dimensioni contigue, complementari, profondamente intrecciate tra loro. È quindi un grave errore prospettico pensare che vi sia stato un passaggio, un cedere il testimone dal cinema al teatro alla scrittura: si allestirebbe, in questa direzione, una cornice interpretativa inadeguata che condurrebbe a ricostruzioni falsate. Si potrebbe piuttosto concepire tutta la vita di Elsa de’ Giorgi come un teatro della scrittura, talvolta un po’ eccessivo o folle, com’era nel suo temperamento.
La sua figura fu segnata fin da subito da due valori, destinati a diventare due veri e propri vettori fondamentali, che da soli già spiegherebbero molto di quel temperamento. Mi riferisco ai concetti di verità e di libertà. Il lettore li ritrova in uno snodo essenziale del percorso espressivo di quest’autrice, ovvero il saggio su Shakespeare e l’attore, edito nel 1950 come un opuscolo della sede fiorentina dell’Electa. In realtà il saggio prende avvio in forma di recensione, invero assai critica, al libro di Valentina Capocci, Genio e mestiere, pubblicato da Laterza l’anno prima. De’ Giorgi mira in questo scritto, sapientemente calibrato, a smontare le tesi della studiosa, mostrando una tale consapevolezza dell’idea stessa di teatro da risultarle perfettamente consustanziale. Leggiamo a pagina 8:
![fig. 1 Karina Puente, Zaira, da [In]visibles cities](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xTriscari_Zaira_g_fig1.jpg.pagespeed.ic.xvdh7GPBUR.jpg)

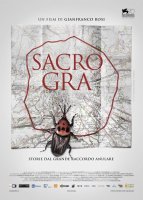




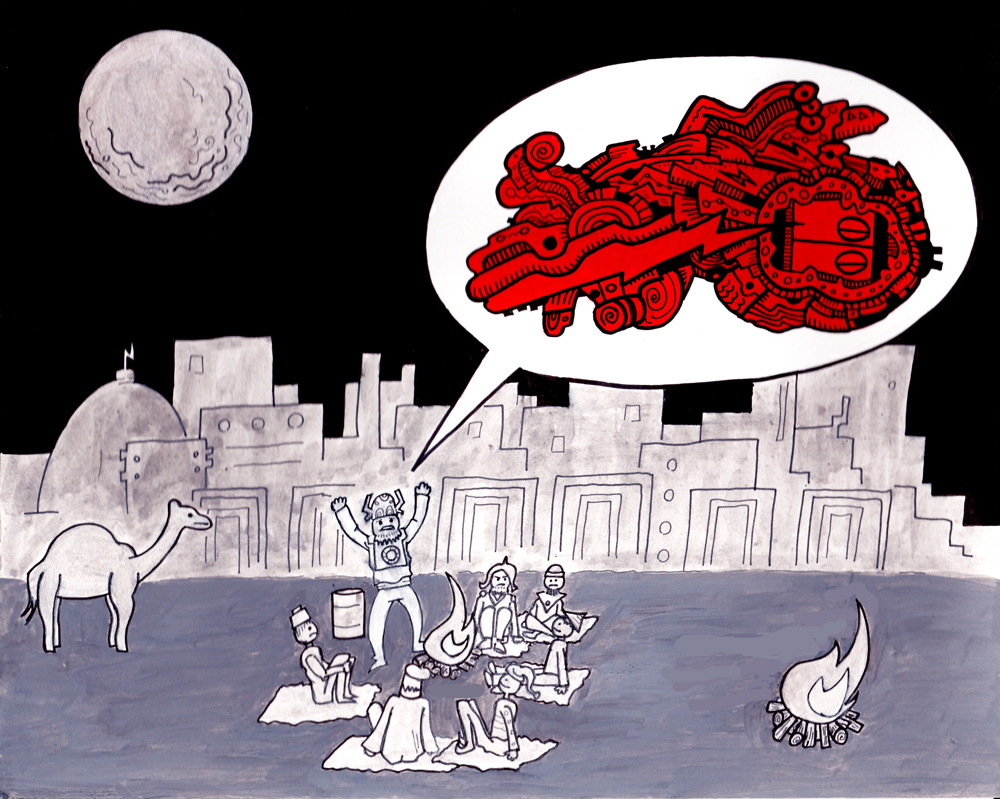


![Fig. 1: Xiomara, Jane e Alba guardano la loro telenovela preferita nella loro cucina (Capitolo 1) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xde_pascalis_janethevirgin_g_fig1.jpeg.pagespeed.ic.XU1Nh7XTsE.jpg)
![Fig. 2: Xiomara balla catturando l’attenzione di tuttə durante la quinceañera di Jane (Capitolo 2) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xde_pascalis_janethevirgin_g_fig2.jpeg.pagespeed.ic.z_1ynyDOvk.jpg)
![Fig. 3: Diversi modelli di genitorialità: Xiomara, Jane, Rafael e Alba (Capitolo 29) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xde_pascalis_janethevirgin_g_fig3.jpg.pagespeed.ic.kr8JHlwY22.jpg)
![Fig. 4: La relatrice femminista di Jane le spiega il funzionamento del Bechdel Test (Capitolo 37) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xde_pascalis_janethevirgin_g_fig4.jpg.pagespeed.ic._pYl7T5QFV.jpg)
![Fig. 5: La voce narrante interviene – anche per iscritto – a dettare alcune regole del racconto sensazionale (Capitolo 51) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/de_pascalis_janethevirgin_g_fig5.jpg.pagespeed.ce.hwNo3k5bGC.jpg)
![Fig. 6: Jane e Rafael si baciano in una nevicata di petali candidi che segna il trionfo del romanticismo (Capitolo 6) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/de_pascalis_janethevirgin_g_fig6.jpg.pagespeed.ce.gaVBqbJGyn.jpg)
![Fig. 7: Xiomara, River e Rogelio guardano il finale di una telenovela in soggiorno (Capitolo 80) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xde_pascalis_janethevirgin_g_fig7.jpeg.pagespeed.ic.Az7jrHUALT.jpg)
![Fig. 8: Jane non è più solo ‘la vergine’, ma anche molte altre cose – fra cui un’autrice di telenovelas (Capitolo 90) [Screenshot da terzi della seria TV Jane the Virgin]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xde_pascalis_janethevirgin_g_fig8.jpg.pagespeed.ic.pZoLcDbIhk.jpg)