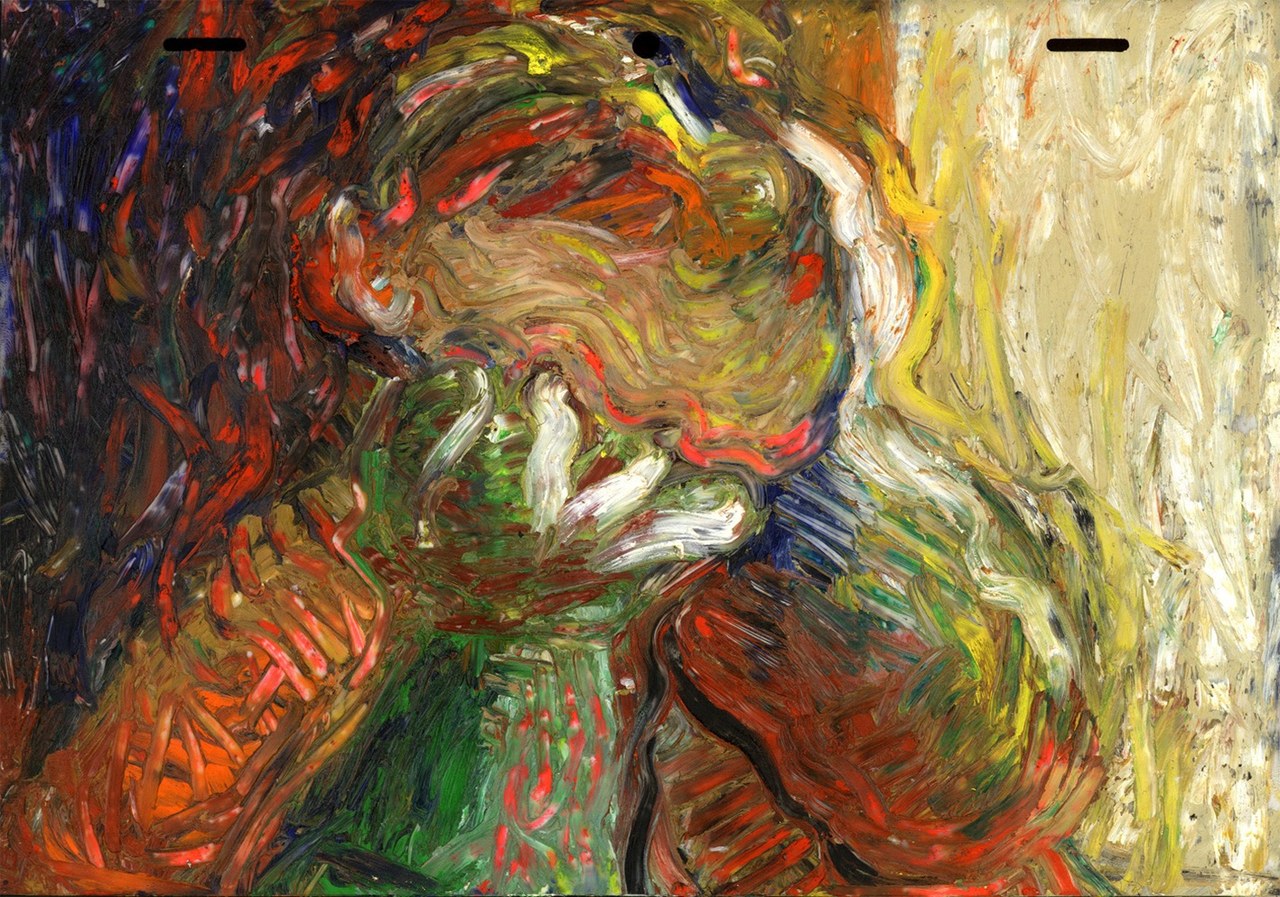Da un dialogo a più voci sugli intrecci concettuali e interdisciplinari intorno a performance, arti performative, performatività e performativo prende origine la raccolta di saggi Reti performative. Letteratura, arte, teatro, nuovi media, riflessione edita a cura di C. Maria Laudando (Tangram Edizioni Scientifiche, 2015). Il merito del volume, da un lato, riguarda l’influenza della svolta performativa novecentesca sulla relazione tra letterarietà, teatralità e visualità e i suoi effetti nel panorama (post)mediale; dall’altro, tenta d’illuminare i confini, le soglie, i margini e le tracce ‘in-visibili’ delle pratiche discorsive, dei processi di ricezione e ‘rimedi-Azione’.
La nota introduttiva della curatrice anticipa gli echi tra i tredici interventi che articolano il confronto: l’assunzione di una prospettiva inter/antidisciplinare e l’apertura a uno spazio liminale tra «teoria e prassi, forma e materia, progettualità e azioni» (p.17). Il volume si divide in tre ‘inter-sezioni’. La prima dipana i fili delle questioni teoriche che ruotano intorno ai concetti legati al termine ‘performance’, ricostruisce uno schema storico-culturale e delinea un approccio metodologico. La sezione centrale, intitolata Il gioco delle parti, affronta i cambiamenti nelle relazioni e nei ruoli ai confini tra diverse pratiche artistiche, (s)oggetti reali e virtuali nel corso del Novecento e nel panorama contemporaneo. Il legame generale tra teoria e prassi emerge chiaramente nell’ultima parte dedicata agli Intrecci e alle dissolvenze identitarie delle pratiche discorsive e dei dispositivi come performance culturali. Il ruolo delle ‘parole-immagini-azioni’ nelle pratiche quotidiane e nelle ricerche artistiche, anticipato già nell’introduzione, ritorna specularmente nel dialogo finale con gli artisti Bianco-Valente. Esse danno vita a un complesso «ecosistema mediatico» (Esposito, p.88), un insieme di processi e interazioni, capace di ‘rendere visibile’ i fili di una (nuova) geografia di memorie, immaginari ed esperienze di sé e dell’Altro.




![Sophia Loren, In cucina con amore [1971], Milano, Rizzoli, 2013.](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xrizzarellim_attrici_g_fig3.png.pagespeed.ic.ihmGxVz6lQ.jpg)
![Foto tratta da Sophia Loren, In cucina con amore [1971], Milano, Rizzoli, 2013.](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xrizzarellim_attrici_g_fig4.png.pagespeed.ic.Zwxc4_gfkl.jpg)