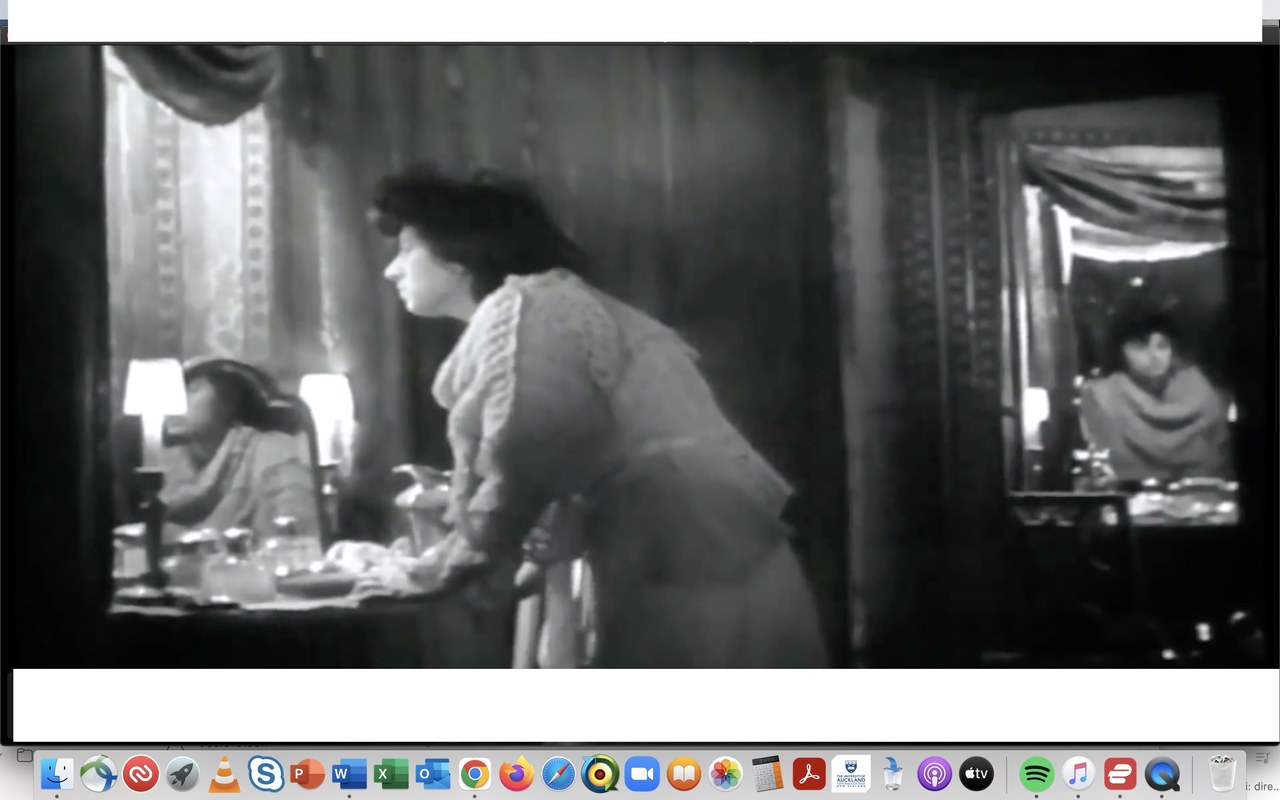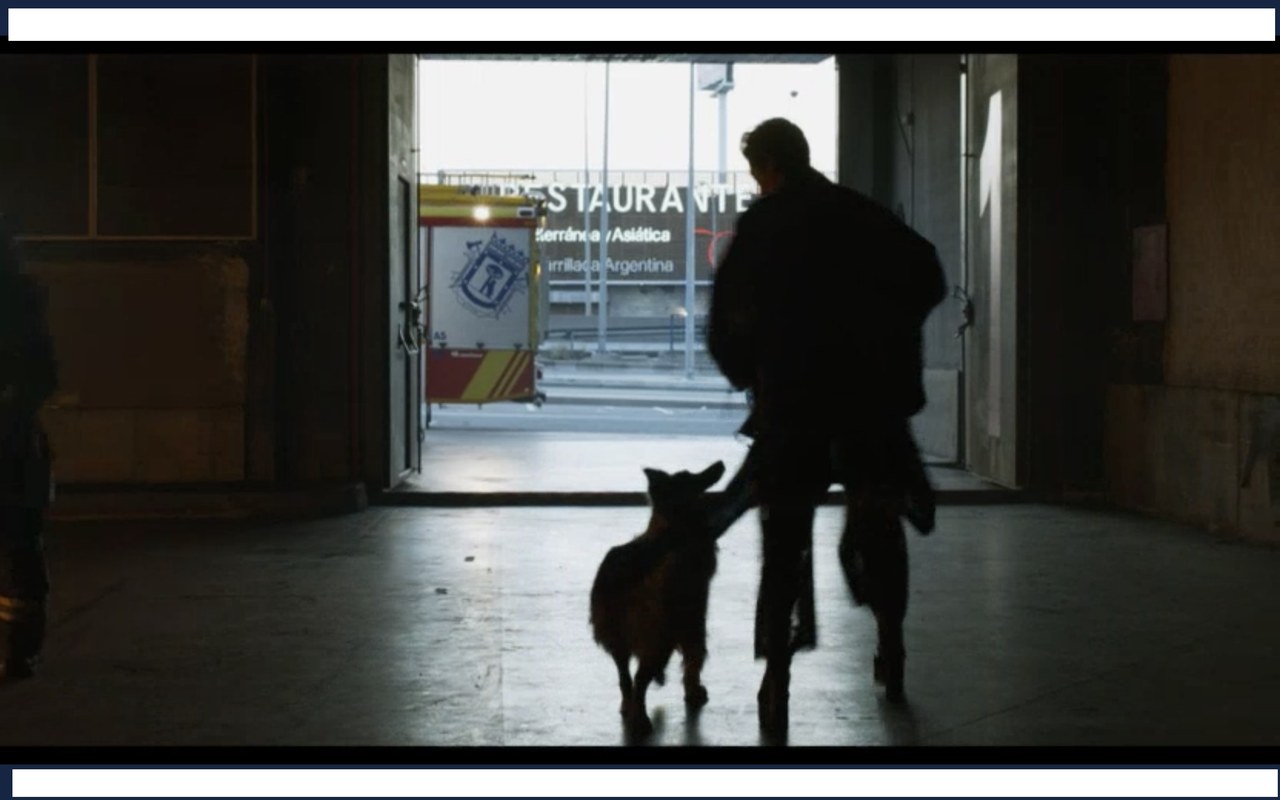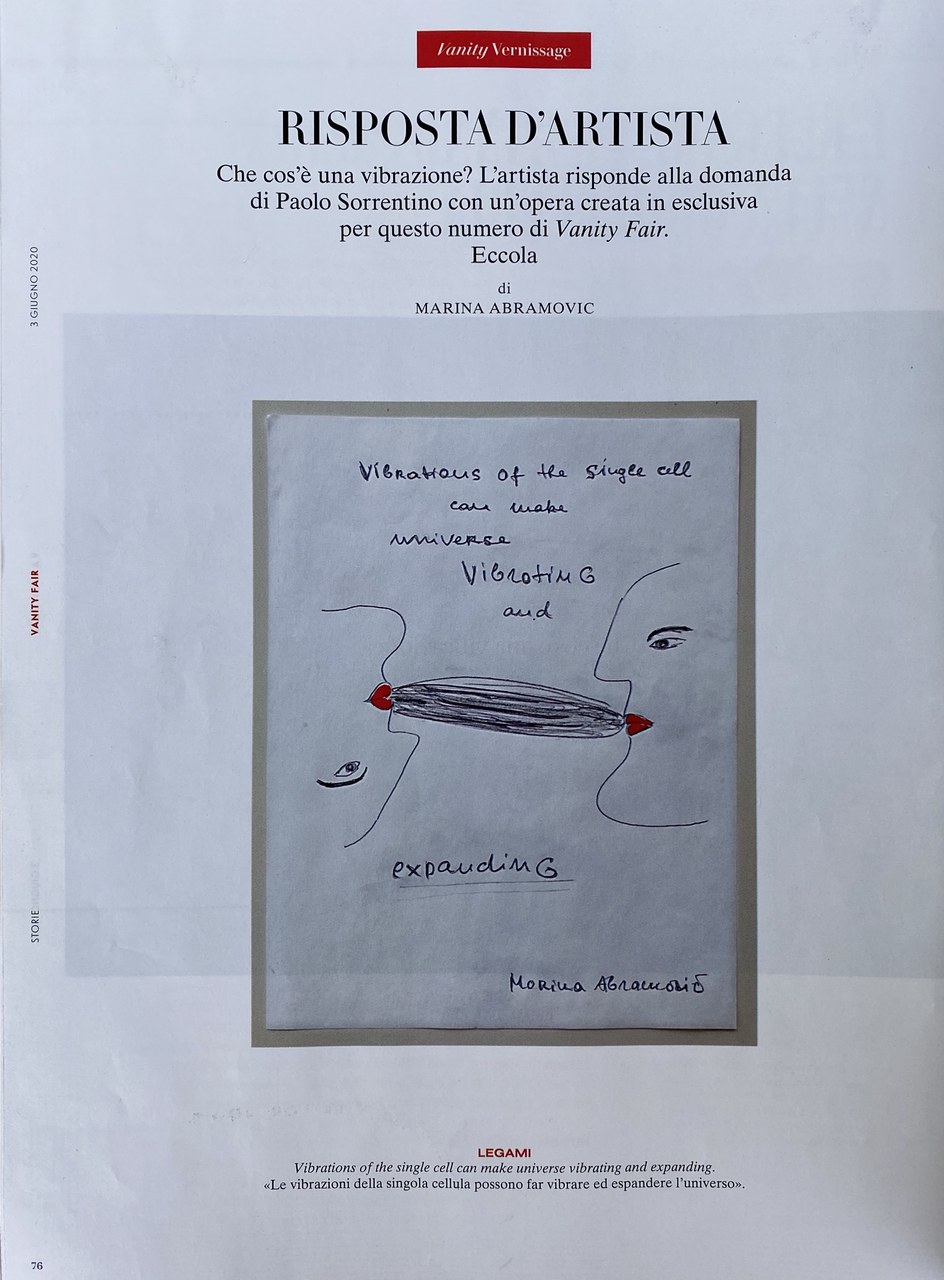Nell’introduzione al suo testo teatrale La voix humaine (1930), Jean Cocteau definisce il progetto come una risposta alle lamentele da parte di quelle attrici che lo avevano accusato di far risaltare, nelle sue opere, più la voce dello scrittore/regista che non la capacità artistica di chi recita. Il testo di Cocteau nasce quindi come un esperimento a partire da alcuni elementi basilari: è un atto unico, c’è un solo personaggio femminile in una camera da letto spoglia in cui spicca l’accessorio di ogni dramma moderno, il telefono, un’invenzione che ha cambiato definitivamente il modo di concepire e rappresentare le relazioni. Il monologo è un dialogo simulato in cui, tramite le parole della protagonista, dobbiamo immaginare le parole, le reazioni e il carattere di chi sta dall’altra parte della cornetta. Il dramma infatti consiste in una lunga telefonata, più volte interrotta, tra una donna che sta parlando al telefono – probabilmente per l’ultima volta – con l’uomo che la sta lasciando dopo un rapporto sentimentale durato cinque anni. Si tratta di uno spettacolo che è stato fatto più volte oggetto di riscrittura e adattamento, e col passare degli anni è diventato praticamente un manuale di recitazione per tante grandi attrici che volevano dimostrare la propria bravura a partire da un testo basato sugli aspetti dolorosi della fine di un amore.
2.9. La voce umana. Anna Magnani, Sophia Loren, e Tilda Swinton: protagoniste del cinema tra le mura di casa
di Bernadette Luciano
Questa pagina fa parte di: