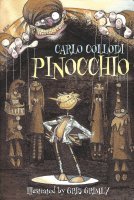* Le citazioni tra virgolette, senza rinvio di nota, si intendono riferite agli interventi del convegno, disponibili online:
https://puppetplays.www.univ-montp3.fr/fr/actualit%C3%A9s/colloque-puppetplays-portrait-du-marionnettiste-en-auteur.
Di che cosa parliamo quando parliamo di testo, a teatro? Chi è l’Autore di un testo che vive pienamente solo nella dimensione della scena e di fronte agli spettatori? E che cosa studiamo quando pretendiamo di studiare un testo inafferrabile per costituzione, che si rimette in discussione ad ogni rappresentazione perché sempre in gioco dinamico e dialettico nelle relazioni con gli altri elementi scenici? E ancora, quali e quante accezioni di ‘Drammaturgia’, e quindi di Dramaturg, possibili oggi?
Sono questioni basilari che conosce bene chi si occupa di performatività, teatro e spettacolo.[1] Questioni sostanziali che, come spesso accade, i teatri di figure sbalzano con maggior ‘profondità’ e rilievo. L’occasione per metterle a fuoco nella loro complessità è data dal progetto Puppetplays, che grazie ad un finanziamento ERC (e ad una appassionata ed efficiente équipe), si è proposto di repertoriare testi per marionette (nell’accezione francese dell’espressione Marionnette, ossia comprensiva di tutti i generi assimilabili ai teatri di figure), offrendoli alla consultazione on line entro una solida cornice storico-critica. Ovvero la costituzione di un archivio digitale di testi, strutturato come una banca dati ad accesso libero, ospitata da una piattaforma[2] articolata. Come si legge nella presentazione del progetto, si tratta di «studiare e rendere accessibile ad un vasto pubblico un’ampia selezione di testi per marionette prodotti nell’Europa occidentale», in un’estensione cronologica dal XVII al XXI secolo; 2000 i titoli, dei quali diverse centinaia in versione digitale, oltre ad una serie di pubblicazioni, dossiers e percorsi tematici, strumenti didattici, dizionario degli autori, glossario. Ad oggi sono stati inseriti 600 testi teatrali, che è possibile ‘attraversare’ seguendo percorsi di ricerca diversificati, sfruttando le preziose relazioni segnalate dal gruppo di ricerca in fase di inserimento.