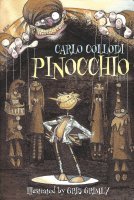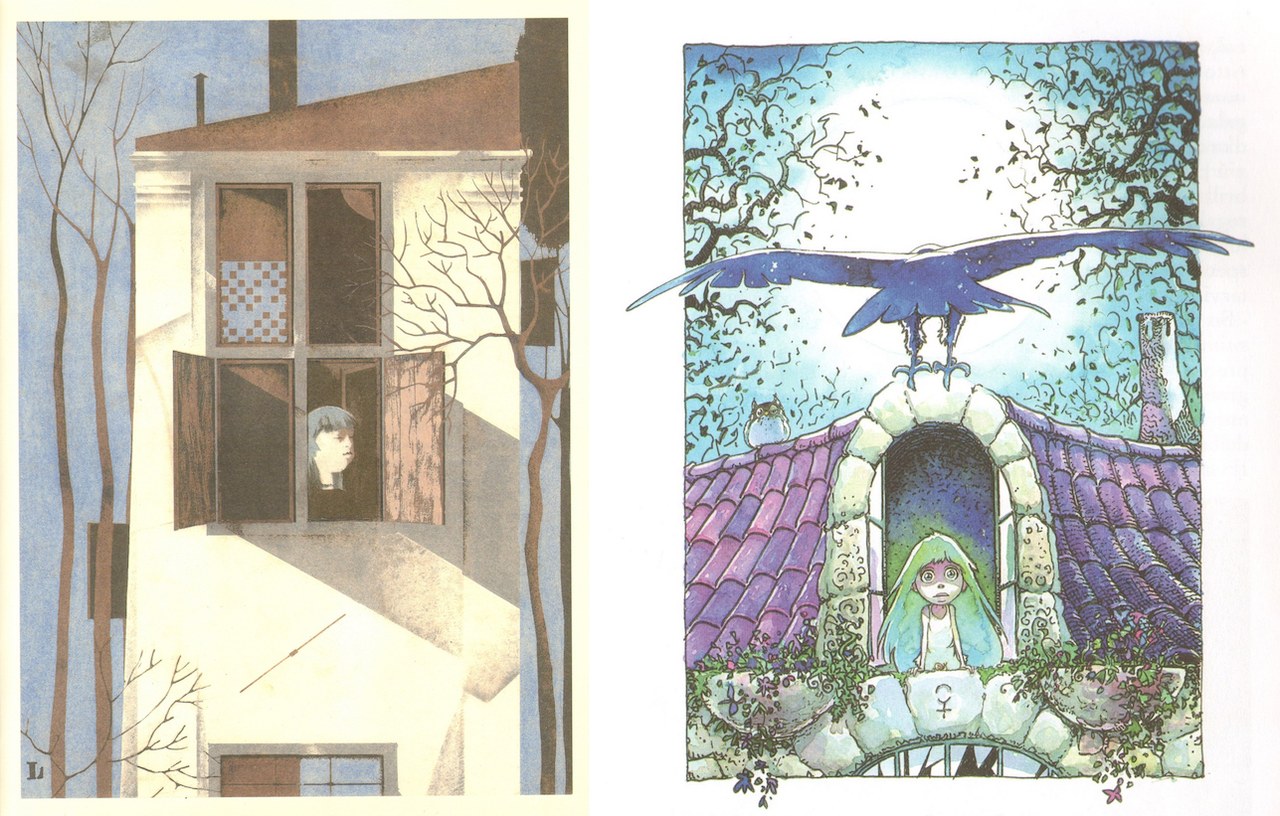Tradotto in più di ventotto lingue, tra cui persiano, giapponese, coreano e addirittura due lingue norvegesi, il Pinocchio di Roberto Innocenti, uscito nel 1988, ha segnato un’inversione di tendenza rispetto all’operazione compiuta sin dagli anni Quaranta da Walt Disney, che aveva scalzato Carlo Collodi dal suo ruolo di autore e imposto nel mondo la sua icona del burattino. Le tavole dipinte ad acquarello, con una perizia straordinaria, da Innocenti ripercorrono la storia autentica del burattino ambientandola nella sua terra madre, una Toscana ottocentesca raggelata e segnata dalla miseria e dalla fame. Si riscoprono così la profondità e l’inquietudine del testo originale, insieme alla sofferenza e alla violenza che erano state bandite dalla versione americana. Nel 2005 Innocenti si è di nuovo cimentato col testo collodiano: le tavole più recenti presentano una chiave interpretativa che si discosta da quelle precedenti, rivelando dimensioni meno drammatiche e impiegando colori più limpidi per descrivere, nelle più diverse forme e con straordinaria competenza architettonica, la dimensione urbana e contadina della Toscana.
Anche la tedesca Sabine Friedrichson, pubblicò il suo Pinocchio nel 1988. In origine le sue illustrazioni dovevano accompagnare l’edizione rielaborata Der neue Pinocchio di Christine Nöstlinger. Dopo essersi resa conto dei cambiamenti che l’autrice viennese aveva apportato al testo collodiano, la Friedrichson decise di ritirare il proprio lavoro, che poteva funzionare solo in un’edizione fedele al testo di Collodi. L’illustratrice si concentra infatti su un singolo dettaglio ingrandito al punto da far sparire tutto il resto, oppure forza la prospettiva in modo da cogliere solo uno scorcio in una diagonale estremamente audace. La scena dell’impiccagione, ad esempio, si focalizza sui piedi agilissimi che non toccano più terra, mentre sullo sfondo si vede solo la casetta bianca divenuta una villa tradizionale toscana.