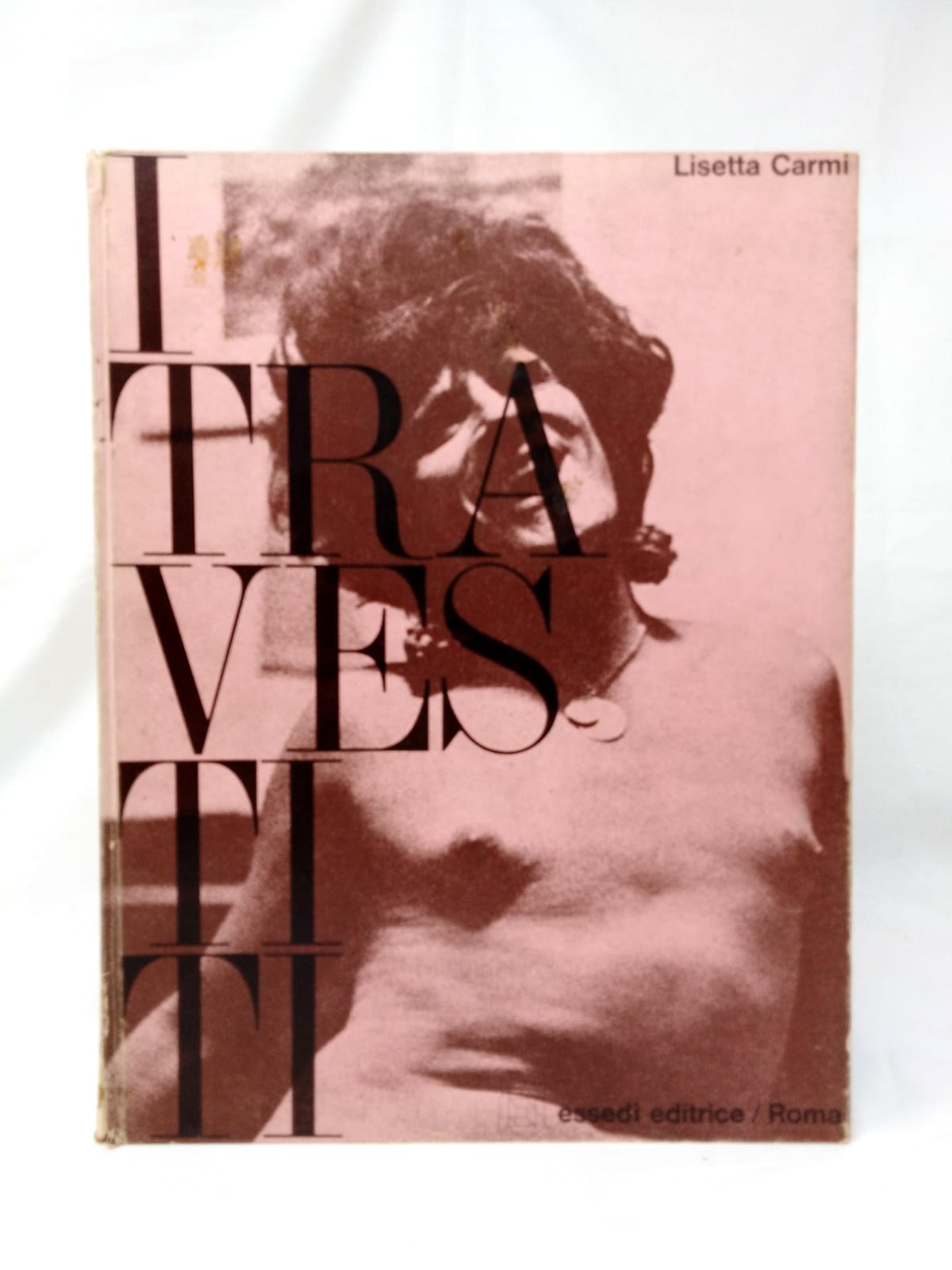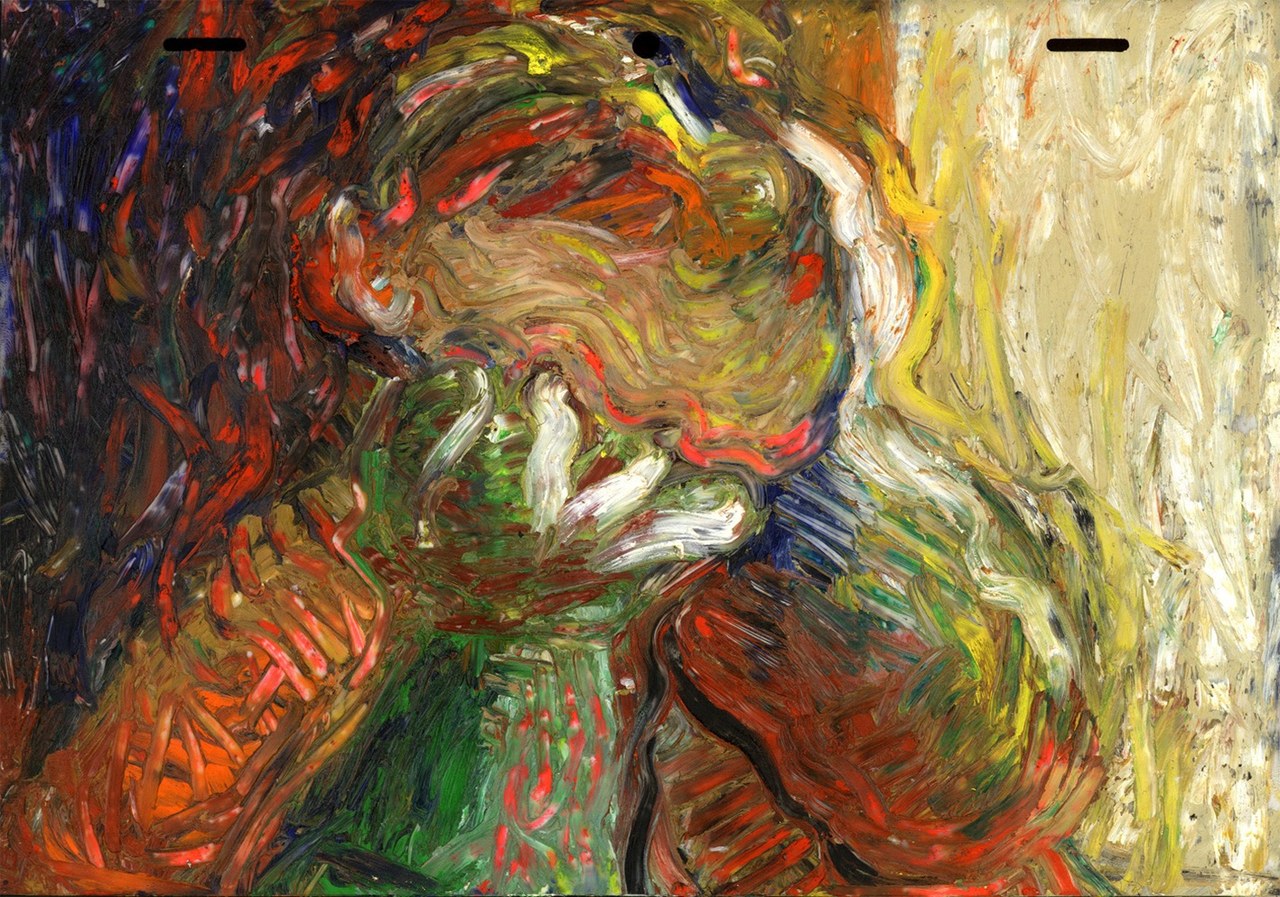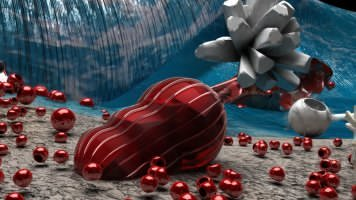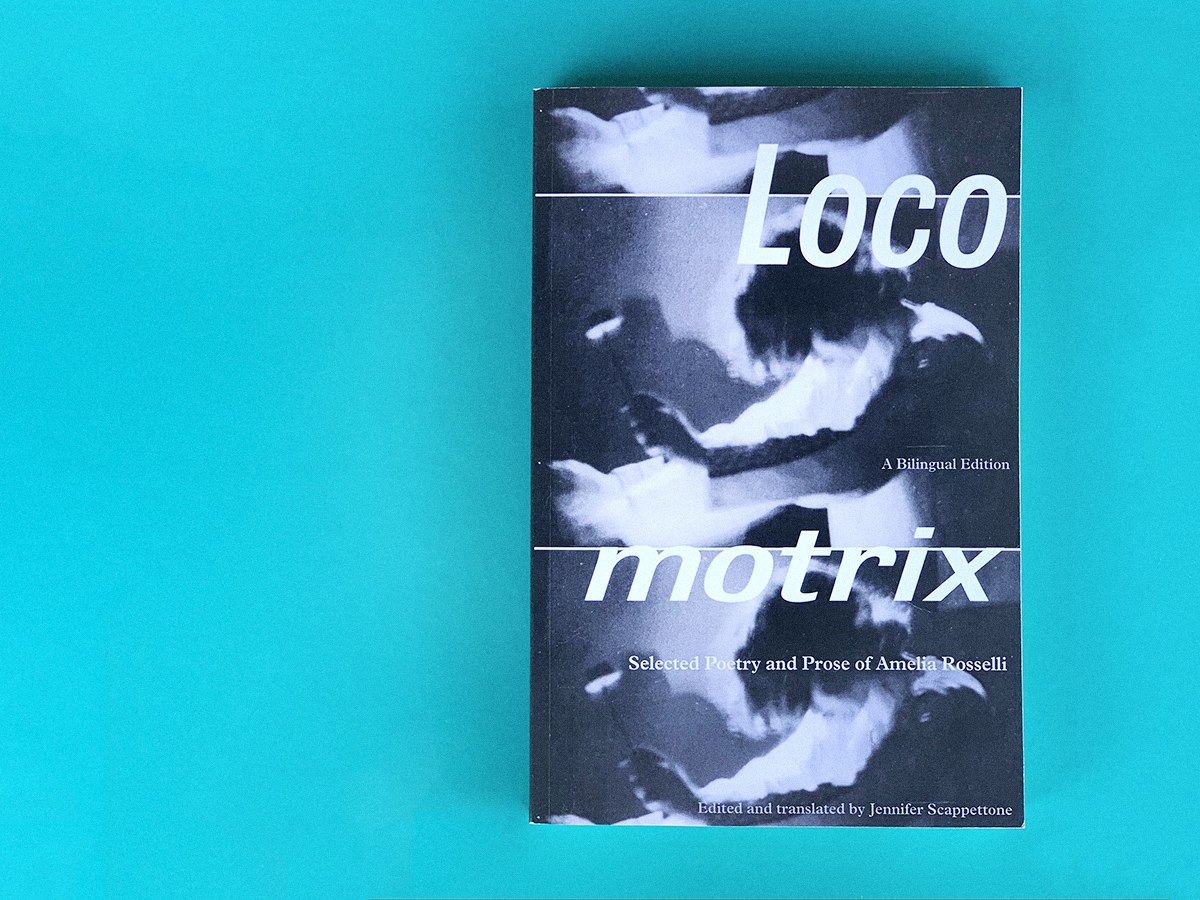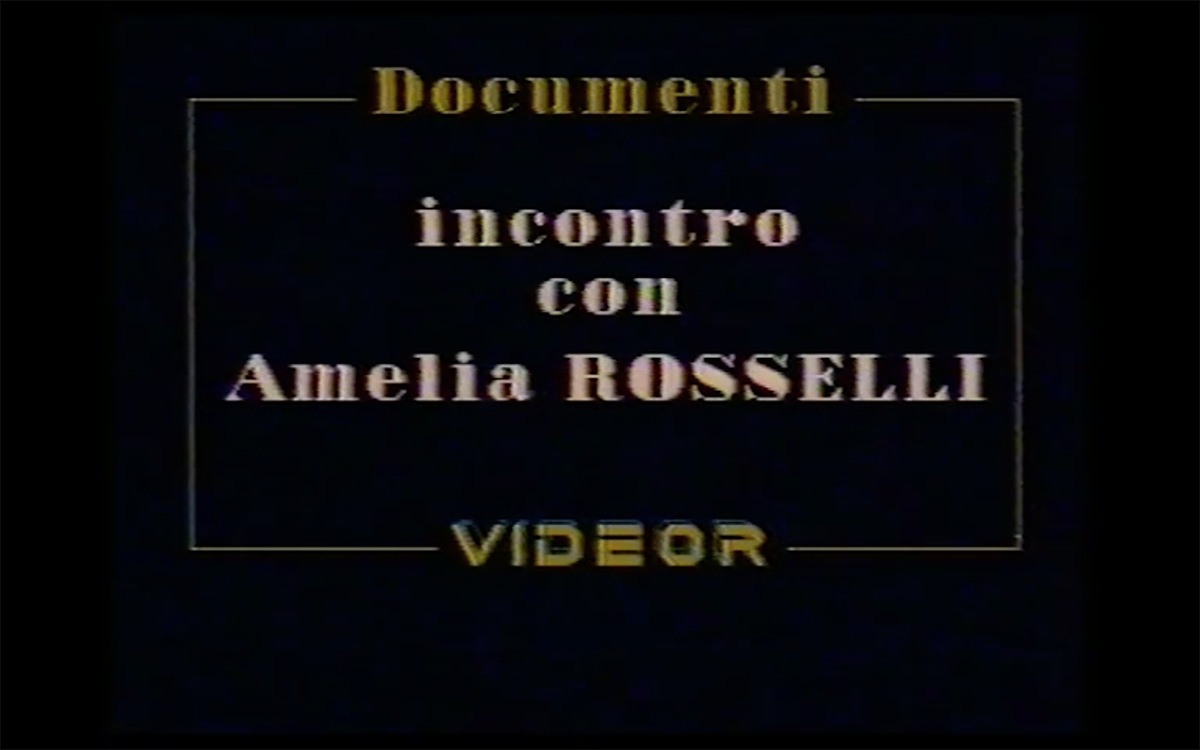Preferisco il cinema.
[…]
Preferisco in amore gli anniversari non tondi,
da festeggiare ogni giorno.
[…]
Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.
W. SzymborskÄ…, Possibilità, 1986
1. Uno sguardo d’insieme
Sono trascorsi, d’un soffio, dieci anni dal primo pionieristico (ma timido) convegno su ‘Cinema e donne’ organizzato all’Università di Sassari: correva l’anno 2011 e il seme di quella rete di relazioni e di studi che oggi chiamiamo FAScinA era stato gettato, con la leggerezza, l’ingenua baldanza e la cura che caratterizzano i moti del desiderio. Da quel primigenio incontro sono scaturiti, negli anni successivi, progetti di ricerca, saggi su riviste e volumi, workshop e giornate di studio disseminate in molti Atenei italiani; e soprattutto da quel lontano confronto ha preso avvio il fitto network di ricerca che tiene insieme numerosissime studiose interessate a indagare il panorama del cinema e degli audiovisivi tenendo conto dei saperi, delle storie, delle soggettività e dei talenti delle donne. Tuttavia, dieci anni fa, a fronte di un contesto internazionale già assiduamente attraversato e vivificato da questo approccio, lo scenario italiano sembrava ancora refrattario: il territorio sul quale ci affacciavamo appariva come una landa vasta, addirittura sterminata, promettente come un Campo Lungo dove via via compaiono le prime incerte figure di una avventura che va prendendo forma. Sentieri selvaggi, appunto.