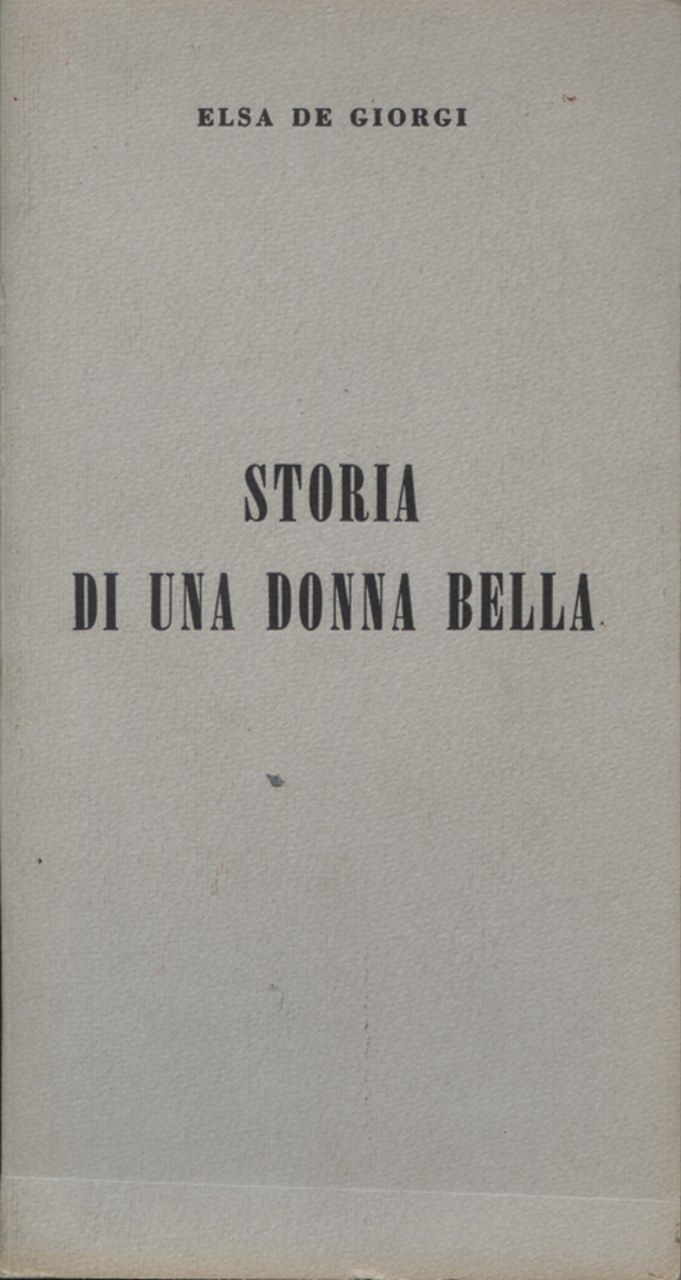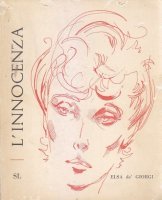Per provare a trovare un punto fermo tra le molteplici scritture che costellano la lunga vita e carriera attoriale di Isa Miranda (1905-1982) si può partire da una traccia. Si tratta della firma con la quale l’attrice milanese verga innumerevoli cartoline, fotografie, ritratti, libri: un ‘marchio’ destinato a sopravvivere alla sua stessa morte, che si ritrova oggi ancora copioso tra i materiali venduti nei mercati di modernariato e le collezioni di memorabilia dei cinefili, forse nel tentativo – a lungo perseguito dall’attrice – di attestare la propria presenza e di promuovere il proprio ricordo. I caratteri alti e regolari, l’inclinazione ascendente, la precisa sottolineatura del nome mantengono una stabilità sorprendente nel tempo: essi si ritrovano immutati nei primi autografi degli anni Trenta fino a quelli dell’età matura e della vecchiaia resistendo all’età, alle mode, ai cambiamenti storici. Nella permanenza di questa cifra espressiva è senza dubbio contenuto il segreto più profondo della personalità di Ines Isabella Sampietro: l’analisi grafologica svela il carattere combattivo e volitivo, l’ambizione, l’egocentrismo, ma anche la solitudine di una donna divenuta nella tarda età amministratrice e vestale del suo stesso mito. La regolarità della calligrafia lascia trasparire l’indole dell’ex segretaria, poi scrupolosa raccoglitrice di articoli e immagini, ordinati cronologicamente e assemblati in album che contengono le attestazioni gloriose del suo passato.