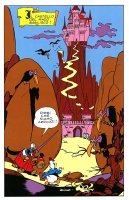Rappresentare artisticamente il perturbante, o per essere più precisi quel sentimento commisto di familiarità ed estraneità che Freud chiama Unheimliche, è una questione che porta a ridefinire la relazione tra la percezione psichico-corporea della realtà e il raggio d’influenza dell’inconscio; e quindi, in ultimo, a (de)strutturare le ragioni dell’immaginario. In questa direzione si muove la ricerca espressiva di Laura Fortin che esplora, per mezzo del disegno, nevrosi e inquietudini di un sentire profondamente contemporaneo. Nello specifico l’artista, la cui poetica denota alcune tangenze con la temperie della dark art, pone al centro delle proprie opere una linea d’ombra tra corpo e mente, tra coscienza sensoriale e interpretazione intellettiva, che non di rado si risolve nella raffigurazione di soggetti difformi dalla norma codificata, che perciò non sarebbe lecito mostrare, e anzi andrebbe rimosso: diciamo pure un eccesso, uno scarto.
Nero residuo, accolto nella raffinata collana d’arte de Le Farfalle (2022), non fa eccezione rispetto a quanto detto finora. Il volume consta di quattordici disegni di Fortin – il cui numero parrebbe richiamare una personale ‘via crucis’ di un corpo-psiche femminile ferito – e da altrettanti testi poetici di Roberto Deidier, interlocutore idealmente «all’altro capo» (come titola l’ultimo libro edito per Lo specchio Mondadori) che raccoglie l’implicita richiesta di dare voce al dolore e al disagio dell’artista. Il lavoro di Deidier si presenta dunque come la traduzione poetico-verbale del perturbante di Fortin, ovvero della cifra stilistica di Nero residuo volta a una rappresentazione-ossessione della corporeità femminile che rinnega le proporzioni naturalistiche poiché la realtà, qui, coincidendo con il corpo-mente di chi disegna, è un luogo di estraneazione e di minaccia.