Non apprezzavo il modo in cui la cinematografia trattava la Calabria, forse mi sbagliavo ma ero fortemente convinto che vi era un forte divario tra le rappresentazioni della realtà e la realtà. Decisi di girare alcuni aspetti del mondo contadino per un problema di giustizia sociale, perché era un mondo di fame e di miseria, perché era il mondo della mia infanzia, ma anche e soprattutto perché era un mondo di incontri poetici (Gallo 1992, p. 150).
Così Mario Gallo, produttore di alcune importanti pellicole del cinema italiano e autore, tra gli altri, di preziosi documentari girati nella sua terra d’origine (il comune di Rovito, in provincia di Cosenza), dichiara a proposito della sua poetica che, come spesso accade, riesce a eludere le intenzioni stesse dei propri autori. Gallo, infatti, parte sì da un intento di denuncia, dal voler raccontare le condizioni di miseria, sfruttamento e disoccupazione della Calabria degli anni Cinquanta-Sessanta, ma poi finisce per sublimare quell’esperienza restituendo della Calabria un’immagine poetica, fatta soprattutto da incontri d’amore.
Partiamo quindi dall’evidenziare, come già rilevato in altra sede (Tucci 2023), che in Mario Gallo il paesaggio non è, come in altri autori a lui contemporanei, funzionale per trattare tematiche come quella del lavoro, molto diffusa negli anni in questione; al contrario Gallo è interessato alle dinamiche ludiche: il tema del gioco (Michelino, 1957; Sabato sera, 1959), della festa (Farsa di Carnevale, 1957; Il mago, 1959), dell’incontro amoroso (Matrimonio segreto, 1958; Dichiarazione d’amore, 1961 e Una storia d’amore, 1965). In questo saggio ci concentreremo proprio su questi tre film, richiamando questioni già trattate ma nel tentativo di fare un passo avanti nella nostra ricerca sull’autore. Per far questo, mostreremo come, nella dinamica dell’incontro amoroso raccontata da Gallo, sia presente sempre una doppia articolazione tra gli interni domestici dove l’incontro amoroso non è dato, è impossibile o interdetto, e il paesaggio esterno, naturale, dove invece esso trova terreno fertile per la propria realizzazione e manifestazione, nel contesto di una prassi che attraversa in vari modi il cinema meridiano (Gaudiosi 2021; Sainati, Federico 2023). Vediamo ad esempio cosa avviene nel primo caso di studio.
























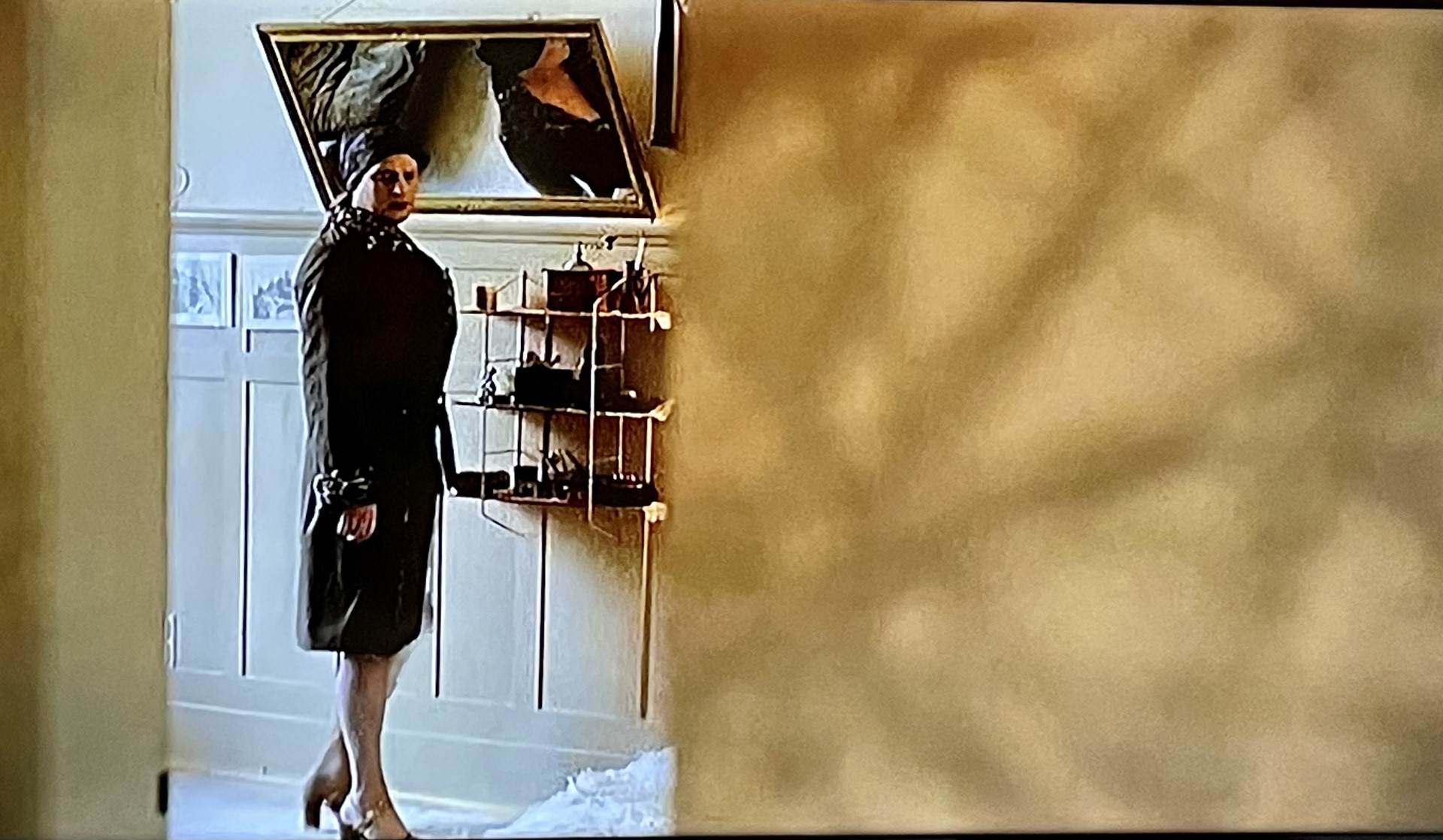





![Fig. 1 – Gli auguri pasquali con una riflessione sul ripetuto ricominciare, Instagram @ambraofficial, 4 aprile 2021, https://www.instagram.com/p/CNPBK3FhCoe/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig1.jpg.pagespeed.ic.WgAicPWfAZ.jpg)
![Fig. 2 – Ambra Angiolini in uno dei suoi scherzosi travestimenti, Instagram @ambraofficial, 13 luglio 2021, https://www.instagram.com/p/CRSAYx7Br95/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig2.jpg.pagespeed.ic.4DFyiz-wnB.jpg)
![Fig. 3 – I fiori regalati per il compleanno, fotografati appoggiati al termosifone, , Instagram @ambraofficial, 23 aprile 2022, https://www.instagram.com/p/Ccsj8RNNhR_/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig3.jpg.pagespeed.ic.l6czIfZ6M_.jpg)
![Fig. 4 – Video amatoriale dalla festa di compleanno, Instagram @ambraofficial, 23 aprile 2022, https://www.instagram.com/p/Ccsj8RNNhR_/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig4.jpg.pagespeed.ic.F8MYrSeuWu.jpg)
![Fig. 5 – Fermo immagine del video-balletto con la figlia Yolanda, Instagram @ambraofficial, 20 marzo 2021, https://www.instagram.com/p/CMpM5vCBtTb/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig5.jpg.pagespeed.ic.v1VsekiyUn.jpg)
![Fig. 6 – Angiolini e la figlia scherzano sul fare le vacanze dalla propria camera da letto durante il lockdown, Instagram @ambraofficial, 11 gennaio 2021, https://www.instagram.com/p/CJ6EbLpBzPg/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig6.jpg.pagespeed.ic.r5WbCrQEIg.jpg)
![Fig. 7 – Selfie di compleanno senza filtri, Instagram @ambraofficial, 22 aprile 2021, https://www.instagram.com/p/CN97qYOhaxg/ [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig7.jpg.pagespeed.ic.g8XYboPby0.jpg)
![Fig. 8 – Foto in posa dal salotto di casa, Instagram @ambraofficial, 22 luglio 2021, https://www.instagram.com/p/CRpBxt4BXbo/. [Screenshot da terzi del profilo Instagram di Ambra Angiolini]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtralli_ambragram_g_fig8.jpg.pagespeed.ic.3ZCagbfOG0.jpg)

















