Tra casa e ‘palazzo’ del governo si dipana una rete di relazioni che attinge al carattere polifunzionale degli edifici nelle loro pratiche d’uso, agli assetti socio-economici e ai regimi simbolici socio-culturali, nella loro mutua interazione. Come ricorda Carlo Tosco nel suo Il castello, la casa, la chiesa (2003), l’architettura è infatti un fenomeno complesso non certamente riducibile al mero aspetto costruttivo. I due riferimenti architettonici configurano dunque campi dinamici di interazioni, più o meno polarizzate, di cui l’edificio costituisce solo una delle componenti. Singolarmente e nella reciproca tensione, risultano particolarmente sensibili in un’ottica di genere, indagata del resto da una consolidata tradizione di studi. Il contributo intende riflettere sulla messa in scena delle spazialità in questione nella rappresentazione di donne ai vertici del governo della res pubblica proposta dall’attuale serialità televisiva e in narrazioni ambientate nel presente. In particolare ci si soffermerà su due prodotti, la serie danese Borgen - Il potere (Borgen, 2010-2022; S. 4, Ep. 38)* e la spagnola Privacy (Intimidad, 2022; S. 1, Ep. 8), entrambe attualmente disponibili in Italia su Netflix. Nella loro dislocazione in un Nord e un Sud dell’Europa sono parse infatti offrire una interessante, e talora inattesa, prospettiva di osservazione.
1. Donne (seriali) al Palazzo del governo
La serialità televisiva è un osservatorio privilegiato per monitoraggi di genere e luogo di promozione di politiche di gender balance, più o meno compiutamente realizzate. Negli ultimi decenni una significativa gamma di proposte è stata incentrata sull’ascesa di donne a ruoli apicali nelle istituzioni pubbliche di governo (Moïsi 2017). Vi si annoverano narrazioni con esplicita matrice biografica ora a valenza documentaristica (tra tutte, il biopic in cinque episodi Thatcher: A Very British Revolution, 2019) ora liberamente ispirate al fascino imperituro di grandi regine e personalità. Di carattere invece finzionale (inteso qui nell’accezione di non direttamente attribuibile a un referente individuale dichiarato), Borgen - Il potere (Borgen, 2010-2022; S. 4, Ep. 38)* e Privacy (Intimidad, 2022; S. 1, Ep. 8) si alimentano di tendenze sociali e cronache contestuali.





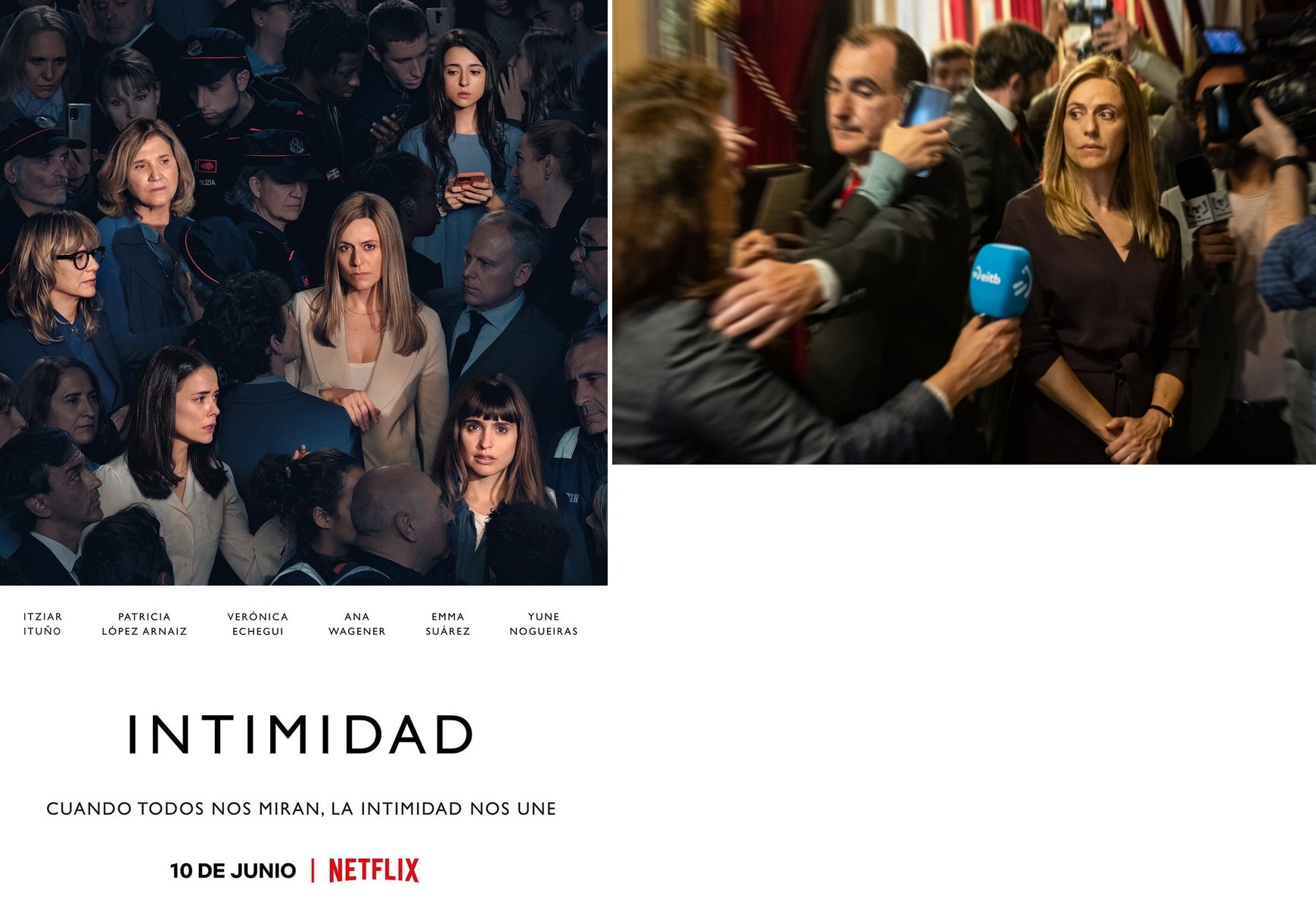



















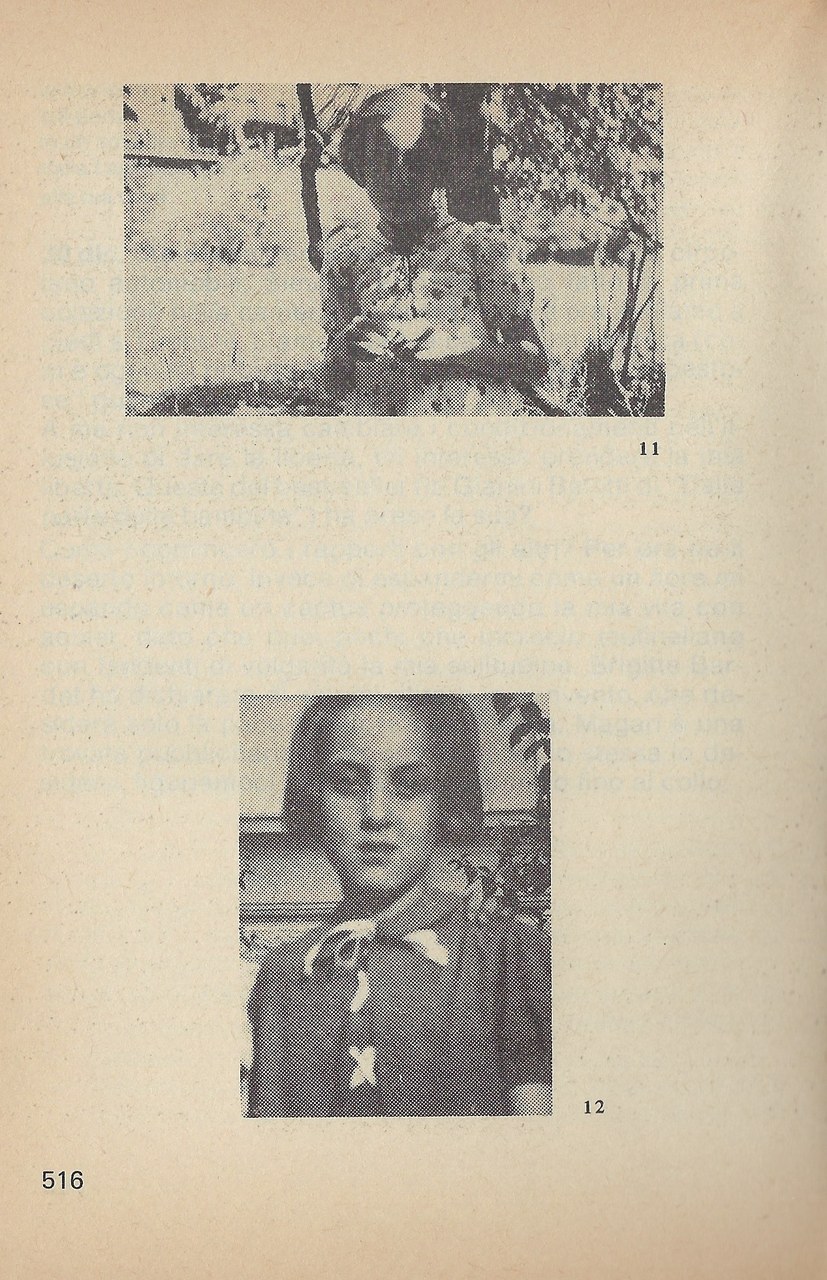
![Fondo Carla Lonzi, s. 1, s.s. 3, u.a. 2, Galleria Nazionale Roma [Accessibile Google Arts & Culture].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.3.jpg.pagespeed.ic.qS9sS22p78.jpg)
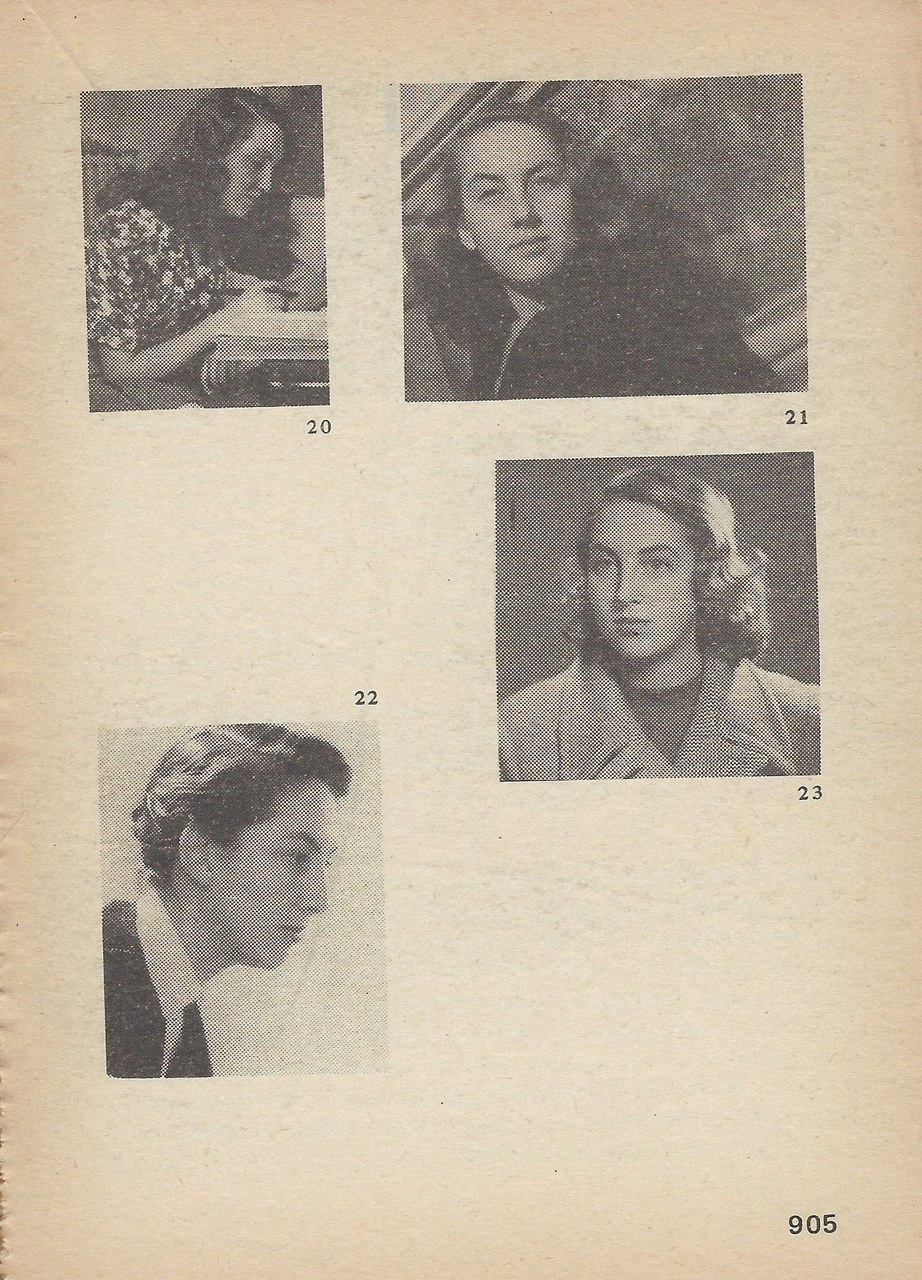
![Fondo Carla Lonzi, s. 1, s.s. 3, u.a. 2, Galleria Nazionale Roma [Accessibile Google Arts & Culture].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.5.jpg.pagespeed.ic.TOEA7Ke6ko.jpg)

![Archivio Pietro Consagra, Milano [L’autrice ringrazia la direttrice Gabriella Di Milia].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.7.jpg.pagespeed.ic.ggd5GLbhXF.jpg)
![Archivio Pietro Consagra, Milano [L’autrice ringrazia la direttrice Gabriella Di Milia].](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xbertelli_g_fig.8.jpg.pagespeed.ic.9zqsUVdqdD.jpg)














![Fig. 1: Isa Miranda in La signora di tutti (M. Ophuls, 1934) [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtognolotti_miranda_g_fig1.jpg.pagespeed.ic.NnCugzeIus.jpg)
![Fig. 2: Isa Miranda, ‘Isa Miranda si racconta’, Film d’oggi, 12, 1946 [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtognolotti_miranda_g_fig2.jpg.pagespeed.ic.Fy3nNg93AC.jpg)
![Fig. 3: Isa Miranda, ‘La casa della melanconia’, Film d’oggi, 12, 1946 [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtognolotti_miranda_g_fig3.jpg.pagespeed.ic.KFsgAQib_H.jpg)
![Fig. 4: copertina di Isa Miranda, La piccinina di Milano, Milano, Gastaldi, 1965 [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtognolotti_miranda_g_fig4.jpg.pagespeed.ic.FJO2khHqUU.jpg)
![Fig. 5: La sala della casa di via Nomentana in una inquadratura di Siamo donne, episodio ‘Isa Miranda’ (L. Zampa, 1953) [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtognolotti_miranda_g_fig5.png.pagespeed.ic.Zqf-8zHfAW.jpg)
![Fig. 6: La casa del bambino povero in una inquadratura di Siamo donne, episodio ‘Isa Miranda’ (L. Zampa, 1953) [Screenshot da terzi dal film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xtognolotti_miranda_g_fig6.jpg.pagespeed.ic.Y8RJzjKcSq.jpg)



