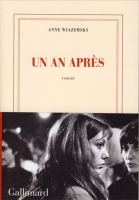La vita non è che un continuo passaggio di esperienze,
da una generazione all’altra: prima imparare e poi insegnare
a chi viene dopo di noi.
Franco Zeffirelli
1. Dai materiali d’archivio al museo intermediale
Messa in movimento, trasmissione e ricezione di un’esperienza molteplice sono i motivi guida espressi dal regista fiorentino Franco Zeffirelli a proposito della raccolta (durante la sua vita) e della destinazione di una serie di materiali legati alla propria attività e all’arte dello spettacolo in toto. Votandosi a questi principi, ha promosso con forza il riconoscimento di quest’insieme patrimoniale come ‘vivente’, non solo per l’azione di conoscenza storica che esercita nel presente verso il futuro ma, si legge tra le righe del suo pensiero, per la capacità di accogliere e far percepire i caratteri stessi della vita e delle arti.
Dal 2015 parte di questi materiali[1] sono gestiti e rimessi in opera a Firenze dalla Fondazione Zeffirelli Onlus, nata in quell’anno proprio con l’obiettivo di «promuovere la cultura e l’arte, attraverso la tutela e la valorizzazione di beni di interesse artistico e storico».[2] Sulla scorta del pensiero dell’artista, l’istituzione ha destinato i propri spazi all’incontro, lo studio e la produzione artistica attraverso il patrimonio zeffirelliano.
Così nella città natale dell’artista, all’interno del Complesso di San Firenze, nel corso del 2015 è stato istituito il CIAS - Centro Internazionale delle Arti dello Spettacolo,[4] che oggi ospita e anima al suo interno un archivio, una biblioteca, un museo, una sala musica da centocinquanta posti che funge anche da spazio di proiezione ed esposizione (nello splendido ex oratorio dei padri filippini caratterizzato da alcuni palchi laterali che ne fanno quasi un teatro), un bookshop, alcune aule dedicate alla didattica (ma tutti gli spazi sono riutilizzati in tal senso), laboratori e un’area ristorativa. In questi spazi si svolgono un insieme di attività formative, artistiche e di progettazione. Le diverse parti, che includono anche la direzione curatoriale, sono pensate come sezioni complementari di uno stesso corpo, sia per gli scambi tra biblioteca, archivio e museo (anche in termini di visite guidate dedicate), sia e soprattutto per gli ulteriori percorsi che fruitori e studiosi possono attivare autonomamente passando da una parte all’altra.[5]