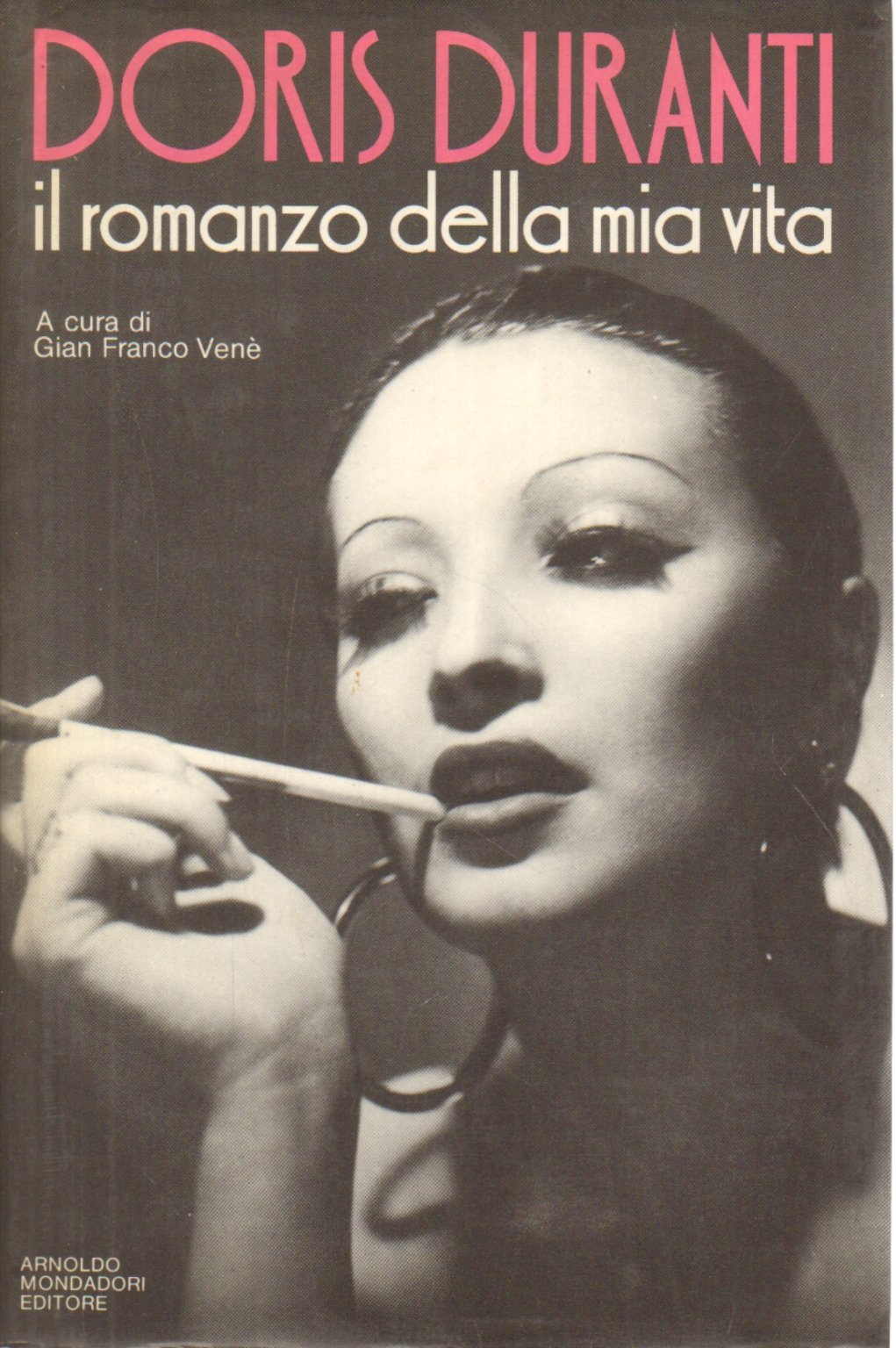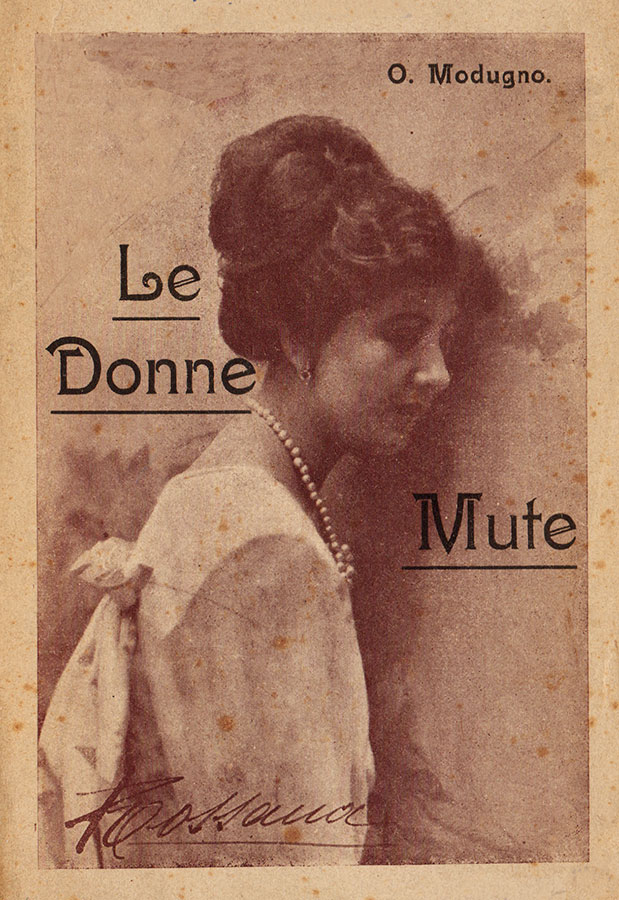Nulla risponde al desiderio umano più del racconto della nostra storia.
Adriana Cavarero
Il vasto ed eterogeneo corpus delle scritture autobiografiche delle attrici italiane, a dispetto della sua natura spiccatamente interdisciplinare, capace cioè di renderlo un oggetto di studio potenzialmente affascinante sia per chi studia cinema (e in particolare il divismo cinematografico) sia per chi studia letteratura, solo recentemente ha suscitato interessi accademici. Mi riferisco, in particolare, al lavoro di Maria Rizzarelli sulle «divagrafie»[1] (termine coniato dalla stessa autrice in riferimento alla produzione letteraria delle attrici italiane) che ha ispirato riflessioni successive.[2]
L’intento di questo saggio è quello di analizzare come caso di studio l’autobiografia di Antonella Lualdi, pubblicata di recente da Manfredi Edizioni,[3] cercando di inquadrare il testo all’incrocio, da un lato, degli studi sulle scritture del sé (in particolare femminili), dall’altro, degli studi sul divismo.
Come si vedrà, l’approccio metodologico offerto da una prospettiva femminista appare come il più adatto a mettere a fuoco tale peculiare tipologia di testi e, nello specifico, il caso di Lualdi. La scrittura autobiografica dell’attrice (inserendosi nella lunga tradizione delle autobiografie delle donne) riesce infatti a rispondere a un forte desiderio di affermazione del sé e, contestualmente, a diventare un valido strumento di autodeterminazione.
1. Sull’autobiografia
Ritengo opportuno, prima di soffermarmi sul caso specifico del testo di Antonella Lualdi, accennare ad alcune caratteristiche della scrittura autobiografica che la rendono un oggetto di studio particolarmente problematico. Si tratta infatti di un genere letterario intrinsecamente ambiguo, i cui caratteri risultano difficili da definire e che tende a sfuggire a qualsiasi tentativo di sistematizzazione.