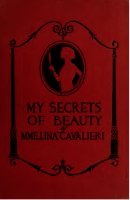«Credo che una delle descrizioni più belle e al tempo stesso più angosciose dell’andare al cinema – voglio dire fisicamente, voglio dire del camminare fra le nebbie, le luci fioche, i radi passanti e le saracinesche abbassate di una cittadina del Nord, per rifugiarsi nel tepore e nel biancore di un cinematografo, dove sembra convergere tutta la vita residua della cittadina, a parte quella che si consuma, misteriosa e prevedibile, dietro le persiane delle case private – si trovi verso la fine degli Occhiali d’oro: parlo del testo, non certo del film» (p. 281). Così scrive Guido Fink all’inizio di un saggio dedicato al complesso rapporto fra Giorgio Bassani e il cinema. Incipit di sfolgorante bellezza formale, il brano aiuta implicitamente a comprendere le due principali ragioni della curatela di Alessandra Calanchi e Paola Cristalli del volume La doppia porta dei sogni, recentemente edito dalla Cineteca di Bologna, che raccoglie ventuno scritti redatti da Fink fra il 1977 e il 2001. Nello specifico, la selezione è stata effettuata sulla poderosa eredità di saggi che la vedova dello studioso, Daniela Sani, ha donato proprio alla Cineteca di Bologna alcuni anni fa.
In primo luogo, come testimonia il passo citato, emerge la volontà delle curatrici di rendere omaggio alla nota capacità di Fink di trasformare la riflessione sul cinema in un dialogo costante con altri universi culturali, a partire da quello letterario, ma senza mai escludere la possibilità di incursioni in terreni tradizionalmente meno battuti. Nelle pagine introduttive, Alessandra Calanchi pone appunto l’attenzione sulla natura fortemente prismatica della scrittura finkiana. Attraverso variegati percorsi – «cinema e letteratura, la screwball e la sophisticated comedy, il film yiddish e gli ebrei nel cinema italiano, il New Deal, il melodramma, il cinema ‘ferrarese’ di Antonioni e di Bassani, l’onirismo, la fantascienza» (p. 11) –, gli interventi scelti in collaborazione con Paola Cristalli restituiscono un mosaico di intrecci che supera i confini fra le diverse discipline. Un mosaico che, come si osserva sempre nell’introduzione, sorprende se consideriamo che che molti di questi scritti risalgono a decenni in cui la fruizione filmica era limitata soltanto al cinema o alla televisione.






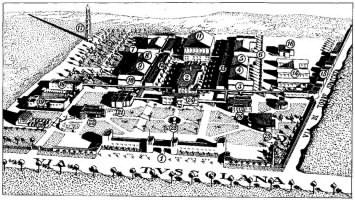









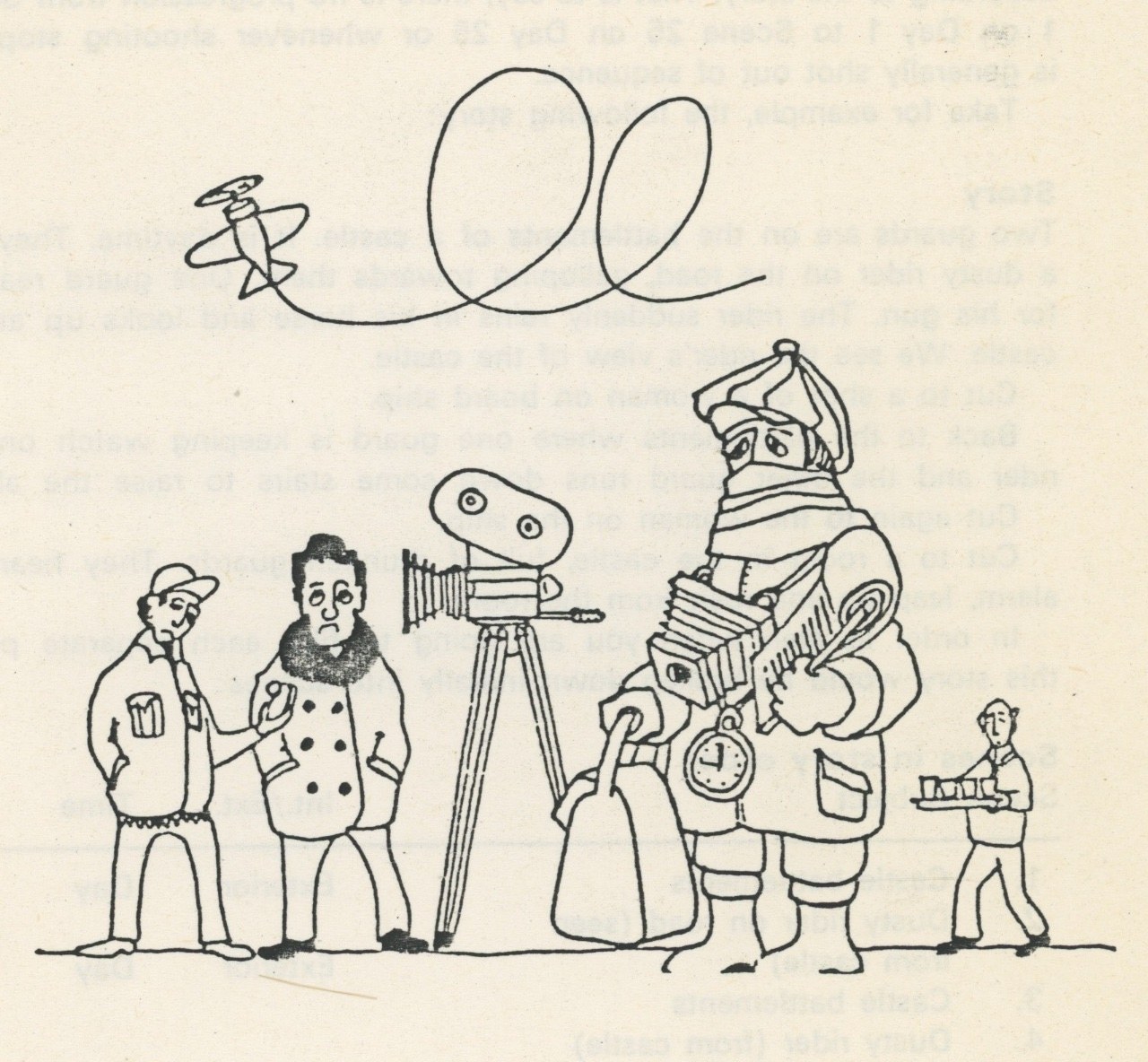





![Fig. 2 Anna Fougez in “Fiore selvaggio” (1921, di Gustavo Serena) [fonte: https://www.ilcinemamuto.it/betatest/omaggio-ad-anna-fougez/]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xmosconi_g_fig2.jpg.pagespeed.ic.s4kvHaCGn7.jpg)