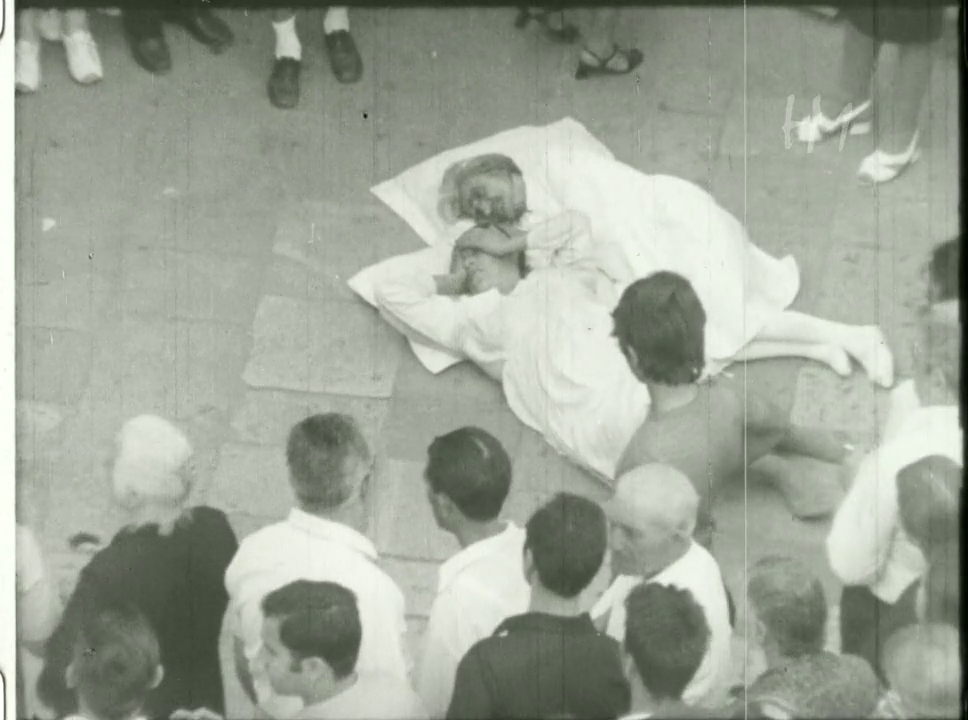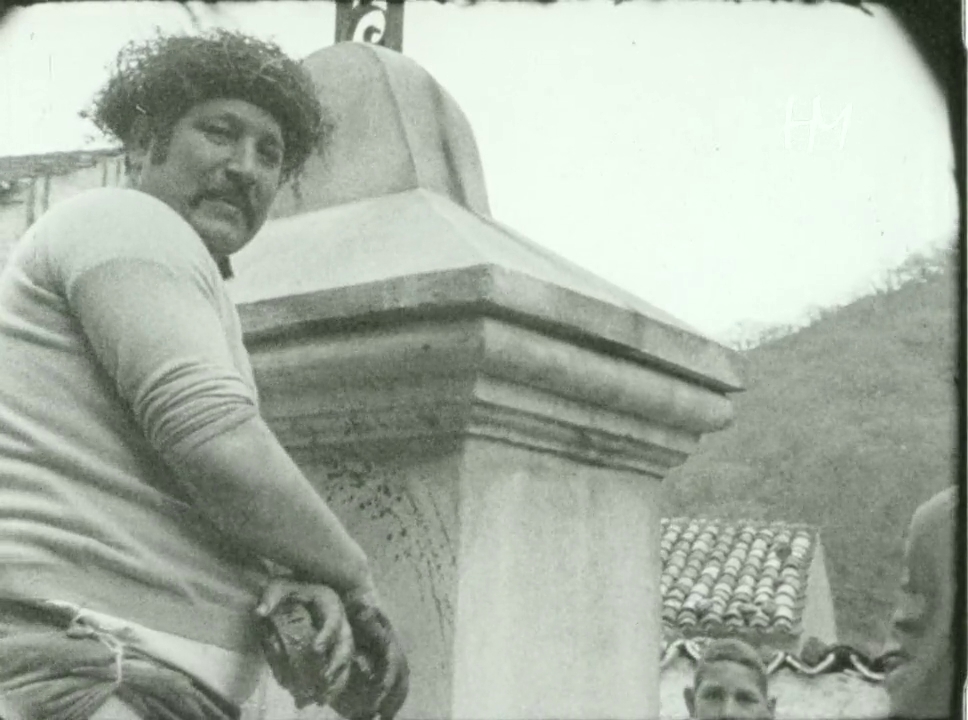Sono vari gli studi che negli ultimi decenni hanno tentato di definire una specificità dei film di famiglia (Aasman 1995; Odin 2001; Simoni 2007; Sangiovanni 2013; Simoni 2013; Cati 2013), nella cornice del tema che ci si prefigge qui di esplorare, ovvero come questo genere filmico possa contribuire a definire un immaginario del Sud Italia. Ci sono tre aspetti preliminari da sottolineare.
I film di famiglia esistono in copia unica realizzati, cioè, con pellicole invertibili che non necessitano la stampa di copie, pertanto si portano dietro un velo di irripetibilità, un’aura, argomento su cui Paolo Caneppele insiste molto nel suo libro Sguardi privati
Il secondo tratto proprio dei film di famiglia è quello della ‘traccia’ che Caneppele prende in prestito ancora una volta dalle parole di Benjamin: «La traccia è l’apparizione di una vicinanza, per quanto possa essere lontano ciò che essa ha lasciato dietro di sé. L’aura è l’apparizione di una lontananza, per quanto possa essere vicino ciò che essa suscita. Nella traccia noi facciamo nostra la cosa; nell’aura essa si impadronisce di noi» (Benjamin 2000, p. 53). Aura e traccia concorrono a far sì che, mentre rivediamo un Home Movies, il passato ritorni presente evocato dal rituale della fruizione: nonostante quell’epoca non ci appartenga più veniamo chiamati a interagirvi. Tra passato e presente si forma un chiasma, un campo di forze attrattive, lo spazio compreso (o compresso) tra due epoche, tra l’allora e l’ora, che torna a sciogliersi e vibrare, rivelandosi. In che rapporto è preso il racconto del Sud Italia in questa tensione tra differenti temporalità? Come con il cinema di famiglia si plasma, si amplia, si spezza? È un confronto pacifico, conflittuale, apre nuovi orizzonti di ricerca?
Terza e ultima considerazione: il cinema di famiglia necessita di testimonianze, il suo muto fluire parla e si amplifica se fitti sono i ricordi e le storie raccontate dalle cineamatrici e dai cineamatori, dalle famiglie, dai parenti. Il cinema di famiglia è un catalogo sterminato di vissuti, è un fattore sociale ma va questionato, verificato, indagato.
Sotto questa luce è lecito ritenere il film di famiglia come un ritratto di un’epoca, di una generazione, come un documento che attesta da un punto di vista altro rispetto al cinema professionale, uno sguardo diverso sulle tracce del passato. Qualcosa di analogo accadde notoriamente in fotografia (Criscenti, D’Autilia 1999; Burke 2002): se i luoghi e gli spazi della vita pubblica si definiscono rispetto agli usi che ne facciamo, consuetudini e comportamenti (come ha notato lo storico Maurizio Ridolfi), essi sono stati in realtà condizionati dai codici di rappresentazione che di quegli spazi trasmettevano i fotografi, «testimoni oculari della vita quotidiana» (Ridolfi 2005, p. 5). Se una storia della società italiana è stata impressa in fotografia, come appare mediata dal cinema amatoriale? Che cosa questo sguardo specifico lascia trasparire di nuovo?
Rivolgiamoci ora a Sud e prendiamo in esame le pellicole a formato ridotto impresse da cineamatori e cineamatrici originari del meridione in un periodo compreso tra il 1948 e il 1968, forbice temporale all’interno della quale si è andato concretizzandosi un lungo studio dedicato alle forme in cui il cinema non di finzione ha raccontato l’identità del Mezzogiorno (Mito, racconto e paesaggio meridiano: verso un archivio del cinema documentario italiano 1948-1968). Coinvolto in un più ampio gruppo di ricerca (insieme a Università di Catania, Napoli, Calabria e Palermo), il mio compito è stato quello di analizzare oltre cento diversi fondi conservati e digitalizzati dalla Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna, da cui poi sono state selezionate ed estrapolate circa cinquecento clip rappresentative di alcune regioni del sud Italia (in particolare Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna). Tali estratti sono ora visibili e indicizzati all’interno del portale Archivi del Sud e dentro la serie Sguardi del Sud all’interno del sito di Home Movies Memoryscapes (Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia s.a.).
La ricerca a Sud sul cinema amatoriale ha evidenziato diverse forme simboliche, parafrasando il pensiero di Ernest Cassirer ([1929-1933] 1961-1966), ovvero modi ricorrenti attraverso cui dare senso e struttura al proprio esserci: a) rituali sociali come viaggi, pranzi in famiglia, escursioni, gite, giochi; b) riti e miti collegati alle feste religiose come processioni e ricorrenze quali la Settimana santa o le feste patronali (Santa Rosalia, San Nicolò, Sant’Agata, San Gennaro, Sant’Antimo) o le visite a santuari e luoghi di culto; c) paesaggi urbani e suburbani delle grandi città del Sud, ripresi dai cineamatori molto spesso prima del loro stravolgimento edilizio o nel pieno della loro vitalità sociale; d) le campagne nei loro rituali autoctoni come il lavoro collegato alla raccolta delle arance, le vendemmie o le saline di Trapani, i dintorni di Napoli e Avellino; e) paesaggi e luoghi ricorrenti come lo stretto di Messina, luoghi simbolo come il teatro di Siracusa e di Taormina, i sassi di Matera, il mercato della Vucciria di Palermo, i parchi naturali, le coste, le spiagge, oppure lo sguardo dei migranti italiani originari del Sud (Ilacqua, Paternostro, La Colla…) che tornano nella loro terra per fissare su pellicola il ricordo delle proprie origini.
Il paesaggio meridiano filmato dal cinema ridotto è un paesaggio in transito dove permangono tratti del mondo agricolo ma come resti, residui: c’è qualcuno che lava i panni a fiume (fondo Renato Longo, Lago di Aceno 1958), le contadine raccolgono il fieno a mano (fondo Giuseppe Natoli nelle campagne del Messinese nel 1960), raccoglitori di tabacco (fondo Enzo Mazzeo, a San Donato nel 1971) quasi nascondono la propria condizione dall’obiettivo del curioso cineamatore [fig. 1].
Il paesaggio agricolo, si intuisce in generale, è oscurato dalla società dei consumi che arriva a deformare e cambiare riti e miti. Le città, i loro centri storici resistono, ignari ancora degli effetti che la globalizzazione e il turismo di massa riserverà loro; i mercati, le piazze, le strade sono vivi scenari (come la Vucciria di Palermo filmata da Nicola Schicci nel 1963). Gli interni, le case, i balconi, i cortili, sembrano ancora quei luoghi che anche il cinema di finzione ha raccontato a Sud, qui si avvicendano giochi e calde giornate estive (il fondo napoletano di Giovanni Alfano), si festeggiano pranzi in famiglia (fondi Damiata, La colla, Acanfora), con una socialità mista e multigenerazionale che riempie la scena, segni di coesione e di una comune identità [fig. 2].
L’urbanistica intanto continua a intaccare le coste, e così la villa a mare (nei fondi calabresi di Paolo Corea e siciliani di Salvatore Stella) diventa un simbolo di affermazione economica. Si costruisce a Sud, il paesaggio si piega al nuovo che avanza, cedendo terreno a una non chiara definizione di moderno. Altre volte il paesaggio è ammirato dal migrante che ritorna, come nella pellicola Ritorno a volte (1971) che il sorrentino Ermanno Acanfora gira dedicandola al suo amico e professore Ottavio Mascoli, che malinconico torna nel paese della sua infanzia a rivedere i suoi ricordi, la sua gente [fig. 3].
Ma è soprattutto nel rituale religioso che il paesaggio meridiano non si lascia piegare, neppure a volte filmare. Accade a Enzo Mazzeo, ventenne napoletano che con la sua Arriflex nel 1971 si trova a documentare il fenomeno delle Tarantate a Galatina (LE). Di fronte alla cappella di San Paolo giungono gli ammalati, la piazza è come un ospedale, tutti assistono ma la camera di Mazzeo non deve filmare il dolore privato di una famiglia, così parenti e amici inveiscono contro la 16mm di Enzo che si nasconde dietro un balcone, schivando un sasso [fig. 4].
Si tratta dello stesso balcone da cui Mingozzi venti anni prima aveva ripreso le stesse immutate scene nel suo cortometraggio del 1962 La Taranta. Il Sud nel rituale si ripete, come nelle riprese che Mazzeo realizza in Calabria durante i riti dei Vattienti di Nocera Terinese (CZ), i quali, per emulare la passione di Cristo, si percuotono le gambe con spazzole di ferro fino a grondare sangue [fig. 5]. Con corone di spine e a piedi scalzi, i vattenti corrono per le strade di Nocera spruzzando sangue sulle case e sugli autoveicoli in segno di buona sorte. Mazzeo era affascinato (scrive e ricorda) «dalle tante creature umane che partecipavano a riti terapeutici o propiziatori», sentendosi parte di un impegno civile condiviso con chi si impegnava in quegli stessi anni in attività simili di ricerca (Ernesto de Martino tra tutti ma anche Amalia Signorelli, Luigi Lombardi Satriani, Ferdinando Scianna, con coeve ricerche fotografiche, alle origini dell’antropologia visiva, di Annabella Rossi e Lello Mazzacane).
Nel filmare il rituale il cinema inedito di Mazzeo, con elevate doti tecniche (intraprenderà una fortunata carriera da ingegnere, costretto dal padre a mollare la cinepresa), nei rulli non montati e digitalizzati da Home Movies testimonia una vivida curiosità per l’essere umano e per il suo lato misterioso, una profonda volontà di comprendere e un rigoroso rispetto per uno spettacolo che non ha nulla di spettacolare ma dove tutto è segno iscritto come sulla pietra, dove l’immagine è rito e il rito si fa immagine simbolica, traccia sensibile impressa sulla filigrana. Così scrive Enzo Mazzeo in un suo testo inedito:
I partecipanti ai riti non si percepiscono nelle mie immagini come figuranti o comparse ma come testimonianze vive di tormentate realtà interiori da comprendere e condividere, segnalando a tutti noi, ancor più nella fissità delle immagini, il loro perentorio diritto ad esistere e a essere compresi travalicando quel solco infinito che sembra volerli tenere lontani (Mazzeo s.a.).
Lo sguardo a Sud del cinema di famiglia è un cinema di testimonianza che del meridione registra i cambiamenti, il paesaggio e il passaggio da un’economia rurale ad una promessa di benessere. Questo immaginario, se interrogato, dialoga e interagisce con il cinema di finzione e non, è il suo libero controcampo: libero dalle dinamiche produttive che spesso soprattutto per il documentario ne imbrigliarono la forma; libero di spaziare come una soggettiva verso storie da rievocare; libero di affermare un suo immaginario di riferimento, rivolto a Sud ma in dialogo con il resto del Paese.
Il database digitale diventa allora il luogo di una memoria che da privata diventa pubblica, memoria ricomposta, dove il singolo avvenimento filmato, gesto, rituale, vive in un sistema, trattato come corpus, in una serie accomunato ad altri fatti e sguardi di altre famiglie, epoche: da atto privato diviene documento tra i documenti e così il navigare al suo interno è come un performare l’archivio e le sue tante storie (Osthoff 2009).
Bibliografia
S. Aasman, ‘Le film de famille comme document historique’ in R. Odin, Le film de famille usage privé, usage public, Paris, Méridiens Klincksieck, 1995, pp. 97-113.
Archivi del Sud, <https://www.archividelsud.com/> [accessed 23 August 2024].
W. Benjamin, ‘I passages di Parigi’, in Id., Opere Complete, Einaudi, Torino 2000, v. 9, pp. 117-135.
P. Burke, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Carocci, Roma 2002. Caneppele, Sguardi privati. Teorie e prassi del cinema amatoriale, Milano, Meltemi, 2022.
E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche [1923-1929], trad. it. di Erald Arnaud, 4 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1961-1966.
A. Cati, Immagini della memoria: Teorie e pratiche del ricordo tra testimonianza, genealogia, documentari, Milano, Mimesis Edizioni, 2013.
L. Criscenti, G. D’Autilia (a cura di) Autobiografia di una nazione. Storia fotografica della società italiana, Roma, Editori Riuniti, 1999.
Fondazione Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia, ‘Memoryscapes’, <https://www.memoryscapes.it/it/serie/28_sguardi-del-sud)> [accessed 23 August 2024].
R. Odin, ‘Il cinema amatoriale’ in G. P. Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale: Teorie, strumenti, memorie, v. 5, Torino, Einaudi, 2001, pp. 319–320.
E. Mazzeo, Gli anni 60 a Napoli, s.l., s.a., pp. 1-7 [testo inedito fornito dall’autore].
S. Osthoff, Performing the Archive: The Transformation of the Archive in Contemporary Art from Repository of Documents to Art Medium, New York, Atropos Press 2009.
M. Ridolfi, ‘Gli spazi della vita pubblica’, in G. De Luna, G. D’Autilia, L. Criscenti (a cura di), L’Italia del Novecento. La società in posa, Torino, Einaudi, 2005, pp. 3-145.
A. Sangiovanni, ‘Memorie private e storia pubblica: film amatoriali, familiari e privati come fonti per la storia’ in F. Serra, Storiografia: XVII, Pisa, Serra Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2013, pp. 265-281.
P. Simoni, ‘Non basta premere un bottone’ in A. Giannarelli, Il film documentario nell'era digitale, v. 9, Roma, Ediesse, 2007, pp. 5-108.
P. Simoni, ‘Archivi filmici privati: la rappresentazione del quotidiano e degli home movies’, Mediascapes journal, n. 2, 2013, pp. 135-145.