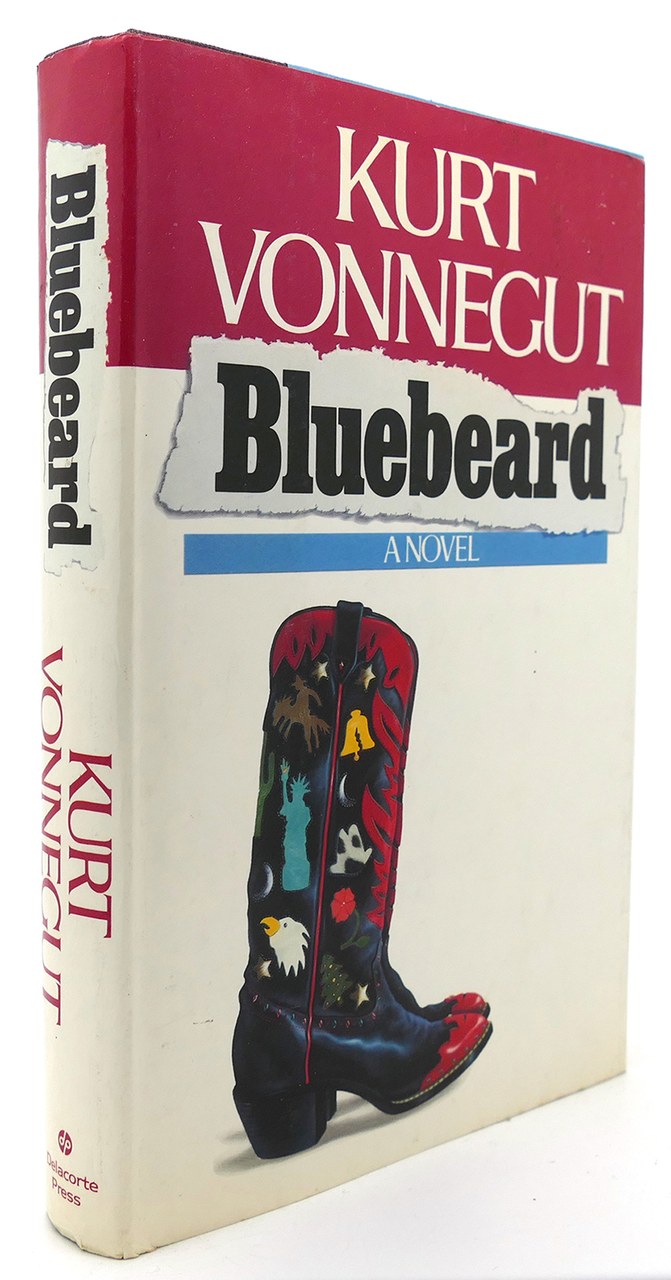Bluebeard è il dodicesimo romanzo di Vonnegut, uno tra gli ultimi (saranno quattordici in tutto). Esce nel 1987 (anche se, nel consueto mondo paradossale in cui abita la fantasia vonnegutiana, racconta la vita di un personaggio che nasce nel 1916 e muore nel 1988) e riceve un’accoglienza tiepida da parte della critica, alla quale sembra ormai esaurita la vena del grande ventennio che intercorre tra Mother Night (1962) e Deadeye Dick (1982), con al centro Slaughetrhouse Five (1969), l’opera che dischiude all’autore americano le porte della fama e del successo [fig. 1]. In questa generale disattenzione sembra che chi si è occupato del romanzo si sia poco curato di metterne in relazione il titolo alla storia (Mustazza 1994, p. 287 segg.), forse dando il collegamento per scontato, e assecondato in questo dallo stesso Vonnegut con le sue dichiarazioni, come ad esempio in una lettera del 20 gennaio 1987 a Peter Reed, in cui afferma di essere sul punto di concludere un nuovo romanzo «su un pittore dell’espressionismo astratto che a settant’anni passati ripensa alla fondazione di quella scuola di radicale non-rappresentazione. S’intitola Barbablù perché il protagonista tiene un dipinto chiuso a chiave che nessuno dovrà guardare finché lui non sarà morto» (Vonnegut 2012, p. 315).
In effetti vi è un macro-livello nella storia in cui il riferimento a Barbablù è esplicito: Rabo Karabekian, il pittore che ne è protagonista, tiene nascosto qualcosa nel suo patataio e vieta l’ingresso in quello spazio di cui custodisce gelosamente la chiave a chiunque, in particolare a Circe Berman, non propriamente sua moglie ma una vedova che Rabo, anziano e vedovo lui stesso, invita a vivere in casa con lui a East Hampton, dopo averla incontrata in spiaggia. A lei che gli chiede per la prima volta e con insistenza che cosa contenga il capannone, Rabo risponde: «Senta, pensi a qualcos’altro, a qualsiasi altra cosa. Io sono Barbablù e quello studio è la mia stanza proibita per quanto la riguarda» (Vonnegut 2007, p. 48).
Il romanzo, di fatto, è l’autobiografia di Rabo che, figlio di profughi armeni sopravvissuti al genocidio in Turchia nel 1915, lascia la città natale in California a sedici anni per diventare apprendista presso un grande illustratore di New York, Dan Gregory. Allontanato da questi, combatte nella Seconda guerra mondiale (topos ricorrente nella narrativa di Vonnegut), diviene compagno di strada degli espressionisti astratti [fig. 2], nonché uno dei maggiori rappresentanti di questa corrente, finché le sue opere, tutte dipinte con gli stessi colori «Sateen Dura-Lux», per un difetto chimico della vernice non si dissolvono, lasciando un cimitero di tele bianche. A questo punto Rabo si ritira, dopo essersi lasciato alle spalle un primo matrimonio ed essersi risposato con una miliardaria, con la quale condivide una delle più grandi collezioni di espressionisti astratti al mondo. La villa a East Hampton è un museo nel quale Rabo, dopo la morte della sua seconda moglie, accoglie i visitatori, cui nega l’accesso solo in quell’unica stanza [fig. 3].
Barbablù e il suo segreto, appunto. Ma in realtà ci sono due Barbablù in questo romanzo, e l’uno è il rovesciamento dell’altro. Uno è Rabo, ovviamente, e l’altro è Dan Gregory, il suo maestro e mentore, che ne rappresenta il negativo, l’opposto. Gregory è un genio del disegno tecnico, dell’illustrazione, e la sua è un’arte senz’anima. Non è un caso che Gregory sia un mostro di insensibilità e crudeltà, ammiri Mussolini e disprezzi le donne:
Nessuna donna, disse lui, poteva riuscire bene nelle arti, o nelle scienze, o in politica o nell’industria, poiché il suo compito, fondamentalmente, era quello di fare figli, incoraggiare gli uomini e accudire alle faccende di casa. Mi invitò a mettere alla prova questa sua affermazione nominandogli, se ci riuscivo, dieci donne che avessero contato qualcosa in alcun campo tranne quello del lavoro domestico. Oggi, credo, ne saprei nominare più di dieci, ma a quel tempo riuscii soltanto a tirar fuori santa Giovanna d’Arco. «Giovanna d’Arco,» disse lui, «era un ermafrodito» (Ivi, p. 120).
Gregory assume dunque l’‘atteggiamento’ di Barbablù, che si concretizza poi nel ‘segno’ di Barbablù: il divieto, la stanza proibita. In questo caso la stanza proibita è rappresentata dal New York Museum of Modern Art, centro di tutto ciò che Gregory aborre nell’arte, ricettacolo di «bava e vomito di pazzi e degenerati e ciarlatani» (ivi, p. 139): se Mussolini prendesse il potere a New York, dice a un certo punto del romanzo, «darebbe fuoco al Museo d’arte moderna e metterebbe fuori legge la parola ‘democrazia’» (ivi, p. 117). Il divieto – che coinvolge tanto Rabo quanto la giovane assistente di Gregory, Marilee, che ne è amante, vittima e schiava – viene trasgredito e naturalmente la trasgressione viene scoperta e punita («Il vostro affettuoso papà vi aveva chiesto una cosa sola come espressione della vostra lealtà: di non mettere mai piede al museo d’arte moderna», ivi, p. 138), con conseguente cacciata di Rabo dal suo paradiso terrestre [fig. 4].
È proprio da questa esperienza – dall’incontro con Barbablù – che Rabo muove fino a diventare il secondo Barbablù del romanzo: un anti-Barbablù, in realtà, che depone la propria corazza – come afferma Monika Szczepaniak, «le storie di Barbablù sono esplicazioni di un corazzamento, segnalano la vulnerabilità come un segreto ben custodito della mascolinità, e smascherano la virilità ‘indossata come una maschera’ come un pericolo per donne, bambini e per gli uomini stessi» (Szczepaniak 2005, p. 301, traduzione mia) – e si apre a una prospettiva più morbida, più inclusiva. Ciò avviene progressivamente, dopo un nuovo confronto con Marilee nell’immediato dopoguerra a Firenze, dove lei si è stabilita dopo avere sposato un nobile locale e averne ereditato titoli e beni alla sua morte, diventando la contessa di Portomaggiore. Non è un incontro romantico, come Rabo si aspetta, ma una profonda lezione morale che smantella ciò che resta in lui del principio di Barbablù. A lui che si vanta delle proprie conquiste, sciorinandole come una bandiera di mascolinità, Marilee risponde:
«Hai detto che durante la guerra ti “scaccolavi pezzi di passera dai capelli”?»
Le dissi che mi dispiaceva di averlo detto, ed era vero.
«Non avevo mai sentito quell’espressione prima d’ora», mi disse. «Ho dovuto tirare a indovinare che cosa significasse».
«Dimentica quello che ho detto», le dissi.
«Sai che ipotesi ho fatto? Ho pensato che, dovunque tu andassi, c’erano donne che avrebbero fatto di tutto per ottenere da te cibo e protezione per se stesse e per i figli e per i vecchi, dal momento che gli uomini validi erano morti o lontani», disse. «Ho indovinato?»
«Oh, mio Dio, mio Dio», dissi.
«Che c’è, Rabo?» fece lei.
«Hai messo il dito nella piaga», dissi.
«Mica tanto difficile indovinarlo», disse lei. «Lo scopo principale della guerra è appunto quello di mettere le donne in questa condizione, dappertutto. È sempre la guerra degli uomini contro le donne, laddove gli uomini fanno solo finta di combattersi fra loro».
(Vonnegut 2007, p. 183).
Nel confronto con Marilee e attraverso di lei, Rabo si rende conto del pericolo che corre il suo nucleo di umanità più profonda – ciò che in Barbablù è scisso e alienato – e lo neutralizza, infrangendo il proprio stigma con un atto simbolico che è rappresentato dal suo ultimo quadro: ciò che è racchiuso nel patataio è ciò che lo rende un Barbablù, ma insieme ne è il superamento, perché Rabo è un Barbablù che apre la porta. E dietro la porta c’è un enorme quadro, un quadro realista, un paesaggio fitto di persone, sullo sfondo della campagna sudetica il giorno della fine della guerra, di fronte al quale Rabo conduce per mano Circe Berman:
Ci trovavamo all’estrema destra di un dipinto alto duecentosettanta centimetri e lungo ventuno metri e mezzo. All’accendersi delle luci, il quadro visto così di scorcio ci sarebbe apparso come un triangolo alto sì due metri e settanta ma largo soltanto un paio di metri. Impossibile dire, da quel punto di vista, cosa vi fosse rappresentato. [...]
«Adesso, mi prenda per mano e chiuda gli occhi. Non li riapra finché non glielo dico io».
Chiuse gli occhi e mi seguì senza opporre resistenza, come un palloncino.
Quando fummo al centro del capannone, con una decina di metri di quadro per parte, le dissi di riaprire gli occhi.
Ci trovavamo sul ciglio di una bellissima vallata verde, in primavera. C’erano, contate una a una, cinquemila duecentodiciannove persone in quella valle. La più grande di esse aveva le dimensioni di una sigaretta, la più piccola di una cacatina di mosca. C’erano case coloniche, sparse qua e là, e le rovine di una torre di guardia medioevale, sul ciglio della valle, dove noi ci trovavamo. Il quadro era talmente realistico che avrebbe potuto essere una fotografia.
«Dove siamo?» domandò Circe Berman.
«Siamo dov’ero io», le dissi, «quando sorse il sole il giorno in cui finì la Seconda guerra mondiale in Europa».
(Ivi, pp. 223-224).
Il giorno della liberazione, un giorno simbolico che segna la fine della logica maschile di Barbablù, almeno in potenza, e un quadro che riprende la tecnica di realismo assoluto del Barbablù ‘negativo’, di Dan Gregory, liberandola delle sue scorie e mettendola al servizio di un senso di armonia e di speranza. Il quadro definitivo di Rabo Karabekian, che porta un titolo significativo: Now It’s the Women’s Turn (Ora è il turno delle donne). Non di essere Barbablù, ma di essere protagoniste [fig. 5].
Bibliografia
L. Mustazza (ed.), The Critical Response to Kurt Vonnegut, London, Greenwood Press, 1994.
M. Szczepaniak, Männer in Blau. Blaubart-Bilder in der deutschsprachigen Literatur, Köln / Weimar / Wien, Böhlau, 2005.
K. Vonnegut, Barbablù, trad. it. di P. F. Paolini, Milano, Feltrinelli, 2007.
K. Vonnegut, Letters, ed. by D. Wakefield, New York, Delacorte, 2012.