Il proposito di questo libro è di iniziare nel mezzo
nel groviglio tra passato e presente; e accettare la complessità che tale decisione comporta
in ogni analisi della moderna cultura dei media.
Jussi Parikka

A sette anni dall’edizione inglese arriva in Italia, grazie alla traduzione di Enrico Campo e Simone Dotto, il volume Media Archeology del teorico finlandese Jussi Parikka, che, insieme a Media Archeology: Approaches, Applications, and Implications pubblicato nel 2011 con Erkki Huhtamo, prova a sintetizzare il retroterra, le costanti tematiche e i nuovi metodi che da questa area di ricerca emergono.
Il volume costituisce un utile avviamento agli studi media-archeologici che, come spiega l’autore nell’introduzione, analizzano la dimensione ‘materiale’ dei media riletta, seguendo Kittler, dal punto di vista tecnologico ed empirico. Sembrerebbe un ritorno al determinismo, ma, come mostra anche la prefazione di Ruggero Eugeni, i capitoli propongono da diversi punti di vista un riesame dei media nell’accezione ampia e meno visibile di ‘dispositivi’: termine che ricorre nel libro indicando i media come device, cioè apparecchi fisici, ‘artefatti’, costruzioni prodotte da un intreccio di saperi e poteri che mutano nello spazio e nel tempo, ‘apparati’, che plasmano il nostro modo di sentire e pensare, e ‘situazioni’ cioè atti, momenti di interazione comunicativa (pp. 18-20). L’oggetto di studio media-archeologico, scrive Parikka, non è rappresentato solo dalle ‘cose’ ma anche dai discorsi, dalle pratiche e dalle rappresentazioni che rivelano i modi con cui elaboriamo i nostri «sistemi mediali» sotto forma di «relazioni sociali» e «reti di comunicazione» (p. 100). Di qui il sottotitolo della traduzione italiana.
Ma in che modo? Il metodo media-archeologico, presentato nella parte introduttiva da Parikka, sostiene una prospettiva transdisciplinare (storica, sociale, politica ed estetica) collegata a un’indagine tecnologica e computazionale. L’uso del termine ‘archeologia’, ripreso da Foucault, richiama infatti metaforicamente un lavoro che vada oltre la superficie delle cose ed esplori le componenti più profonde a livello strutturale, ecosistemico e temporale rispetto sia alla durata dei processi che alle stratificazioni tra passato, presente e futuro.
Il lavoro dell’archeologia dei media procede in questa direzione, come ricorda lo studioso nel primo capitolo, lungo tutto il suo sviluppo, avvenuto negli ultimi decenni grazie alle acquisizioni della ricerca scientifica sulle immagini e soprattutto della new film history che, già dalla fine dell’Ottocento, ci hanno permesso di scoprire l’incidenza dei media dal punto di vista fisico, percettivo e dinamico. Sullo sfondo di questa formazione la media archeology rimarca la necessità di adottare un approccio intermediale per continuare a riflettere sull’azione – a vari livelli: multisensoriale, affettivo e persino precognitivo – che i media esercitano sulle persone e sulla diversa conformazione del tempo che essi attivano nei più vari ambiti socio-culturali e politico-economici del nostro presente.
Assumere questa nuova ottica, prosegue l’autore nel secondo capitolo, problematizza il nostro rapporto con i media, il modo di vedere ciò che è ‘vecchio’ o ‘nuovo’, soprattutto nella cultura digitale e ci consente di recuperare in una sorta di «what if» (p. 84) o di «archivi dell’impossibile» (p. 82) idee e realizzazioni alternative rispetto alle forme istituzionalizzate. Si può parlare dunque, come si legge nel terzo capitolo, di un «nuovo materialismo» (p. 107) che raccoglie, analizza e descrive ciò che sta alla base delle entità mediali, senza trascurare al tempo stesso quegli aspetti fisici e tecnici che, anche se non rilevati dalla percezione umana, ne veicolano o condizionano il funzionamento.
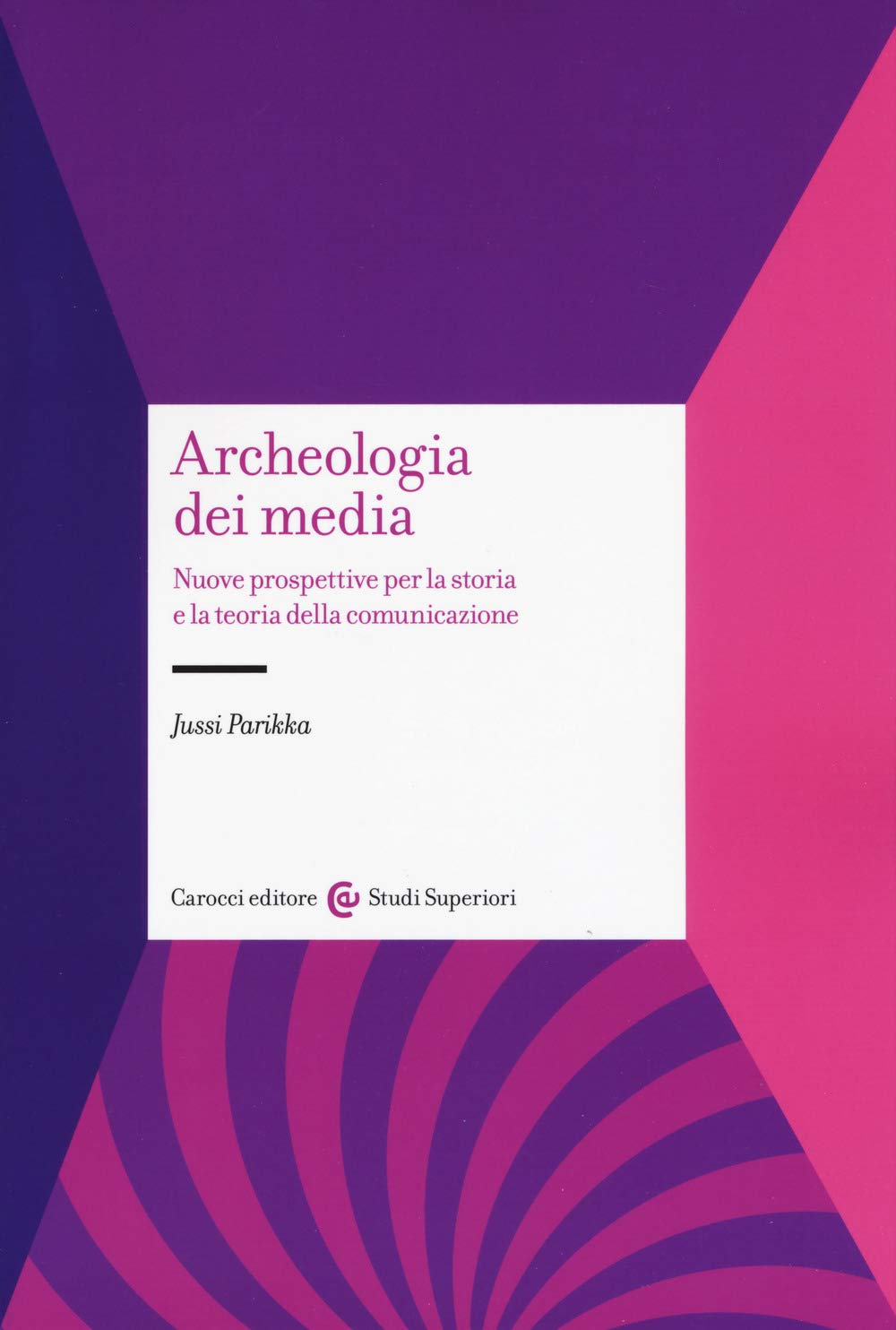
In sintesi, nelle parole di Parikka, l’archeologia dei media ci invita alla ricerca del modo specifico con cui avviene ogni trasmissione nel senso di «transmittere» (p. 153), puntando cioè l’attenzione sul ‘tra’, su tutto ciò che organizza il nostro modo di produrre, conservare ed elaborare le informazioni. Ma la novità, esposta da Parikka nella parte centrale del volume, sta nel porre attenzione a quei tratti coinvolti nel processo ancor prima o indipendentemente dal senso, di cui siamo più o meno consapevoli o partecipi: per esempio gli hardware, i canali, i segnali, i fenomeni di disturbo come il ‘rumore’ o le interruzioni, i linguaggi automatici, i codici di programmazione e gli standard.
Per questo tipo di mappatura come per l’idea di ‘media’ si rivela utile, suggerisce l’autore, rivedere alcune categorie del passato innovandole se necessario. Alcune di queste sono state messe in crisi, com’è accaduto per l’idea di testo, autore, genere (p. 56). Altre, come movimento, sguardo, immersività, virtuale fungono invece da tramite per rileggere analogie e differenze col passato (pp. 60-62). È soprattutto la nozione di archivio, tuttavia, esaminata nel quinto capitolo, ad aver assunto dai primi del Novecento a oggi una inedita centralità nel passaggio dall’individuazione delle sue regole costitutive, come centro di documentazione, all’appropriazione rigenerativa come esperienza quotidiana, condivisa anche dalle arti e dalle istituzioni culturali. L’archiviazione è oggi espressione di una raccolta di ‘oggetti’ che assumono senso solo nella messa in relazione e nella riattivazione partecipata, soprattutto quando sono testimonianza di processi più immateriali, che possono superare anche la sensibilità e le capacità umane come nel caso dei software e dei database digitali.
Ecco perché l’obiettivo della media archeology, come ricorda Parikka a più riprese, non è solo la riarticolazione delle conoscenze che riguardano il campo dei media studies, ma anche il ripensamento trasversale dei legami, degli interrogativi e delle abilità critiche verso i media che possono trovare un riscontro comune tanto nella ricerca accademica quanto nella pratica collettiva, istituzionale e artistica.
E a tal proposito le arti, tra cui Parikka considera anche la letteratura, e in particolare la media art hanno chiaramente di per sé una capacità di azione mediale, produttiva e relazionale, ma per le tracce che conservano e le capacità metariflessive che possiedono sono anche uno strumento di analisi speculare oltre che di rielaborazione dell’esperienza. Su questo fronte la novità più interessante, approfondita nell’ultimo capitolo, è il racconto delle osmosi dialettiche soprattutto in campo media-archeologico tra gli studi, le istituzioni culturali e le creazioni artistiche che lavorano a una ricerca-azione comune, definita come «thinkering» (p. 223), e/o alla formazione sperimentale di «laboratori concettuali» (p. 44) aperti a un coinvolgimento ampio, consapevole e sostenibile intorno alla cultura mediale.
Per concludere, uno dei punti critici dell’archeologia dei media nella presentazione dell’autore sembra però la costante e ambigua esplicitazione del disinteresse per l’analisi del rapporto con il contenuto delle rappresentazioni veicolate dai media. Di certo, è un modo per riattivare l’attenzione verso le componenti materiali, trascurate soprattutto dalla virtualizzazione del digitale e dalla mancanza di un confronto conoscitivo tra il campo tecnologico e quello umanistico; ma è anche l’attuale limite, più che il confine teorico dell’archeologia dei media che bisogna affrontare, come nota Simone Venturini nella postfazione, per le ricadute che gli aspetti presi in considerazione hanno sul senso e sul valore assunto dalla produzione, dalla trasmissione e dal riuso degli oggetti culturali.
Del resto, come scrive lo stesso Parikka, i due aspetti forse non possono andare in parallelo solo ipoteticamente, ma trovano già concreta attuazione in alcuni ‘laboratori’ che
promuovono un’idea di archeologia dei media come disciplina che può educare all’uso dei media e della tecnologia: essa può formare non solo consumatori dotati di strumenti critici e dunque capaci di interpretare ermeneuticamente i complessi contenuti mediali, ma anche produttori in grado di impegnarsi attivamente in diverse pratiche mediali (p. 222).