È ben conosciuta l’interpretazione psicanalitica della violenza negli anni di piombo, secondo cui lo Stato si identifica con una figura paterna da rinnegare. In questa rappresentazione degli anni Settanta, l’eliminazione fisica di importanti personalità istituzionali rimanda ad un’analogia non solo con il rifiuto dell’autorità del padre, ma con tutto il sistema gerarchico che veniva messo in discussione dal clima di contestazione e, successivamente, dalla lotta armata. Come ha scritto Raffaele Donnarumma, «è con l’omicidio di Aldo Moro che lo schema del parricidio viene promosso a mito tragico sotto il quale mettere un’intera epoca della storia repubblicana»,[1] considerazione che lo stesso Donnarumma invita a rileggere non solo in relazione alla figura di un padre oppressivo, ma anche a quella di un’autorità evanescente. La controversa ricostruzione storica degli anni del terrorismo ha anche generato, in narrativa, significative aperture al modo fantastico. Per esempio, il ritorno spettrale di un passato con cui non si sono chiusi i conti e l’ingiusto oblio caduto su alcune vittime si manifestano spesso, nel genere romanzo, attraverso la caratterizzazione di un fantasma. In particolare gli studi di Federica Colleoni hanno fatto emergere una chiara relazione fra aspetti perturbanti e finalità sociali in alcuni romanzi sugli anni di piombo pubblicati negli anni Zero, e la figura dello spettro è stata studiata nelle declinazioni narrative di chi riappare allo scopo di dar voce a problematiche mai affrontate fino in fondo.[2] Metterò al centro di questo saggio una tendenza che, pur rifacendosi ad alcuni degli schemi sopraelencati, si distingue in modo originale, in anni ancora più recenti, nella produzione di romanzieri importanti: l’intersezione tra fotografia, violenza politica, elementi fantastici e storia degli istituti psichiatrici prima della legge Basaglia.
I romanzi qui presi ad esempio sono La prima verità (2016) di Simona Vinci e Quello che l’acqua nasconde (2017) di Alessandro Perissinotto, due storie che, ambientate rispettivamente in Grecia e in Italia, prendono spunto da prospettive storiche nazionali per abbracciare considerazioni sul rispetto dei diritti umani nel mondo occidentale. I due romanzi sono assimilabili particolarmente per l’intrusione dell’elemento perturbante in storie altrimenti realistiche, il paragone (talvolta spinto fino all’opposizione) fra scienze tecniche ed umanistiche, e la centralità delle arti visive – soprattutto la fotografia – nella rappresentazione dell’alterità sociale.
Questo saggio procederà in due fasi, discutendo prima l’utilizzo del modo fantastico e della fotografia messo in atto da Vinci e Perissinotto, per poi trovare una sintesi e suggerire una lettura comparatistica di due approcci che, seppur simili, denotano importanti singolarità stilistico-interpretative. Dal punto di vista metodologico, il saggio esplora il territorio di quelle narrazioni che, pur basate su fondamenta realistiche, non escludono elementi perturbanti, perché la verosimiglianza di questi ultimi non può essere negata categoricamente. Ci troviamo, dunque, dinanzi a rappresentazioni artistiche che, suggeriva Roger Caillois, «inseguendo il reale, incontrano il fantastico».[3] Dal punto di vista delle implicazioni sulla caratterizzazione nel romanzo, siamo invece al cospetto della costruzione del fotografo come personaggio, figura che Remo Ceserani interpretava come portatrice di qualità magnetiche e sconcertanti,[4] e di cui Silvia Albertazzi ha rimarcato la capacità di esprimere «una esigenza umana, la condivisione del veduto».[5]
1. La prima verità
Il romanzo di Simona Vinci è ambientato nell’isola greca di Leros, nelle strutture contigue che servivano da istituto psichiatrico e penitenziario per i dissidenti politici durante la dittatura dei colonnelli. La narrazione si distingue per la cospicua presenza di riferimenti al modo fantastico e ambientazioni che richiamano la tradizione del romanzo gotico, con la figura dello spettro ad indicare l’irruzione del passato nella vita di Angela, studentessa che si reca a Leros come volontaria nel 1992, quando lo scandalo sulle condizioni dei malati ne ha già prefigurato il ridimensionamento.

Figure di demoni, fantasmi e morti che ritornano si accompagnano agli accorgimenti tipici del gotico, come la scoperta di passaggi sotterranei ed il rinvenimento di vecchi documenti che servono da mezzi di comunicazione fra passato e presente. Il meccanismo del romanzo utilizza l’arte fotografica come collante per tutti questi riferimenti a metà strada fra gotico e fantastico: tale funzione è introdotta già nell’incipit, si ripropone nella caratterizzazione di Angela, e ritorna nella discussione finale sulla denuncia delle atroci condizioni dell’istituto, incorporando così tutta la durata della narrazione. La fotografia emerge, dunque, come un ponte fra dimensioni differenti, perché collega la parte finzionale del romanzo (gli eventi di cui Angela è protagonista) con la documentazione storica che sta dietro la scrittura (la vicenda reale della fotografa Antonella Pizzamiglio, i cui scatti ricoprirono un ruolo importante per la presa di coscienza su ciò che accadde a Leros). L’arte fotografica introduce ulteriori parallelismi fra Grecia e Italia, perché anche l’opinione pubblica italiana iniziò a porsi domande sui manicomi tramite le immagini riguardanti i bambini confinati negli istituti di Giorgio Coda, episodio con cui Vinci apre il romanzo. Persino le scelte onomastiche partecipano alla rappresentazione della liminalità fotografica: il personaggio che incarna la passione per la visualità, Angela, porta nella radice greca del suo nome la connotazione di messaggero, di tramite fra due mondi, qualità che le permette di diventare portavoce di chi, rinchiuso in manicomio, non può esprimere il proprio disagio.[6]
La relazione fra fotografia realistica e dimensione fantastica è proposta immediatamente, con il ricordo delle immagini che, scattate da Mauro Vallinotto e pubblicate da «L’Espresso» nel 1970, amplificarono la discussione non solo sui manicomi, ma anche sull’interpretazione classista della professione medica e sulle responsabilità del mondo esterno agli istituti psichiatrici. Lo scatto più famoso e che è stato spesso interpretato, in chiave mistica, come una sorta di crocifissione infantile, è invece introdotto con riferimenti demoniaci nell’incipit de La prima verità:
Un lettino di ferro con le sbarre bianche e un corpo nudo, quello di una bambina tra i sette e i dieci anni. Che è una femmina, si capisce solo dal taglio tra le gambe unite e tenute ferme da una cinghia di contenzione. Anche le braccia sono legate alle sponde con due strisce di tela e tutto il peso del corpo si regge sui gomiti. […] La fotografia è in bianco e nero e non so se è questo a rendere tanto drammatica l’oscurità che sembra avanzare e gonfiarsi a inghiottire tutto come un vortice d’aria nera. Uno spazio infinito si estende da lì all’eternità e dentro quello spazio sono sicura che ci siano tutti i demoni del mondo. Non saprò mai il nome di quella bambina. Non saprò mai la sua data di nascita, né quella di morte. [...] Li ha zittiti, i demoni, o sono stati i demoni a zittire lei?[7]
La fotografia è dunque usata come uno strumento narrativo, tramite cui il genere romanzo unisce finalità sociali e accorgimenti stilistici che aprono all’altro grande tema affrontato da Vinci, la comunicazione fra l’approccio realistico e quello fantastico. È bene ricordare che l’accostamento letterario fra arte visiva e modo fantastico non è inusuale. Già la tradizione del romanzo gotico proponeva costanti riferimenti all’effetto perturbante della percezione ottica e della sua manipolazione: si pensi ai dipinti che si animano (Il castello di Otranto di Walpole), l’ossessione dimostrata verso gli occhi (L’uomo della sabbia di Hoffmann), o la presenza di specchi che generano inganni e crisi identitarie, tema che sarebbe poi sfociato nel Novecento italiano negli esempi di Mattia Pascal e, più tardi, della biblioteca ne Il nome della rosa. Anche attraverso l’arte visiva, La prima verità introduce degli individui percepiti interamente in funzione della malattia, come se la loro personalità non potesse esprimersi al di fuori di essa. Similmente alle vittime della violenza politica (come il personaggio di Stefanos), la caratterizzazione spettrale e mostruosa dei malati ne raffigura efficacemente l’impossibilità di esternare la propria personalità senza l’aiuto di Angela. La prima verità si propone, quindi, come «una storia di fantasmi»[8] e di morti che ritornano dal passato per stabilire una relazione con i vivi.

Particolarmente questa funzione dell’elemento perturbante si presta a collegare ambientazioni temporali lontane, in un romanzo in cui continue analessi e prolessi spostano l’azione dagli anni Trenta (la formazione adolescenziale del personaggio di Basil) agli anni Sessanta (la detenzione di malati e dissidenti politici a Leros), agli anni Novanta (la spedizione dei volontari che iniziano a riorganizzare ciò che diverrà dell’istituto) fino al 2016, anno di pubblicazione in cui la narratrice, non più personaggio finzionale e più vicina ad una voce autobiografica, rilegge gli eventi passati alla luce delle nuove sfide sociali del terrorismo e dei flussi migratori. Il collegamento fra arti visive e fascinazione per l’irrealistico avviene con l’introduzione di Basil, convinto di acquisire capacità soprannaturali venerando l’icona di San Basilio. La malattia mentale del personaggio è rappresentata a metà strada fra impeto religioso e apertura ad un mondo irrazionale, legato più alla superstizione che alla fede. Un esempio su tutti è la convinzione che il padre, anziché malato, sia infestato da un demonio, una presenza che Basil vuole allontanare con la propria purezza, procedimento al quale la venerazione dell’icona partecipa insieme al tentativo di entrare in seminario. Il collegamento fra arte visiva e riduzione del fantastico a ciò che Todorov chiamava non meraviglioso ma ‘strano’[9] (in quanto logicamente spiegato dalle turbe psichiche di Basil) apre la strada all’intenzione più prettamente sociale della vicenda. Basil paga, oltre ai problemi mentali, la bassa condizione sociale della propria famiglia, caduta in miseria dopo la morte del padre, medico che ne aveva invece garantito la reputazione borghese. Inizia a farsi spazio una delle tematiche che distinguono il romanzo ambientato nei manicomi, attraverso un’interpretazione ‘democratica’ della fotografia e delle arti visive volte a denunciare un meccanismo discriminatorio sistematico e ricorrente: la condizione medica conta tanto quanto la classe sociale, fattore che accomuna l’ambientazione greca a quella italiana. L’intersezione fra visualità e dimensione fantastica caratterizza ancor più Angela, il personaggio principale, ed anche in questo caso il connubio finisce per rimarcare la finalità sociale del romanzo. La protagonista è introdotta come una fotografa che ha ereditato la passione del padre:
Le diceva che avrebbe dovuto fotografare molto il cielo perché il cielo è difficile da fotografare bene e da lì si capisce se uno ha occhio. Poi era morto, senza aver mai avuto il piacere di contemplare la foto di un cielo fatta da sua figlia, perché sua figlia, lei, fotografava facciate di palazzi, ponti, alberi, strade, qualche volta persone, ma il cielo lo tagliava sempre via dall’inquadratura, perché aveva paura di non capirlo e di dimostrare la sua totale mancanza di occhio.[10]
La vocazione artistica di Angela si instaura in contrapposizione al cinismo di una scienza che, incarnata dai medici, si limita a contenere con la forza i pazienti, senza proporre una terapia mirata e senza indicare una via d’uscita dalla malattia mentale. Data l’oggettiva impossibilità di comunicare con i casi più gravi, Angela adatta la propria percezione del mondo a ciò che è più congeniale per i malati, trovando un terreno comune nell’accettazione dell’aspetto fantastico. Il taccuino della fotografa diviene simbolo della comunicazione fra passato, presente e futuro, relazione che è possibile grazie all’intrusione dello spettro, elemento capace di occupare diverse coordinate temporali: «Il tempo passato, dove vivono tutti i tuoi fantasmi. Il tempo futuro, dove ti attendono quelli che lo diventeranno. Il tempo presente: qui».[11]
Se il fantasma è la figura che più si presta a viaggiare nel tempo e a far ritornare il passato, il mostro dà invece la percezione di chi è allontanato da una società che non lo conosce a fondo. Il lager dei malati più disperati è abitato da personaggi che condividono la condizione del mostro di Frankenstein, quella di una diversità che, esteriorizzata dall’aspetto fisico prima che da una reale interazione verbale, crea una barriera impenetrabile fra sé e gli altri. È questa la reazione istintiva di Angela, nonostante la protagonista sia stata sensibilizzata dall’esperienza del fratello disabile. Nell’intravedere un uomo al di là del muro che separa gli incurabili dal resto dell’istituto,
Si avvicinò ancora: una maschera di cicatrici vecchie e ferite nuove sotto la quale con uno sforzo d’immaginazione si riusciva a intravedere un uomo tra i trenta e i quarant’anni, con la fronte bitorzoluta e il cranio calvo. Angela immaginò che se lo avesse visto un bambino lo avrebbe chiamato mostro e ne sarebbe rimasto sconvolto. Cercava di allontanare da sé quella sensazione e quel pensiero, come se appartenessero a qualcun altro, ma invece era proprio lei a vederlo così: un essere spaventoso, intollerabile.[12]
Se l’immagine del mostro come presenza insondabile rimanda a Frankenstein di Mary Shelley, i richiami alla tradizione del gotico, attuati attraverso il personaggio della fotografa, non si fermano. Così come la figura del fantasma permette la comunicazione fra passato e presente, la stessa valenza è conferita al ritrovamento di vecchi documenti e, elemento imprescindibile del gotico classico, all’esplorazione di passaggi sotterranei e camere nascoste, dove si svelano segreti inimmaginabili. Questa funzione è ricoperta dal vecchio archivio dell’istituto, stanzino sotterraneo che rivela quanto limitata fosse la documentazione dei casi clinici, a riprova della mancanza di un reale tentativo di cura. La scoperta dell’archivio è assimilabile a una riscrittura, in chiave moderna, degli innumerevoli episodi con cui l’ambientazione gotica introduceva celle, segrete e sotterranei di castelli e monasteri:
Al piano inferiore faceva quasi freddo e mano a mano che le scale si inoltravano nelle viscere dell’edificio l’odore di muffa e varechina si faceva sempre più forte e si sentiva qualcosa gemere, forse un filo dell’impianto elettrico, forse un tubo dell’acqua. Un rumore ritmico, a scatto, che le prime due o tre volte la fece sobbalzare. Una lampadina nuda penzolava dal soffitto e illuminava per un breve tratto un corridoio lunghissimo che come un cunicolo si perdeva nel buio.[13]
Giunto fin qui, il personaggio di un romanzo gotico che si rispetti dovrebbe imbattersi in un fantasma e, almeno in un certo senso, La prima verità non disattende l’aspettativa del lettore, ancora con un simultaneo ricorso a follia, mistero e arte visiva. Angela rinviene il diario di un uomo, personaggio che assume le sembianze di un’apparizione spettrale che può essere sì immaginata, ma percepita solo tramite l’interpretazione degli appunti che lasciato:
Angela si stese nella branda, al buio, e dentro gli occhi vide la grafia meticolosa di quello sconosciuto perduto nel tempo; cercò di immaginare le sue mani e le vide tremanti, fragili, anche se molto probabilmente non lo erano affatto, o forse non lo erano state prima di arrivare in questo posto. Vide dita con le unghie squadrate e un anello d’argento, una specie di fede a spirali, stretto attorno a un indice abbronzato. E mentre scivolava nel sonno, e dal piano inferiore dell’edificio arrivavano colpi violenti e le solite urla spaventose della notte, vide il volto di un uomo ancora giovane, molto bello, con gli occhi azzurro cupo, quasi blu, che la fissava dritto in faccia e senza parlare si accostava il dito indice alla bocca, come a intimarle il silenzio. In testa le risuonò una frase che però non ricordava di aver letto. L’ultimo a morire è il corpo. Che strana frase, soprattutto pronunciata da un fantasma.[14]
L’interazione fra Angela e Basil (soprannominato ‘il Monaco’ perché la sua follia si era manifestata come eccesso di fede religiosa, e per un reale tentativo di entrare in monastero) è costruita artisticamente sul rinvenimento di un disegno raffigurante una maternità, immagine che il vecchio malato considera «quello che rimane di dio».[15] L’esitazione tipica del modo fantastico (credere o no a ciò che si sta osservando?) è al centro di questo scambio: per Angela le parole di un folle gettano chi ascolta in un labirinto di dubbi, ma rinvenire il disegno che Basil aveva effettivamente indicato conferisce al Monaco lo statuto di persona a cui si può credere. Da una prospettiva strutturale, il sasso col disegno diventa uno di quegli ‘oggetti mediatori’ che, alla fine di un’esperienza perturbante, provano al protagonista che qualcosa è veramente accaduto, e che l’interazione con un’altra realtà ha avuto luogo. Alimentata da continui riferimenti alle arti visive, l’esitazione fantastica de La prima verità si risolve finalmente con l’affermazione del potere pratico e ‘performativo’ della fotografia, esemplificata dalla storia di Antonella Pizzamiglio che svela le foto del lager al convegno mondiale di psichiatria. In modo simile, la denuncia operata nel 1989 dal giornalista di «The Observer» John Merritt si pone in stretta relazione agli equilibri geopolitici di fine millennio: per la reputazione della Comunità Europea lo scandalo di Leros è intollerabile, e riformare il sistema diviene imperativo.

2. Quello che l’acqua nasconde
Una simile commistione fra fotografia, violenza politica, richiami fantastici e manicomi ritorna in Quello che l’acqua nasconde di Alessandro Perissinotto. Il romanzo è basato sull’intersezione fra esperienza individuale e storia nazionale: lo straordinario genetista Edoardo Rubessi visita l’Italia dopo anni trascorsi negli Stati Uniti, e finisce per affrontare i fantasmi (che pensava di avere scacciato) degli anni Sessanta e Settanta.
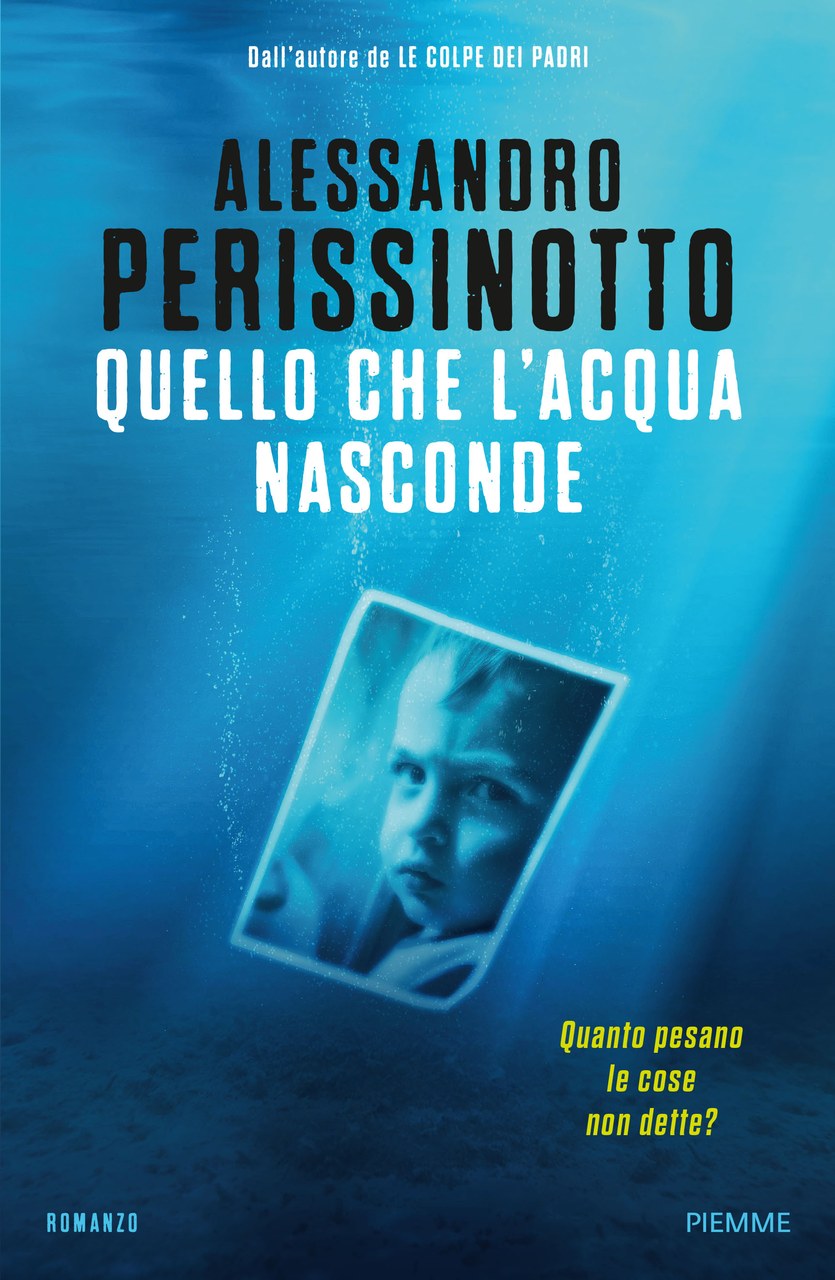
Se il romanzo di Simona Vinci colpisce il lettore con l’immagine di una bambina in stato di prigionia, quello di Perissinotto si apre con l’altrettanto inquietante figura del corpo ustionato di Roberto Crescenzio – vittima accidentale di una rappresaglia politica – immortalato nel 1977 in una fotografia simbolo degli anni di piombo.
Il romanzo introduce la funzione della fotografia come strumento che obbliga l’individuo a fare i conti con un passato che si vuole occultare. Per estensione, questo ruolo si riversa su tutta la società, colpevole di non far luce fino in fondo sul periodo della strategia della tensione che, non a caso, Gabriele Vitello ha studiato con la metafora fotografica dell’album di famiglia.[16] Il collegamento – apparentemente azzardato – fra manicomi e terrorismo si rivela, invece, appropriato. Simboli dell’interpretazione classista della medicina, gli istituti psichiatrici erano al centro dell’attenzione di quei gruppi eversivi che alcuni medici, a loro volta, osservavano come espressione di una devianza comportamentale da trattare clinicamente. Il personaggio principale, Edoardo Rubessi, incarna l’esperienza manicomiale nella sua declinazione classista, essendo stato internato da bambino più come figlio inquieto di alcolizzati che per reali disturbi mentali: come alcuni contestatori scrissero occupando un manicomio di Parma, «il figlio del ricco è esaurito, il figlio del povero è matto».[17] La difficoltà di chiarire le relazioni fra due realtà apparentemente lontane è risolta con l’uso delle arti visive come strumenti che collegano la dimensione fantastica a quella verosimile. La soluzione narrativa è legata a Susan, moglie americana del protagonista. Preoccupata di ciò che Edoardo nasconde, la donna – fotografa free lance – indaga sul passato del marito, dei manicomi e del terrorismo in Italia con le tecniche che più le sono congeniali, appunto quelle della fotografia. Paragonata alla sistematica falsità della parola, esemplificata dalle bugie e omissioni di Edoardo, l’immagine fotografica emerge come portatrice di una verità che completa e chiarisce i comportamenti del protagonista, ed è portata come negazione inconfutabile delle sue menzogne. Varie immagini hanno immortalato un’adolescenza diversa da quella che Edoardo ha raccontato alla moglie, come si evince dalle rivelazioni di Aldo, narratore della vicenda. Svelare le diapositive della loro adolescenza in relazione al concetto di verità offre anche spunti sociologici legati alla fiducia che l’individuo ripone negli altri. Tale fiducia è generata dalla frequente impossibilità di verificare tutte le informazioni che ci pervengono ma, laddove l’opportunità si presentasse, l’istinto sarebbe sempre quello di sincerarsi sulla loro autenticità. Gli effetti sarebbero spesso sorprendenti, come il dialogo fra Aldo e Susan suggerisce:
Buttai lì: «A casa ho le foto di quel periodo. Le foto dei campi. C’è anche Eddy». La fiducia che noi riponiamo negli altri non ha niente di sincero: è pura necessità. Siamo fiduciosi in ciò che gli altri fanno e dicono solo perché, il più delle volte, non possiamo regolarci diversamente. Senza la fiducia non prenderemmo più gli aerei, non attraverseremmo più la strada, non abiteremmo le nostre case, non mangeremmo al ristorante; e non ci sposeremmo, non faremmo l’amore, non ci mostreremmo neppure nudi e indifesi di fronte all’altro. Ma quando qualcuno ci offre la possibilità di scambiare la fiducia con la certezza, quasi mai rifiutiamo il baratto; quando ci chiedono se preferiamo credere o sapere, difficilmente ci accontentiamo del credere.[18]
Proprio questo baratto fra fiducia e certezza trova nella fotografia lo strumento per essere attuato, funzione che la pone in opposizione all’insondabilità del racconto verbale – corrotto – di Edoardo. Mostrare le diapositive dell’adolescenza equivale a distruggere le certezze raccontate dal genetista: «Non c’erano più dubbi, Edoardo si era reinventato l’adolescenza trasformandola da come era stata a come avrebbe voluto che fosse».[19]
Il passato che Edoardo nasconde suggerisce anche il collegamento con il romanzo di Simona Vinci e con la storia della condizione manicomiale in Italia. Vittima del sadismo di Giorgio Coda e del suo assistente, Giovanni Balistreri, Edoardo è raffigurato nelle loro fotografie, che lo vedono legato ad un termosifone. Se l’immagine fotografica condanna Edoardo come bugiardo, lo stesso strumento chiarisce le motivazioni del protagonista che, segnato dall’orrore subìto, emerge come vittima delle contraddizioni degli anni Sessanta e Settanta. Come accaduto per lo scandalo di Leros, l’evidenza fotografica ricoprì un ruolo fondamentale anche per la comprensione delle vicende dei manicomi di Collegno e Grugliasco. Per i molti malati che subirono torture come l’elettromassaggio, l’oggettiva impossibilità di dar voce all’ingiustizia poneva un freno alla libertà – anche giuridica e processuale – di testimoniare la propria tragedia. Nell’isolamento del manicomio, la sostituzione della parola con la fotografia ha anche una motivazione puramente storica: agli internati non era permesso comunicare, in forma orale o scritta, con il mondo esterno. Come si ricordava nel volume fotografico edito da Franco Basaglia, Morire di classe, «gli infermieri non devono tenere relazioni con le famiglie dei malati, darne notizie, portar fuori senz’ordine lettere, oggetti, ambasciate, saluti: né possono recare agli ammalati alcuna notizia dal di fuori, né oggetti, né stampe, né scritti».[20] La proibizione di una forma tradizionale di comunicazione amplifica la risonanza della fotografia interpretata in senso ‘clandestino’ e ‘democratico’, allo scopo di conferire una voce a chi non ce l’ha. Le fotografie scattate nonostante i divieti pongono l’opinione pubblica dinanzi a una scioccante rivelazione: la realtà manicomiale di cui così poco si sapeva si mostra ora in tutto l’orrore di una dimensione che, lasciata a se stessa, aveva creduto di poter adottare un sistema di valori e regole alternativo a quello esterno. Come Alberto Bonvicini, Edoardo prima ha fatto esperienza ingiustamente del manicomio, poi si è avvicinato alla lotta armata. In entrambi i casi la fotografia si fa portatrice di quel passato che rifiuta di essere dimenticato, riportando alla luce delle realtà che la società ha preferito nascondersi, per non fronteggiare le proprie responsabilità.
Anche il romanzo di Perissinotto coniuga l’intenzione sociale ad una riflessione tecnica sull’interazione fra arte visiva ed elemento fantastico, ed alla funzione realistica che può essere conferita all’intrusione di circostanze perturbanti. Il ritorno del passato è un motivo tipico, per esempio, del romanzo gotico, in cui gli spettri di antenati ed avi si manifestano allo scopo di obbligare il presente a confrontarsi con eventi che si è preferito ignorare. Il sadico Balistreri ritorna dal passato nella vita di Edoardo, e proprio le fotografie che gli aveva scattato durante la tortura sono il mezzo usato per provare la propria identità e distruggere le certezze che il genetista ha costruito con la carriera e con il matrimonio con Susan. Balistreri interpreta la fotografia in una chiave accusatoria, volta ad aprire la crisi interiore di Susan. Autore degli scatti su Edoardo, il personaggio di Balistreri (un medico) come fotografo richiama la connotazione demoniaca dell’uomo di scienza nella tradizione dei romanzi gotici e fantastici. È particolarmente in questa connotazione che il ritorno di Balistreri simboleggia, per Edoardo, il ritorno di un tempo passato che si ripropone attraverso la figura del fantasma, entità capace di scardinare le categorie di spazio e tempo:
Anche se la sera il vecchio non c’era, ogni volta che prendeva la bicicletta per tornare a casa, ne vedeva la sagoma seduta sulla panchina, lo spettro. Balistreri aveva mantenuto il dono tremendo di incutere paura anche in assenza, come a Villa Azzurra, quando, nei momenti in cui non era in camerata, tutti lo immaginavano da qualche parte, a trascrivere i nomi dal suo quadernetto alla lista dei candidati all’elettromassaggio di Coda.[21]
Al contrario, la caratterizzazione di Susan come fotografa suggerisce un’interpretazione che coniuga il valore artistico e quello sociale della fotografia, ancora una volta con riferimenti inverosimili usati a scopo realistico. Avendo visitato il rudere di Villa Azzurra, Susan ‘anima’ le immagini dell’abbandono con la propria arte, ricreando la vita del marito sullo sfondo di ciò che rimane della clinica:
La sua tecnica, come quella di tutti i grandi fotografi, consisteva nell’isolare i frammenti dal tutto e nel dare a essi un significato autonomo. Sullo schermo comparve l’immagine di una parte di muro, una superficie di un metro per uno e mezzo, insignificante all’apparenza, almeno per me; invece lei aveva visto e catturato il segno che, su quel muro, aveva lasciato la testiera di un letto di ferro: un rettangolo con gli spigoli smussati e tanti tratti verticali, in corrispondenza delle sbarre. E, nel gioco di luci e di ombre, quella traccia era così netta che non ci vedevi il segno, ci vedevi il letto. «Questo è il letto di Edoardo» disse commentando la foto «lui è lì, sdraiato, con gli occhi aperti, come quando, la domenica, dopo pranzo, si corica sul divano e rimane a pensare al suo lavoro, guardando il soffitto.» Una dissolvenza. Poi la foto di un albero ripreso attraverso l’intelaiatura a quadri di una finestra senza vetri. «Quello è l’albero che Edoardo guardava ogni giorno, quello su cui avrebbe voluto arrampicarsi.» La sua voce era incrinata. Un lavandino in ceramica appeso al muro, un lavandino lungo, una vasca interminabile. «Qui è dove mio marito si lavava, lui che ama tanto l’acqua.» Le foto continuarono a succedersi, una dopo l’altra, e io finalmente capii che ce l’aveva fatta, era riuscita a provare amore e pietà per quel bambino che, in una vita precedente, era stato Edoardo. Ci era riuscita non grazie alla foto sadica del vecchio, ma grazie alle sue, che riempivano di umanità il vuoto delle stanze abbandonate.[22]
Nel passaggio dall’approccio storico ad uno più propriamente contemporaneo, qualcosa di simile accade con gli scatti dei molti luoghi pubblici in stato di abbandono nella città di Torino. Lo zoo, la stazione Vanchiglia, il vecchio ufficio postale, le baracche del corso Regio Parco ed altri luoghi che conferiscono identità alla vecchia Torino si animano tramite l’obiettivo di Susan, con le loro «macerie e mura pericolanti»[23] a richiamare ulteriormente l’ambientazione gotica. La capacità rigenerativa della fotografia appare ora in grado di rivitalizzare luoghi abbandonati, in modo simile a ciò che aveva fatto con Villa Azzurra, e di conferire un’essenza vitale a ruderi che ne sono apparentemente privi. È questa funzione della fotografia, a metà strada fra magia e abilità tecnica, a creare quell’esitazione perturbante nell’osservatore, che percepisce segni vitali dove non ne rimangono veramente:
Come là pareva di vedere i bimbi reclusi, qui gli animali tornavano a popolare le gabbie. Il boa riviveva nel fascio di rampicanti che si attorcigliava sulle maglie di una rete metallica, la giraffa sporgeva il collo nella sagoma di vecchio lampione arrugginito e piegato di netto a due terzi della sua altezza, i pezzi di muro caduti e adagiati in orizzontale erano testuggini spiaggiate. Ma l’abilità di Susan andava oltre l’abilità di far intravvedere la vita nelle forme morte; le sue foto restituivano la drammaticità delle esistenze recluse, imprigionate dietro le sbarre oggi divelte. Il dolore degli animali ingabbiati e dei bambini legati era palpabile, anche se di quei supplizi non rimanevano che le carcasse degli strumenti di tortura.[24]
Ciò che avviene nell’attico di Aldo è una sorta di ékphrasis, una descrizione della fotografia come opera d’arte che, nel divenire vivida grazie alla retorica dell’osservatore, finisce per rigenerare la vitalità dell’oggetto immortalato. Il personaggio come fotografo continua un’interpretazione dell’arte visiva come alternativa alla scienza medica. Sia il fotografo (come notava Ceserani ne L’occhio della medusa) che il medico ricoprono il ruolo di perturbanti portatori di modernità nelle tradizioni del romanzo gotico e nel modo fantastico, e sono spesso raffigurati come cinici, insondabili e disposti a sacrificare l’individuo in nome dell’avanzamento della loro tecnica. Quello che l’acqua nasconde introduce un medico, Edoardo, il quale perde ripetutamente la sfida lanciata contro le malattie genetiche e vorrebbe concentrarsi interamente sulla lotta contro di esse, evitando ogni interazione con i pazienti. Al contrario, l’arte visuale, riportando la vita dove c’è abbandono, è capace di vincere la morte e restituire dignità agli individui torturati da Coda e, nel fare ciò, stabilisce un connubio con le scienze umanistiche. Non a caso, Quello che l’acqua nasconde introduce Susan come una fotografa laureata in letteratura, mentre La prima verità costruisce il personaggio del perseguitato politico Stefanos come un poeta che si cimenta nella pittura:
Kyriakos posò il pennello intinto di giallo ocra su un coperchio di latta, fece un passo indietro e si grattò la testa sotto il cappello di paglia che puzzava di sudore e capelli sporchi. Lavoravano dodici ore al giorno, tutti i giorni, con tre soldati sempre piantati alle costole, e anche se l’idea di questi affreschi era venuta a loro, prigionieri politici, e ci stavano mettendo dentro, oltre che la miglior buona volontà, anche rabbia e amore, a volte gli veniva da chiedersi chi cazzo gliel’avesse fatto fare. Loro sarebbero marciti su quest’isola e, a parte gli indigeni, chi l’avrebbe mai vista, questa chiesa e le facce troppo umane di questo Cristo e di questa Madonna con la bocca rossa? Stefanos non sapeva dipingere. Lo avevano portato perché lui era un intellettuale, un poeta, ci sapeva fare con le parole e li avrebbe aiutati a scegliere i passi della Bibbia che avrebbero posto in calce agli affreschi.[25]
3. Conclusioni
Nel suggerire un collegamento fra fotografia, modo fantastico, istituti psichiatrici e violenza politica, Vinci e Perissinotto indicano la strada per un’ibridazione del genere romanzo che non va sottovalutata. Al di là delle fotografie che servono da antefatto per i romanzi, è soprattutto la scelta narrativa del personaggio come fotografo a scardinare una significativa serie di limitazioni, aspetto confermato dal recente consenso critico conferito a La ragazza con la Leica di Helena Janeczek. Le protagoniste di queste storie, nel trovarsi in un’ambientazione a loro straniera (la Grecia per Angela e l’Italia per Susan), utilizzano il mezzo fotografico per scavalcare le barriere di ciò che non conoscono a fondo del setting. Il richiamo alla suspense del gotico, ricorrente nei momenti in cui le due donne si accingono a scattare immagini o reperire altre informazioni, oltrepassa i confini del semplice accorgimento narrativo per servire finalità legate al romanzo sociale: nell’introdursi in luoghi vietati o abbandonati, le due donne simbolizzano la funzione di chi sfida regole che vogliono preservare uno status quo ingiusto, o una ricostruzione corrotta e parziale del passato.

Tali scelte narrative sono maggiormente giustificate dal ruolo ricoperto storicamente dal mezzo visivo come denuncia a Leros e nei manicomi italiani, particolarmente per la comprensione che il cittadino comune ebbe di un fenomeno in precedenza sottovalutato. Per questo stesso scopo le arti visive, la fotografia ed il personaggio come fotografo accompagnano il lettore attraverso la storia di individui che, pur non essendo malati psichiatrici, si trovano ad interagire con essi. Edoardo finisce in manicomio come forma di punizione contro il suo carattere irrequieto e, ne La prima verità, lo stesso accade al piccolo Nikolaos, confinato nell’area dei pazienti inguaribili per motivi non clinici ma opportunistici, in quanto testimone potenzialmente pericoloso delle violenze a Teresa ed al poeta Stefanos. Ciò si coniuga con la concezione della malattia mentale in un periodo storico che vedeva in essa una colpa da espiare e non una condizione che, se curata a dovere, poteva essere temporanea. Persone sane internate in istituti psichiatrici, questi personaggi rappresentano il mondo estraneo ai manicomi che entra in essi e ne verifica le terribili dinamiche, mettendo il lettore nella condizione di immaginarsi ingiustamente recluso. Il processo di immedesimazione si estende ad altri aspetti, ad indicare la vulnerabilità di ognuno dinanzi all’interpretazione della malattia mentale come accusa. La voce narrante di Perissinotto immagina che, se avesse vissuto circostanze familiari differenti, la sua stessa indisciplina avrebbe potuto portarlo in manicomio, mentre il romanzo di Vinci è narrato dalla prospettiva di Angela, la cui relazione omosessuale con Lina avrebbe comportato, ai tempi di Coda, conseguenze analoghe.
Inevitabilmente, la caratterizzazione di Angela e Susan come fotografe pone anche una questione di genere, in cui l’essere donna fornisce ulteriori implicazioni allo studio delle protagoniste. Come accade spesso nella rappresentazione narrativa dell’emarginazione sociale, la già terribile condizione dei malati è ancora peggiore per le donne. Ne La prima verità ciò emerge dalle vicende della piccola Teresa, vittima di uno stupro di gruppo che la spinge al suicidio e la pone all’ultimo gradino di una scala sociale alternativa in cui essere malati, poveri e bambini è ancor più difficile se si è donna. Quello che l’acqua nasconde ricorda, invece, la percezione della nevrosi come diagnosi spesso affrettata e più frequente per le donne, che in anni recenti anche Corrado Augias ha narrato ne Il lato oscuro del cuore (2014). Ancora interpretata in senso accusatorio, la condizione che oggi verrebbe quasi sminuita come una forma di stress colpisce chi è percepito come vulnerabile per classe sociale e per genere: nel tentativo di licenziare una giovane cameriera, una ricca famiglia torinese la fa ricoverare all’istituto di Via Giulio, dove la rivalità fra due medici uomini decide il suo destino.
In conclusione, l’incontro fra fotografia e fantastico nel romanzo sui manicomi e la violenza politica stabilisce una finalità certamente realistica e sociale, laddove si parte da eventi e percezioni inverosimili. In questo senso, l’interpretazione del fotografo come personaggio si rifà direttamente alla definizione di Walter Benjamin, che intendeva questa figura nella sua capacità di «svelare la colpa e denunciare il colpevole»[26] di un crimine. In epoca di fake news e manipolazione delle notizie, il ruolo della fotografia come portatrice di verità emerge come valore da difendere attivamente. Proprio durante la stesura di questo saggio divampa una polemica che collega la fine de La prima verità con la funzione sociale della fotografia. Nell’emergenza migratoria che Vinci interpreta come nuova frontiera della rappresentazione dello spettro, lo scatto di una ‘naufraga con lo smalto’[27] viene usato per sminuirne la tragedia individuale. Con i suoi fantasmi (le persone senza identità, nome o dimora) e i suoi mostri (i diversi, gli emarginati, gli stranieri), l’applicazione contemporanea della tradizione del gotico e del fantastico nei romanzi di Vinci e Perissinotto conferisce al personaggio della fotografa la funzione mediatrice di chi è disposto a correre rischi in prima persona per agire al posto di chi non ne ha la possibilità. Per questi motivi, la retorica fantastica di chi si trova a «disseppellire i morti»[28] e «intravvedere la vita nelle forme morte»[29] sposa finalità che sono, al contrario, reali e concrete, volte ad evocare i fantasmi di chi è stato emarginato e conferirgli una forma, seppur tardiva, di giustizia sociale.
* L’autore ringrazia i fotografi che hanno acconsentito all’uso delle loro immagini, e chi ha collaborato per ricevere i permessi. Nell’ordine in cui le fotografie appaiono nel saggio: Robin Vandenabeele (fig.1), Mauro Vallinotto (fig. 2), Antonella Pizzamiglio (fig. 3), Nadia Morelli, Francesca Lang, Cecilia Flegenheimer (fig. 4) e Alessandro Perissinotto (fig. 5).
1 R. Donnarumma, Storie Oblique, presentazione a G. Vitello, L’album di famiglia: gli anni di piombo nella narrativa italiana, Massa, Transeuropa, 2013, p. 9. Nello stesso passaggio Donnarumma riflette sulla comparazione fra padre e Stato in narrativa come uno «schema interpretativo diffuso in modo pressoché incontrastato nel discorso pubblico», suggerendo una lettura degli anni di piombo attraverso la lente della negazione della figura paterna non solo in quanto dittatoriale, ma anche perché inadeguata al ruolo che dovrebbe ricoprire ed al quale spesso si sottrae.
2 F. Colleoni, ‘Spettri della violenza politica: gli anni Settanta in alcuni romanzi del nuovo millennio’, Enthymema, VII, 2012, pp. 425-442.
3 R. Caillois, Nel cuore del fantastico, Milano, Abscondita, 2004, p. 162.
4 R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 63.
5 S. Albertazzi, Letteratura e fotografia, Roma, Carocci, 2017, p. 9.
6 L’intersezione fra onomastica e letteratura fantastica è approfondita in S. Zangrandi, Fanta-onomastica. Scorribande onomastiche nella letteratura fantastica del Novecento, Pisa, ETS, 2017.
7 S. Vinci, La prima verità, Torino, Einaudi, 2016, p. 7.
8 Ivi, p. 13.
9 La definizione del fantastico e della sua biforcazione in ‘strano’ o ‘meraviglioso’ è contenuta in T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1995, p. 28.
10 S. Vinci, La prima verità, p. 34.
11 Ivi, p. 48.
12 Ivi, pp. 50-51.
13 Ivi, p. 59.
14 Ivi, p. 83.
15 Ivi, p. 79.
16 G. Vitello, L’album di famiglia: gli anni di piombo nella narrativa italiana.
17 O. Pivetta, Franco Basaglia. Il dottore dei matti, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2015, p. 36.
18 A. Perissinotto, Quello che l’acqua nasconde, Milano, Piemme, 2017, pp. 59-60.
19 Ivi, p. 63.
20 F. Basaglia, Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, Torino, Einaudi, 1969, p. 44.
21 A. Perissinotto, Quello che l’acqua nasconde, p. 194.
22 Ivi, pp. 165-166.
23 Ivi, p. 205.
24 Ivi, p. 208.
25 S. Vinci, La prima verità, pp. 135-136.
26 W. Benjamin, Breve storia della fotografia, Bagno a Ripoli, Passigli, 2014, p. 54.
27 ˂http://www.repubblica.it/cronaca/2018/07/23/news/bufala_smalto_josefa_open_arms_migranti-202474909/˃
28 S. Vinci, La prima verità, p. 77.
29A. Perissinotto, Quello che l’acqua nasconde, p. 208.
Tag: Simona Vinci, Alessandro Perissinotto, Leros, Villa Azzurra, gotico, fantastico, fotografia