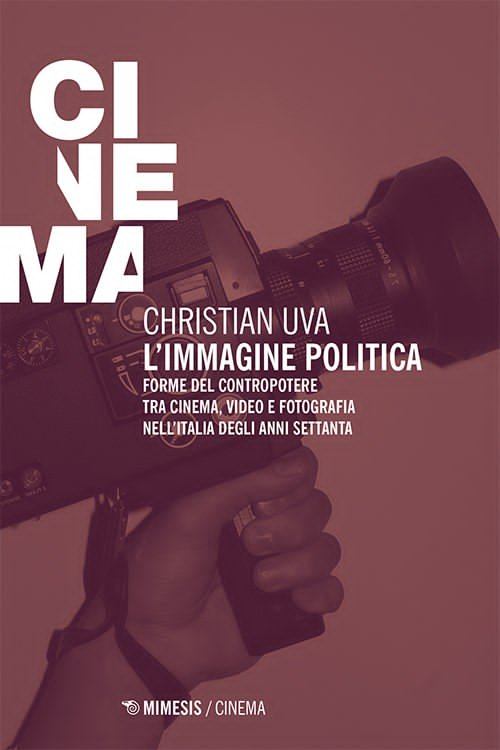
Nel tentare una prima forma di epurazione nei confronti del suo avversario, Stalin fece cancellare Lev Trotskij dalla fotografia che lo ritraeva al fianco di Lenin durante un comizio tenuto da quest’ultimo nel 1920; lo stesso fece Hitler nel momento in cui, spinto da motivazioni diverse, decise di far eliminare Goebbels da una fotografia del 1937 che li ritraeva entrambi insieme alla regista Leni Riefenstahl. Gli esempi di manipolazione o di uso di media differenti come veicolo di un messaggio ideologico potrebbero moltiplicarsi se si considera il ventennio fascista e l’immagine che di sé Mussolini diffuse servendosi della fotografia, del cinema, degli organi di stampa. Tra i possibili impieghi delle immagini, siano esse statiche o in movimento, l’utilizzo con finalità di propaganda politica o perfino di oppressione è stato ampiamente praticato dai sistemi di governo che si sono succeduti nel corso del Novecento. Ma se gli espedienti retorici messi in atto dal potere in funzione della propria predominanza sono oramai noti e ampiamente dibattuti, ancora ricco di nuove esplorazioni è il campo d’indagine preso in esame da Christian Uva nel volume L’immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell’Italia degli anni Settanta (Milano-Udine, Mimesis, 2015). Il saggio si allontana dall’osservazione dei media ufficiali e dà voce alle immagini cinematografiche, elettroniche e fotografiche che con essi instaurano un rapporto di antagonismo, ponendosi come schegge di resistenza e di controinformazione. Lo scenario storico in cui le immagini analizzate esplicano la loro valenza politica non è quello dei regimi totalitari, ma il decennio caldo degli anni Settanta in Italia, racchiuso tra le contraddizioni del 1968 e le lotte armate che tra il 1977 e l’anno successivo raggiungono esiti controversi.
Il testo non presenta una scansione tematica, ma propone approfondimenti e analisi di singoli casi studio sulla base dei dispositivi via via coinvolti nella contestazione, dedicando a ciascuno di essi un intero capitolo. Il primo medium che si affaccia sul terreno dell’azione politica in forma di immagine è il cinema. L’autore passa in rassegna i documentari e i lungometraggi realizzati dai collettivi studenteschi, ripercorre il dibattito teorico intorno alla ridefinizione della forma e della tecnica del cinema avviata alla fine degli anni Sessanta, e non trascura i contributi di registi impegnati come Zavattini e Bellocchio, delineando lungo una trattazione densa di esempi le peculiarità del cinema militante. Emerge chiaramente come i segnali di rottura con il cinema tradizionale passino attraverso il rifiuto di un orizzonte borghese che, partendo dalla struttura stessa del linguaggio filmico, viene identificato con una componente narrativa, spettacolare e drammatica facilmente compromessa con i circuiti commerciali. Le inchieste e le testimonianze riprese vengono piuttosto montate in sequenze che riflettono, anche nella breve durata delle inquadrature, la concitazione di quegli anni. Compito precipuo del cinema militante, strettamente correlato, dunque, anche alle scelte di stile, è la rivendicazione di un intervento diretto sulla realtà, condotto sia attraverso la presenza fisica della macchina da presa nei luoghi topici della contestazione (le università, le fabbriche, le piazze), sia per mezzo di una ricaduta effettiva sui processi sociali e politici. Esemplificativo, a tal proposito, è Apollon: una fabbrica occupata (1969) di Ugo Gregoretti, che documentando la battaglia dei lavoratori della tipografia romana non solo contribuisce alla sua riapertura ma innesca occupazioni anche in altre fabbriche.
Dopo la strage di piazza Fontana, all’alba degli anni Settanta, alle rivendicazioni di studenti e operai si affiancano questioni di carattere sociale: il diritto alla casa, alla scuola e alla salute, nonché il diritto di emancipazione confluito nel movimento femminista, convivono con le convulse tensioni che coinvolgono diverse forze in campo, dalle frange extraparlamentari allo Stato, alla minaccia neofascista. Come si legge nella parte centrale del volume, a farsi veicolo di espressione di tali istanze sono i dispositivi di ripresa e di registrazione elettronica, la cui natura versatile meglio si adatta all’urgenza di porsi in presa diretta con la realtà. Sull’immediatezza e sulla possibilità di una comunicazione orizzontale, «ad altezza degli stessi soggetti» (p. 123), del videotape alcuni collettivi e registi fondano un vero e proprio metodo, non disgiunto da una consapevolezza teorica che parte dalla conoscenza dello strumento. È il caso del gruppo Videobase, che ne Il fitto dei padroni non lo paghiamo più (1972), ad esempio, si immerge nel quartiere della Magliana e ne segue per oltre dieci mesi le assemblee; oppure di Alberto Grifi, che nel suo Anna (1972-1975) riporta la vicenda della minorenne incinta e tossicodipendente al suo nucleo vitale, dilatando potenzialmente all’infinito la durata delle riprese.
L’ultimo linguaggio visivo di cui si ricercano le accezioni politiche è la fotografia. In questa sezione del testo l’autore affonda le proprie riflessioni nel pieno degli anni di piombo e ricostruisce il backstage di alcune delle immagini che si sono sedimentate nell’immaginario collettivo. Tra queste, a spiccare per la plasticità della figura ritratta e per le connotazioni che di volta in volta le sono state attribuite, è la fotografia scattata da Paolo Pedrizzetti al giovane coperto da un passamontagna che, durante la nota manifestazione del 1977 in Via De Amicis a Milano, impugna una pistola ad altezza d’uomo. Seguendo la natura indiziaria della fotografia, Uva spiega come lo scatto sia stato utile a risalire ad altri negativi dai quali si evince che il colpo inferto al vicebrigadiere non proveniva dalla pistola dell’uomo immortalato da Pedrizzetti, ma di un altro attivista, anche lui esponente di Autonomia Operaia.

L’imprescindibile dimensione documentaria della fotografia si sposa con un chiaro messaggio politico in altre fotografie amatoriali strettamente connesse al modo in cui si è consolidata nelle immagini la rappresentazione degli anni di piombo, ossia le polaroid che riprendono Aldo Moro nel covo delle Brigate Rosse. Se da un lato esse rispondono ai criteri referenziali e denotativi della foto segnaletica, dall’altro restituiscono un’immagine dimessa del politico, prefigurandone la distruzione. Distanti dalla violenza che promana dalle fotografie cui si è accennato sono gli scatti di Tano D’Amico – alcuni dei quali riprodotti nel volume, come le foto e i frame analizzati nei paragrafi e nei capitoli precedenti – impegnati a conferire un «epos umano» (p. 220) ai militanti e a sottrarre il loro agire alle mistificazioni dell’informazione ufficiale.
Dopo aver ripercorso le sequenze e i frammenti visivi di un’epoca tra le più problematiche e affascinanti della recente storia italiana, il testo si conclude con un passaggio alla tecnologia digitale. Gli spunti interpretativi avanzati dall’autore prendono le mosse da caratteristiche congenite come l’alta definizione e l’eccesso di realismo che ne consegue, tale da far slittare le immagini ‘povere’, in bassa definizione o in bianco e nero, nell’orbita di una precisa scelta politica (ne è testimonianza l’utilizzo dello smartphone da parte di Pippo Delbono in alcune delle sue opere più graffianti). Sono dati, questi, che alla luce dei nuovi fenomeni di terrorismo e delle dinamiche incredibilmente pervasive di diffusione delle immagini sollevano quesiti destinati ad impegnare anche gli sguardi più attenti e critici.