Les années è il racconto della vita di una donna nata in Francia nel 1940 coincidente con il vissuto dell’autrice; la narrazione è scandita più che da vicende e accadimenti personali dalle fasi dell’emancipazione sociale, economica e femminile del dopoguerra, attraverso la transizione da una società dominata da valori religiosi e dall’ethos comunitario a una improntata al consumo delle merci e al godimento individuale.[1] Gli anni può essere considerato il culmine di un’aspirazione autobiografica che percorre tutta l’opera di Annie Ernaux, ma è anche il libro in cui l’autrice francese mette maggiormente in discussione e innova il genere letterario della rappresentazione di sé.

Ne La honte e ne Il posto, gli altri due testi impegnati a fare i conti con la storia il tempo e la memoria, la narrazione è condotta in prima persona, mentre ne Gli anni il perno dell’io sparisce, si insabbia in un ‘noi’ collettivo, in sostantivi di categoria – le madri, i padri, i figli – o in una terza persona generica. L’autobiografia diventa paradossalmente impersonale.[2]
Questo significa che il rapporto fra eventi individuali e sfondo sociale viene invertito, le vicende individuali altro non sono che ricadute di una storia che accade sopra la volontà e perfino la capacità di comprensione di chi la racconta.[3] Ecco come, ad esempio, viene descritto il passaggio dalla condizione di studentessa a quella di giovane madre:
Nei pomeriggi di sole, le giovani mamme, sedute sulle panchine dei giardinetti e con un occhio al parco giochi, si scambiavano consigli sui pannolini e su cosa dare da mangiare ai figli. Sembravano lontanissime le confidenze dell’adolescenza, le lunghe chiacchierate fatte nel riaccompagnarsi interminabilmente a casa. Le lasciava incredule il pensiero di come avevano vissuto fino a tre anni prima, con il rimpianto di non averne approfittato più a lungo. Erano entrate nella fase della preoccupazione per il cibo, per il bucato, per le malattie infantili. Avevano pensato che non sarebbero mai diventate come le loro madri e ora, con più leggerezza con una forma di disinvoltura incoraggiata dalla lettura di libri quali “Il secondo sesso” e slogan come Moulinex libera la donna, ne prendevano il testimone, rifiutando però, a differenza loro, di riconoscere qualsiasi valore a ciò che tuttavia si sentivano tenute a fare senza sapere bene perché.[4]
Sopprimendo i personaggi, intesi come costruzioni psicologiche tridimensionali, e mettendo sullo stesso piano cose e individui, Ernaux abdica all’intenzione romanzesca, ciò che le interessa configurare non è una trama, né una storia, ma lo scorrere del tempo. Già ne Il posto l’autrice aveva dichiarato a proposito del padre:
Da poco so che il romanzo è impossibile. Per rendere conto di una vita sottoposta alla necessità non ho il diritto di rimaneggiarla in senso artistico, né di fare qualcosa di appassionate o emozionante. Metterò insieme le parole, i gesti, i gusti di mio padre, i fatti salienti della sua vita, tutte le tracce oggettive di una vita che anche io ho condiviso. Nessuna poesia del ricordo, nessuna derisione trionfante. La scrittura piatta mi viene spontanea. È la stessa che utilizzavo quando scrivevo un tempo ai miei genitori per raccontare loro l’essenziale.[5]
Dichiarazione di poetica che viene portata all’estremo ne Gli anni dove i ricordi che sfilano non definiscono l’unicità di una vita, bensì la sua serialità. Un destino sovrapponibile a quello di milioni di altre persone. Dunque, ne Gli anni accade proprio il contrario di quanto avviene nella Recherche di Proust, testo evocato ripetutamente da Ernaux, ma che vale come modello agli antipodi. Proust vuole salvare e ricostruire la trama invisibile che lega i fra loro diversi momenti della vita e restituire l’estensione del tempo e la qualità dell’immersione individuale. Per Proust l’esistenza rivela attraverso il recupero memoriale un disegno tematico unico e pieno di corrispondenze; al contrario Ernaux abbandona questa pretesa ed eleva la casualità e l’inappartenenza a forma cogente della vita.
Il ricordo per Ernaux ha una qualità e una fattura eminentemente visive, è un fotogramma, un’immagine che la mente ha registrato senza una particolare ragione e che si ripresenta come un oscuro grafema alla memoria: «la donna accovacciata che, in pieno giorno, urinava dietro la baracca del bar al margine delle rovine di Yvetot, dopo la guerra, si risistemava le mutande con la gonna ancora sollevata e se ne tornava nel caffé». Eppure Gli anni si apre con una frase lapidaria: «Tutte le immagini spariranno». Una dichiarazione paradossale per una narrazione nella quale le immagini e le fotografie occupano tanto spazio. Qual è dunque la loro funzione e il loro ruolo?
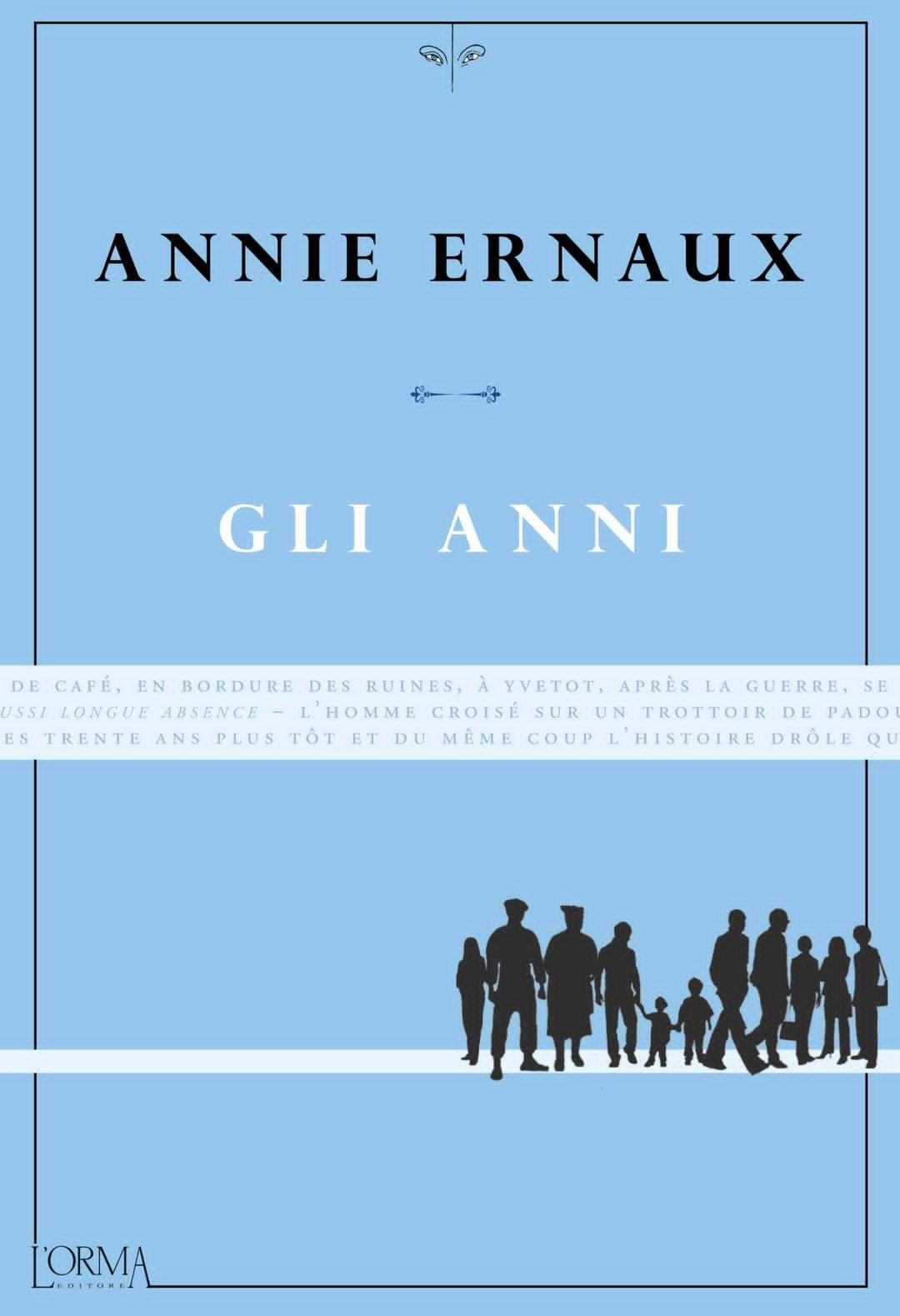
Anche ne La honte e Nel posto ci sono numerose descrizioni di fotografie, perlopiù di famiglia o ritratti personali, che riflettono la scissione tra identità acquisita e provenienza familiare, un nodo ripercorso da Ernaux nella propria infanzia e giovinezza, nel legame con i genitori gestori di un bar tabaccheria, in un paesino dell’alta Normandia, gli uni e gli altri estranei, con poca contiguità con ciò che la scrittrice è diventata: un’insegnante, esponente di una classe sociale inurbata e borghese diversa da quella con forti radici rurali dei genitori. L’estraneità provata nei confronti della vita dei propri genitori è al tempo stesso estraneità verso di sé, verso la propria esistenza.
Il frequente ricorso a descrizioni di fotografie di famiglia, sottoposte a un’analisi sociologica che ne indaga pose, vestiti, sfondi, è in questi due testi funzionale a ricostruire una memoria e un’identità in cui si cerca la prova indiziale della relazione, dell’esserci stato lì in quel momento e non altrove, a dispetto ma anche a riprova di ciò che l’autrice è diventata in seguito.[6] La fotografia che isola un frammento temporale, decretandone l’immediata morte ma anche lo slancio verso un’insondabile posterità, funge per Ernaux da dispositivo metanarrativo che asseconda la frammentazione dell’io biografico, ma costituisce anche la traccia residuale e unica cui la memoria può appoggiarsi, senza peraltro lasciare spazio a un’adesione sentimentale o a una celebrazione nostalgica.
L’ekphrasis di fotografie di famiglia o dell’autrice occupa un posto rilevante e cardine all’interno de Gli anni e si amplia a immagini che non sono fotografie vere e proprie ma ne hanno il medesimo carattere di fissazione dell’istante, cenotafi involontari della vita trascorsa.[7] Si tratta sempre di fotografie descritte e non mostrate, testualizzate all’interno della narrazione, di cui vengono forniti dettagli relativi alla loro materialità: macchie, scontornature, note presenti sul supporto. La dissociazione fra l’oggetto fotografico, in quanto ‘cosa’ costituita di carta, pigmenti e inchiostro, e l’immagine che tale oggetto trasmette è opportunamente usata per indicare una separazione fra la persistenza oggettiva e materiale – gli album di famiglia tramandati, le foto depositate nei cassetti e nei file del computer – e la loro leggibilità, legata invece alla memoria, alla tenacia degli individui che sanno ancora dare un significato a quelle immagini.
Esiste d’altra parte una tradizione francese significativa, da Marguerite Duras a Patrick Modiano a George Perec, di uso dell’immagine fotografica all’interno della narrazione romanzesca.[8] L’autore cui Ernaux sembra più vicina, almeno negli intenti, è Patrick Modiano che così si esprime circa l’autobiografia:
Ma démarche n’est pas d’écrire pour essayer de me connaître moi-même ni de faire de l’introspection. C’est plutôt, avec de pauvres éléments de hasard: les parents que j’ai eus, ma naissance après la guerre […] trouver un peu de magnétisme à ces éléments qui sont sans intérêt en eux-mêmes, les réfracter à travers une sorte d’imaginaire. L’antreprise autobiographique m’a toujours paru une sorte de leurre, sauf si elle a une dimensionpoétique comeme Nabokov l’a fait dans Autres rivages. Le ton autobiographique a quelque chose d’artificiel car il implique toujours una mise en scéne. Pour moi, c’est plutôtune entreprise artistique, une mise en forme d’éléments dérisoires.[9]
Sappiamo che il legame più forte esistente fra l’autobiografia e la fotografia è la memoria, i suoi modi di operare.[10] Esistono analogie fra il nostro modo di pensare il tempo e il procedimento fotografico, cercando di fermarlo nel ricordo, come fermiamo l’immagine con lo scatto, in realtà diventiamo consapevoli, proprio in virtù di questo gesto, che gli anni continuano a scorrere. La fotografia assume uno statuto singolare di solvente temporale e di testimonianza lacerante del suo passare. Inoltre poiché le fotografie e le immagini descritte sono oggetti esterni al testo, che nel testo vengono evocati, l’effetto che si crea è quello di uno scarto: rappresentare la fotografia significa mettere in parole la distanza, la separazione, il never more.[11]
Annie Ernaux abita con la scrittura lo scarto in cui la fotografia diventa testimonianza di un mondo che è stato e non è più, la narrazione che ne segue per certi aspetti è un colmare il vuoto, per altri è un aggirarsi intorno a un oggetto – l’immagine – di cui nonostante i limiti consapevolmente enunciati e la morte decretata alla prima riga («Tutte le immagini spariranno») l’autrice vuole mantenere dove possibile quell’emanazione irriducibile, perfino alla parola, che Modiano chiama «magnetismo».
In un’area semantica affine si muove lo storico dell’arte Horst Bredekamp che ha definito attivo il legame che ci avvince a quanto cade sotto il nostro sguardo e ha forma compiuta. Bredekamp ne ha evidenziato la vitalità materiale, la capacità di riverbero sulla nostra percezione psichica:
Mentre la lingua parlata è propria dell’uomo, le immagini gli vengono incontro sotto il segno di una corporeità aliena: esse non possono essere ricondotte pienamente a quella dimensione umana cui devono la propria realizzazione, né sul piano emotivo né mediante azzardi linguistici E qui risiede il fascino delle immagini. Una volta prodotte, diventano autonome e incutono ammirazione e paura, sono cioè oggetti capaci di suscitare sensazioni fortissime.[12]
Tutto il testo de Gli anni di Ernaux gioca su un’ambiguità di fondo: da un lato riversare il magnetismo delle immagini sulla scrittura, dall’altro superare le immagini con la parola, nella consapevolezza che il carattere privato di tali immagini – sia che si tratti di fotografie di famiglia sia di immagini pubbliche che ritraggono divi del cinema e pubblicità – rivesta importanza e valore solo nell’associazione memoriale personalissima dell’autrice.
L’elenco iconico con cui si apre il libro riporta alcune visioni personali, cose che solo lei può avere visto in un certo momento della propria vita, altre sono invece immagini pubblicitarie, cartelloni del cinema, luoghi noti, visibili a molte altre persone. Si direbbe che questi ultimi assolvano la funzione di stabilire quel legame con la realtà esterna, quella testimonianza dell’essere stati nel mondo in un determinato tempo che la fotografia come referente e documento può assumere e di cui il racconto autobiografico ha bisogno per collocarsi entro coordinate spazio-temporali.[13] Inoltre questo tipo di immagini produce un effetto di realtà, poiché si tratta di immagini verificabili da chiunque.
Diverso è invece il ruolo di volta in volta affidato alle immagini che fanno parte del repertorio privato dell’autrice, ma il fatto che si trovino frammischiate merita qualche considerazione. La struttura dell’elenco è portante per il romanzo di Ernaux e sostenuta dall’uso di frasi che spesso sono puramente nominali. Per rendere il flusso del tempo, la materia contenuta dagli Anni per l’appunto, l’autrice francese fa un reiterato uso di elenchi che seguono un doppio criterio: quello della memoria personale e familiare e quello della storia nazionale francese ed extranazionale. I due livelli, lungi dall’essere separati, risultano intrecciati, con un procedimento che serve non solo ad ancorare la terza persona narrante, l’autrice, al proprio tempo, a vicende più grandi delle proprie, alla Storia che mette in prospettiva e allinea, ma anche a ridimensionare la portata individuale del vissuto; è come se Ernaux ad ogni pagina ci dicesse: «guarda com’è singolare questo mio ricordo, questo fatto peculiare avvenuto nella mia vita» e poi subito dopo trovasse il modo per smentirsi, per dire altrettanto convincentemente: «in fondo tutti i ricordi si assomigliano, quello che accadeva a me accadeva anche a migliaia di altre persone, più o meno nello stesso tempo».[14]
Ma l’elemento di maggior tendenziosità di questi elenchi è dato dal fatto che mettono insieme e sullo stesso piano immagini viste dall’occhio dell’autrice e immagini scattate da una macchina fotografica o da una cinepresa. In realtà, come vedremo, esiste una sottile differenza fra le due serie.[15]
Se la fotografia è, per sua stessa essenza, un motore di nostalgia, in Ernaux è soprattutto specchio di inappartenenza, di distanza. Guardarsi e guardare i propri cari senza riconoscerli significa prendere atto di come il tempo lavori sugli esseri umani. La fotografia funziona da specchio di una distanza che si misura nel rito di guardare le immagini di famiglia nei pranzi festivi che cadenzano Gli anni e registrano i cambiamenti generazionali:
Foto brunite passavano di mano in mano, il dorso macchiato da tutte le dita che le avevano toccate nel corso di altri pranzi, un misto di unto e caffè ormai fusi in un colore indefinibile.
In quei due sposi irrigiditi e austeri alle cui spalle scomparivano i vari invitati al matrimonio, disposti in più file davanti a un muro, non si riuscivano a riconoscere né i propri genitori né nessun altro. E anche in quel neonato dal sesso indefinibile, posato nudo su un cuscino, non si riveda più se stessi, ma qualcun altro, una creatura appartenente a un tempo muto e inaccessibile.[16]
E d’altronde la stessa distanza, lo stesso disincanto oggettivato si ritrovano nella descrizione della propria fotografia a un anno di età, considerata con il linguaggio catalografico e l’attenzione tipici dell’archivista:
È una foto virata seppia, ovale, incollata tra le pagine di un libretto dal bordino d’oro, protetta da un foglio goffrato, trasparente. Sopra, Photo Moderne, Ridel, Lillebonne (Senna Inferiore) tel. 80. Un neonato grassoccio dalla bocca imbronciata i capelli scuri a formare un ricciolo sulla testa, è seduto mezzo nudo su un cuscino al centro di un tavolo intarsiato. Lo sfondo sfocato, la ghirlanda a decorare la tavola, la camicia ricamata sollevata sul ventre – la manina nasconde il sesso – la bretella scivolata dalla spalla sulle braccia pienotte sono tutti elementi intesi a formare la rappresentazione pittorica di un amorino o un cherubino. Con ogni probabilità ogni membro della famiglia ha ricevuto una copia della fotografia e si è poi messo a cercare di stabilire da chi avesse preso il bambino. In questo documento d’archivio famigliare – che deve risalire al 1941 – è impossibile leggere altro oltre alla messa in scena rituale, modellata sui costumi della piccola borghesia, dell’entrata nel mondo.[17]
Altrove la descrizione di una fotografia di famiglia, anziché essere una statica pagina di analisi sociologica, diventa un motore narrativo vero e proprio, che apre a ritroso uno squarcio nel tempo e nella biografia sentimentale dell’autrice:
Foto a colori: una donna, un ragazzino sui dodici anni e un uomo, distanti l’uno dall’altro, disposti a triangolo su un piazzale polveroso, bianco di sole, con le ombre al lor fianco, davanti a un edificio che potrebbe essere un museo. A destra, l’uomo, preso di spalle, le braccia sollevate, tutto in nero con una giacca alla coreana, filma l’edificio. In fondo, al vertice del triangolo, il ragazzino, di faccia, in pantaloncini e maglietta con una scritta illeggibile, tiene in mano un oggetto scuro, forse l’astuccio della macchina fotografica. A sinistra, in primo piano di tre quarti, la donna, con un abito verde a vita alta, in uno stile tra il casual e l’hippie. In mano ha un librone spesso, forse la guida turistica. I capelli sono legati, tirati dietro le orecchie, il volto pieno e indistinto a causa della luce. Sia la donna che il bambino sembrano essere stati colti mentre camminavano, devono essersi voltati sorridendo all’ultimo momento richiamati da chi è dietro all’obiettivo. Sul retro: Spagna, luglio ’80. Lei è la moglie e la madre di questo piccolo nucleo famigliare, il cui quarto membro, il figlio maggiore adolescente, è quello che ha scattato la foto. I capelli tirati, le spalle curve, le pieghe informi del vestito indicano, nonostante il sorriso, stanchezza e indifferenza al desiderio di piacere. Lì, in pieno sole, in quel luogo non identificabile di un percorso turistico, probabilmente in lei non c’è spazio per alcun pensiero al di fuori della bolla familiare che con il marito scarrozza, da un Parador Hotel a un bar di tapas passando per i siti storici classificati con tre stelle dalla guida, a bordo di una Peugeot 305 che temono di trovare con le gomme bucate dall’ETA. In quel consesso privato all’aria aperta, la testa sgombra dalle preoccupazioni multiformi di cui la sua agenda porta le tracce succinte “cambiare le lenzuola” “ordinare l’arrosto”, “consiglio di classe” eccetera – e perciò lasciata in balia di una coscienza esasperata, non riesce sin da quando sono partiti dall’hinterland parigino sotto una pioggia battente, a disfarsi del suo dolore coniugale, un accerchiante misto di impotenza, di risentimento e di abbandono. Un dolore che filtra il suo rapporto con il mondo. Accorda ai paesaggi soltanto un’attenzione distante, si limita a considerare – quando osserva le zone industriali all’entrata della città, il profilo di un nuovo centro commerciale e la scomparsa degli asinelli – quanto sia cambiata la Spagna dalla morte di Franco. Tra i tavolini dei caffè all’aperto presta attenzione soltanto alle donne che ritiene abbiano un’età compresa tra i trentacinque e cinquant’anni, cerca sui loro volti i degni della felicità o dell’infelicità, «come fanno loro»?[18]
In questo brano la fotografia aziona uno scorrimento temporale, e diventa un vero e proprio dispositivo per l’affabulazione: dalla descrizione degli abiti e delle posture l’autrice non ricava solo osservazioni generali ma s’infiltra nelle pieghe della vita familiare della donna che era all’epoca: madre di due figli adolescenti, moglie insoddisfatta del proprio matrimonio, forse in cerca di una via di fuga. Qui la scrittura svolge un lavoro che l’immagine non potrebbe fare, perché la fotografia è un manufatto che si dispiega nello spazio – un insieme di pigmenti chimici stampati su carta preparata – mentre la scrittura si dispiega nel tempo, secondo la classica definizione del Laocoonte di Lessing (1766).
D’altronde le fotografie di per sé non narrano, trattengono apparizioni istantanee. Il tipo di memoria che innescano ne Gli anni può essere episodica, come nei ritratti, o più largamente estesa, una memoria che potremmo chiamare semantica poiché richiama a sé un prima e un dopo, un intreccio di fatti e riflessioni rispetto al momento ripreso, come nell’ultimo esempio. Tuttavia per Ernaux l’evocazione descrittiva, anche quando funge da dispositivo per dipanare storie, non è mai cruciale, perché le fotografie che sceglie ritraggono momenti ordinari e quasi trascurabili della vita. Queste immagini ci trascinano dentro effimere apparizioni, dalle quali possiamo solo arguire o dedurre i fatti importanti, le scelte avvenute, i cambiamenti. Ne risulta un racconto assolutamente frammentario, per sineddoche o metonimia, una fotografia vale per manciate di anni, nascite, cambiamenti di lavoro, di posizione, di stato di animo che non vengono raccontati, ma allusi.
Al tempo stesso tramite la fotografia i ricordi diventano apodittici, l’ekphrasis avviene sempre in un presente della scrittura che rende in un certo senso incontestabile il rapporto con la realtà e con la verità. La fotografia diventa così un inconfutabile pezzo di mondo, contiene la verità proprio perché afferrata nella sua casualità e frammentarietà.
Ernaux applica, come dicevamo, una distinzione fra le immagini, tra fotografia, oggetto di un archivio personale reale o immaginario che sia, e immagine in senso interiore:
le immagini reali o immaginarie, quelle che persistono anche nel sonno
le immagini di un momento bagnate da una luce che è soltanto loro
Svaniranno tutte in un colpo solo, come sono svanite a milioni le immagini che erano dietro la fronte dei nonni morti da mezzo secolo, dei genitori morti anch’essi. Immagini cin cui comparivamo anche noi, bambine, tra altri esseri scomparsi prima ancora che nascessimo, nella stessa maniera in cui ricordiamo i nostri figli piccoli assieme ai loro nonni già morti, ai loro compagni di scuola. E così un giorno saremo nei ricordi dei figli in mezzo a nipoti e persone che non sono ancora nate. Come il desiderio sessuale, la memoria non si ferma mai. Appaia i morti ai vivi, gli esseri reali a quelli immaginari, il sogno alla storia.[19]
Questa pagina che si apre con due frasi nominali sciolte sintatticamente, anche se soggetto del paragrafo che le segue dal quale sono staccate da un spazio tipografico, condensa l’ambivalenza con cui Ernaux guarda alle immagini: la frase sospesa, senza punto, come se cercasse di prolungare attraverso le parole l’incanto che il reale assume talvolta nella fissità visiva, è smentita poco dopo dall’enunciazione che tutte queste immagini spariranno.
Cosa sono dunque «le immagini di un momento bagnate da una luce che è soltanto loro»? Quella stessa luce che bagna gli scatti del fotografo Jansen protagonista del romanzo Chien de Printemps di Patrick Modiano, la contemplazione dell’illusoria eternità di ciò che ha preso forma e sembra contenere il passato e la vita, proprio perché testimonianza di vita, connessione fra lo sguardo e la memoria.[20] Non è infatti solo il desiderio sessuale a non fermarsi mai, come la memoria, ma anche la luce che attraversa e trasporta le immagini – verrebbe da usare la parola platonica eidola – e che tramite la fotografia ne trattiene letteralmente l’emanazione luminosa.[21]
Al tempo stesso per Ernaux il deposito di tali immagini è per sua natura inaffidabile e perituro: la nostra memoria oltre a non stare mai ferma è anche destinata a fondersi a quella di chi ci sopravvivrà, per un breve tempo, mischiandosi a quella di chi ci ha preceduto, in una promiscuità che smentisce il carattere di unicità e di traccia singolare che l’immagine, in particolare quella fotografica, vorrebbe detenere.
Luce è il lemma che ritorna significativamente alla fine de Gli anni:
Quell’ambizione non l’ha abbandonata, ma adesso vorrebbe più che altro poter cogliere la luce che bagna volti ormai invisibili, tavole imbandite di vivande scomparse, quella luce che già c’era nelle narrazioni domenicali dell’infanzia e che non ha smesso di depositarsi sulle cose vissute, una luce anteriore. Salvare[22]
In uno dei numerosi momenti metanarrativi del testo, Ernaux dichiara di aver rinunciato a forgiare una lingua speciale, come quella dei sogni, che potesse rendere la complessità del suo sentire e del suo essere in mezzo al mondo, ma ciò a cui non ha rinunciato e che ancora la trattiene è la luce di quelle che sono visioni tutte interiori, da salvare. Queste apparizioni richiamate da fotografie e appunti non coincidono necessariamente con essi. E di nuovo lo spazio vuoto tipografico, dopo un infinito sciolto – «Salvare» – nell’abolizione della punteggiatura e degli snodi sintattici, consente a Ernaux di portarsi sul confine dell’intraducibilità fra un medium e l’altro: tra visione e scrittura.
Emerge tutta la differenza che separa il trattamento proustiano del tempo in relazione alle immagini fotografiche e quello messo in opera da Ernaux: per quest’ultima la fotografia è un innesco narrativo o l’equivalente della scena e, là dove l’immagine vorrebbe entrare con la sua materialità vitale che risponde a un’intensità interiore, il flusso della scrittura si fissa in un bagliore, in un bagno di luce intraducibile, mentre per Proust l’immagine deve essere rivelazione, perciò la fotografia rischia sempre di essere deludente: «Adesso mi sforzavo di trarre dalla mia memoria altre istantanee, segnatamente istantanee che essa aveva scattato a Venezia, ma bastava questa parola a rendermela noiosa come una mostra di fotografie».[23]
La scelta di non mostrare le fotografie è coerente alla fiducia di Ernaux nella scrittura come mezzo espressivo sufficiente, ma al tempo stesso postula oggetti esterni alla narrazione dai quali dipende la veridicità e l’attendibilità stessa del suo racconto. Ci troviamo dunque di fronte a un esteso espediente di quello che Nicola Gardini ha definito la «lacuna» del testo che ne invera il contenuto, perché non essendo compresa ma esterna ad esso e per noi in qualche modo inverificabile ci obbliga a credere ancora più fortemente alla scrittura che ad esso si relaziona.[24] In sostanza le fotografie sarebbero la realtà alla quale la scrittura fa riferimento. D’altra parte Ernaux è ben consapevole che la fotografia ha finito per sostituirsi alla realtà:
Il clic saltellante e rapido del mouse scandiva la misura del tempo. […] La ricerca del tempo perduto attraverso il web. Gli archivi di tutte le cose passate che non immaginavamo neanche di poter ritrovare un giorno ci venivano incontro nell’istante stesso in cui le cercavamo. La memoria era diventata inesauribile, ma la profondità del tempo – quella che ci veniva trasmessa dall’odore e dall’ingiallimento della carta, dal fruscio delle pagine, dalla sottolineatura di un paragrafo a opera di una mano sconosciuta – era scomparsa. Eravamo in un presente infinto. Lo volevamo ‘salvare’ di continuo, in una frenesia di foto e di filmati di cui facevamo un rinnovato uso sociale. Centinaia di immagini disperse ai quattro angoli del nostro mondo di amicizie trasferite sul computer e archiviate in cartelle che finivamo per non aprire quasi mai. Ciò che contava era di aver scattato la foto, aver captato e raddoppiato l’esistenza, averla registrata in diretta, i ciliegi in fiore, una camera d’albergo a Strasburgo, un neonato. Luoghi, incontri, scene, oggetti, era la conservazione totale della vita. Con il digitale esaurivamo la realtà.[25]
La sua scrittura mimetica, nell’emulare la bidimensionalità, la frammentarietà, il tratto epifanico e casuale dell’oggetto fotografico, ha adottato anche la serialità tipica dei procedimenti digitali. L’esito formale è particolarmente riuscito nel proporre un’autobiografia spossessata di sé, una sorta di moderna versione delle effemeridi, tavole di valori in cui le vicende individuali si misurano sulla prossimità e comparabilità con il fluire della storia e della statistica, ma l’annegare della responsabilità personale in un noi collettivo o in un flusso che tutto sovrasta è un’operazione meno neutra e ineluttabile di quanto appaia.
Annie Ernaux non è l’unica autrice nata durante la seconda guerra mondiale a essere approdata a una posizione che guarda al presente come a un tempo ormai fuori dalla Storia, dominato da forze che annichiliscono la volontà individuale o la rendono irrilevante, ma se questa prospettiva ha senso dal cono di un Novecento che ha esaurito il proprio mandato e significato nello svelare il lato fagocitante del capitalismo e l’inerzia delle democrazie, può apparire riduttiva rispetto al movimento stesso della vita e alle sue possibili storie.[26]
1 Les années è uscito in Francia per Gallimard nel 2008 mentre l’edizione italiana è apparsa nel 2015 per i tipi de L’Orma Editore (Roma) con la traduzione di Lorenzo Flabbi, di poco preceduta da Il posto (La place, Paris Gallimard, 1983), uscito nel 2014 (sempre grazie a L’orma Editore). La honte è stato pubblicato da Gallimard nel 1997.
2 Stando alla definizione di P. Lejeune, Il patto autobiografico [1975], Bologna, Il Mulino, 1986, p. 13, l’autobiografia è il racconto retrospettivo che un individuo reale fa della propria esistenza, quando mette l’accento sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della propria personalità. L’istanza disattesa da Ernaux è proprio la storia della propria personalità, che rimane opaca.
3 Cfr. G. Mazzoni, Autobiografia ed estraneità, pubblicato in http://www.alfabeta2.it/2015/07/26/autobiografia-ed-estraneita/; A. Sarchi, Annie Ernaux. Gli anni, http://www.laricerca.loescher.it/letteratura/1128-annie-ernaux-gli-anni-una-recensione.html .
4 A. Ernaux, Gli anni [2008], trad. it. di L. Flabbi, Roma, L’Orma Editore, 2015, pp. 102-103.
5 A. Ernaux, Il posto [1983], trad. it. L. Flabbi, Roma, L’Orma Editore, 2014, p. 21.
6 L’ekphrasis di fotografie di famiglia nella narrativa contemporanea è stata analizzata da M. Hirsch, The familiar Gaze, Hannover and London, University Press of New England, 1999 e da S. Albertazzi, Foto di famiglia e istantanee amatoriali nella letteratura contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2010.
7 Susan Sontag sottolinea il carattere intrinsecamente commemorativo insito nell’immagine fotografica: «Il nostro senso oppressivo della caducità di ogni cosa si è ancora più acuito da quando le macchine fotografiche ci hanno dato modo di ‘fissare’ l’attimo fuggente» (S. Sontag, On Photography [1973], trad. it. di E. Capriolo, Torino Einaudi, 1978, p. 17). Ma già Italo Calvino in un racconto del 1958, L’avventura di un fotografo, scriveva: «La realtà fotografata assume subito un carattere nostalgico, di gioia fuggita sull’ala del tempo, un carattere commemorativo, anche se la foto è dell’altro ieri. E la vita che vivete per fotografare è già in partenza commemorazione di se stessa» (I. Calvino, Gli amori difficili, in Id., Romanzi e racconti, ed. diretta da C. Milanini, a cura di M. Barenghi, B. Falcetto, Milano, Mondadori, 2004, p. 1100).
8 Cfr. V. Sperti, Fotografie e romanzo. Marguerite Duras, George Perec, Patrick Modiano, Napoli, Liguori, 2005.
9 Ivi p. 132: «Il mio procedimento non è di scrivere per cercare di conoscermi e fare dell’introspezione. Piuttosto è, con dei poveri elementi casuali – i genitori che avevo avuto, la mia nascita dopo la guerra … – trovare un po’ di magnetismo, in quegli elementi che sono privi in sé di interesse, rinfrangerli attraverso una specie di immaginario. L’impresa autobiografica mi è sempre parsa una specie di illusione, a meno che avesse una dimensione poetica come avviene in Nabokov di Speak, memory. Il tono autobiografico ha qualcosa di artificiale, poiché prevede sempre una messa in scena. Per me, si tratta piuttosto di un’impresa artistica, una messa in forma di elementi insignificanti».
10 Si veda L. Haverty Rugg, Picturing ourselves. Photography and Autobiography, Chicago, The University of Chicago Press, 1997.
11 Cfr. V. Sperti, Fotografie e romanzo. Marguerite Duras, George Perec, Patrick Modiano, p. 45; R. Krauss, Le photographique. Pour une théorie des écarts, Paris, Macula, 1990.
12 H. Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico [2010], trad. it. di S. Buttazzi, Milano, Raffaello Cortina, 2015, p. 10. Per una riflessione sullo specifico fotografico cfr. T. Serena, ‘La materialità delle fotografie: una questione ermeneutica’, in Il Restauro della fotografia. Materiali fotografici e cinematografici, analogici e digitali, a cura di B. Cattaneo, Firenze, Nardini, 2012, pp. 15-26.
13 Cfr. Ph. Dubois, L’acte photographique, Bruxelles, Editions Labor, 1983, p. 98.
14 Marguerite Duras ne L’amant rileva come sia proprio la fotografia a livellare l’individualità facendo apparire tutti uguali: «Tous le gens photographiés, j’en ai vus beaucoup, donnaient presque la meme photo, leur ressemblance était hallucinante» (M. Duras, L’amant, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 118).
15 Si veda ad esempio il passo seguente, dove distingue fra ricordo come qualcosa di inalienabile e personale e l’accumulo di segni esterni del tempo: «E avevamo in noi una grande memoria confusa del mondo. Di pressoché ogni cosa conservavamo soltanto parole, dettagli, nomi, tutto ciò che faceva dire sulla scia di George Perec “mi ricordo”. Il rapimento del barone Empain, le praline Picorettes, i celebri calzini di Bérégovoy, il progetto di legge Devaquet, la guerra delle Falkland, la polvere di cacao da sciogliere nel latte della Benco. Ma non erano veri ricordi, continuavamo a chiamare così qualcosa d’altro: erano i segni di un’epoca» (A. Ernaux, Gli anni, p. 140).
16 Ivi, p. 29.
17 Ivi, p. 19.
18 Ivi, p. 153
19 Ivi, p. 13.
20 P. Modiano, Chien de Printemps, Paris, Seuil, 1993, p. 11.
21 M. Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographique, Paris, Seuil, 1987.
22 A. Ernaux, Gli anni, pp. 264-265.
23 R. Ceserani, L’occhio della Medusa. Fotografia e letteratura, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 57.
24 N. Gardini, Lacuna. Saggio sul non detto, Torino, Einaudi, 2015, pp. 17-20 e 46-55.
25 A. Ernaux, Gli anni, p. 245.
26 Significativa la risposta data dalla scrittrice alla domanda posta da Giorgio Biferali con riferimento agli attentati parigini del 13 novembre 2015 rivendicati dallo Stato Islamico, in una intervista pubblicata su Il Messaggero e poi riedita in versione più lunga sul blog Le parole e le cose, http://www.leparoleelecose.it/?p=21666 : «G. B.: “Si è detto spesso che certi fatti, così imprevedibili, stravolgono la nostra quotidianità e ci costringono a vivere nella paura. Secondo lei, come dovremmo reagire?” A. E.: “Vivremo come prima. Di fatto ciò che mi colpisce rispetto agli attentati del 1986 e del 1995 compiuti dal Gruppo Islamico Armato algerino in Francia, di ben minore portata, è l’assenza di paura delle persone, la volontà di non cambiare nulla nel proprio modo di vivere”».