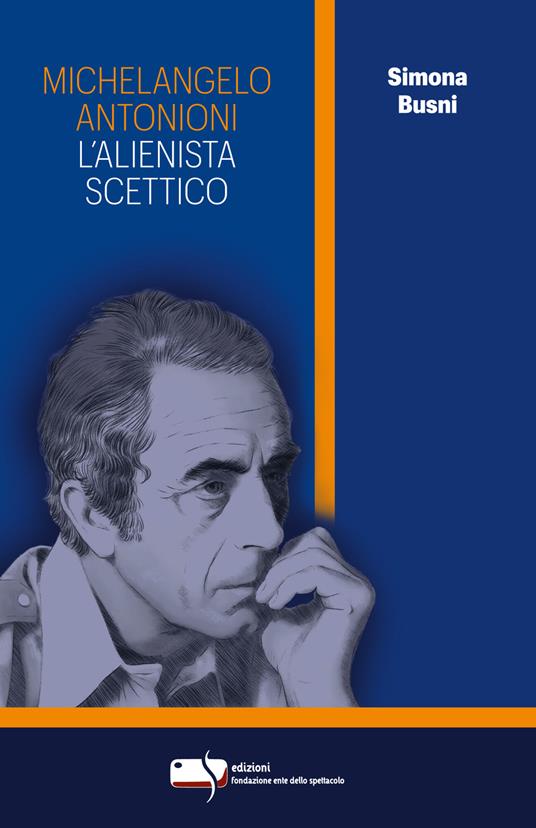
In una sequenza famosa di Il sorpasso di Dino Risi (1962), i protagonisti Bruno (Vittorio Gassman) e Roberto (Jean-Louis Trintignant) corrono in auto lungo la via Aurelia e ascoltano Vecchio frac di Domenico Modugno. Bruno commenta: «A me ‘sto Vecchio frac me fa impazzi’. Perché pare una cosa da gnente e invece aho’, c’è tutto. La solitudine, l’incomunicabilità, e poi quell’altra cosa, che va de moda oggi… la… l’alienazione, come nei film de Antonioni. L’hai visto L’eclisse?». Roberto inizia ad abbozzare una risposta, ma Bruno riprende deciso: «Io c’ho dormito, ‘na bella pennichella. Bel regista, Antonioni. C’ha una Flaminia Zagato. Una volta sulla fettuccia di Terracina m’ha fatto allunga’ il collo». La tentazione di leggere in questo dialogo una sorta di gioco post-moderno ante litteram tra cultura alta e cultura bassa è forte, ma muoverebbe in una direzione diversa da quella suggerita dal saggio di Simona Busni (Roma, Edizioni Ente dello Spettacolo, 2019) del quale vorrei scrivere. E dunque, mi limito a notare come nello spazio breve di poche battute Risi e gli sceneggiatori Ettore Scola e Ruggero Maccari abbiano saputo condensare i luoghi comuni che più spesso circolavano – e ancora si ascoltano – sul cinema del regista ferrarese: la crisi dei sentimenti come atmosfera narrativa pervasiva e asfissiante, la cupa pesantezza dei dialoghi, e più di tutti l’alienazione.
Fino dal titolo del volume, Busni è ferma nel tenere lontano quegli stereotipi. Così la alienazione si trasforma, con uno slittamento all’apparenza sottile ma decisivo, in un attributo, «alienista», al quale l’autrice accosta l’aggettivo «scettico», aprendo ai territori imprevisti di medicina e filosofia. Alienista è infatti colui che è «attento osservatore di ciò che è Altro, in tutte le sue forme e declinazioni» (Busni 2019, p. 81) giacché, continua Busni, l’occhio di Antonioni si muove «sulle linee di confine, sugli orizzonti, sulle fratture, sui flussi» (ivi, p. 83) che segnano i corpi degli individui e li allontanano dalla compattezza normativa per aprirli verso la pluralità di elementi dei quali sono composti e che dentro quei corpi si arruffano. Come l’alienista studia i sommovimenti della mente, così, suggerisce l’autrice, Antonioni si sporge verso la matassa complicata della psiche nel tentativo di esplorarne i meandri, camminando lungo la linea sottile e sovente spezzata che definisce la personalità.
Da qui una delle parole chiave che segnano il percorso del saggio: ‘groviglio’. Busni riprende uno dei saggi seminali dedicato a Michelangelo Antonioni, Il discorso dello sguardo di Lorenzo Cuccu (Pisa, Edizioni ETS, 2014 [1990]), e ne raccoglie l’idea della natura processuale e dinamica degli sguardi. Per l’autrice l’architettura visiva dei film del regista è fondata infatti proprio su un «groviglio di sguardi» (Busni 2019, p. 47). L’approccio poco ortodosso alla grammatica cinematografica – i campi vuoti, le false soggettive – e al procedere del racconto, che spesso non si chiude, o non si chiude del tutto, al termine della pellicola – fa sì che guardare, in Antonioni, non sia mai qualcosa di scontato. Scalzato dalla postazione di occhio onnipotente, chi ne osserva le immagini sente di occupare un altrove dal quale si dipartono mille prospettive possibili, nessuna della quali esauriente ma tutte parziali, sfalsate rispetto a un centro che appare elusivo: «è come se il soggetto – da intendersi anche nelle declinazioni di personaggio o di narratore – smarrisse la sua centralità logica, il suo primato sensoriale, e restasse confinato in una dimensione periferica, estremamente ramificata, piena di transiti e biforcazioni» (ivi, p. 50).
Alla visione si accosta allora il tatto, in un groviglio sensoriale che attraversa i modi della fotogenia. In una pagina molto citata – pour cause – Antonioni evoca la fotogenia attraverso una serie di superfici che l’immagine sembra sfiorare, lasciando da parte il «fatto»:
Il cielo è bianco. Il lungomare deserto. Il mare vuoto e senza calore. Gli alberghi semichiusi e bianchi. Su una delle sedie vuote della Promenade des Anglais a Nizza è seduto il bagnino, un negro con la maglietta bianca. Il sole fatica a uscire dal leggero strato di nebbia, la solita di tutti i giorni. Non c’è nessuno sulla spiaggia, tranne un bagnate che fa il morto a pochi passi dalla riva […]. Basta guardarlo, il bagnante, per capire che è morto. […] Supponiamo di dover sceneggiare un pezzo di film sulla base di questo avvenimento, di questo stato d’animo. Per prima cosa io proverei a togliere dalla scena il «fatto», a lasciare soltanto l’immagine descritta […]. In quel lungomare così bianco, in quella figura solitaria, in quel silenzio, c’è secondo me una forza straordinaria. Il fatto qui non aggiunge nulla, è un di più (M. Antonioni, ‘Il fatto e l’immagine’, ora in Fare un film è per me vivere. Scritti sul cinema [1994], a cura di C. di Carlo e G. Tinazzi, Venezia, Marsilio, 2009 pp. 50-52).
In un’altra sua pagina il regista evoca la fotogenia del vento: «com’è fotogenico il vento!» (ivi, p. 54). Per il regista di Ferrara la fotogenia è questione di pelle, e di superfici – come lo era del resto per Jean Epstein, che su questo snodo teorico ha appoggiato il suo pensiero e la pratica del cinema. Il vento che accarezza i muri delle case, il bianco del cielo, la porosità della polvere che filtra la luce, lo sciabordìo delle onde: vedere, toccare, ascoltare, in una confusione di sensazioni che compongono le immagini e ne definiscono la qualità profonda. Di fatto si delinea in Antonioni una nuova percezione che se fa aggio sullo scetticismo – di qui parte del titolo del volume – per mettere in dubbio la chiarezza dei confini di quello che si percepisce, d’altro canto suggerisce l’apparire di una modalità sinestesica della visione: lo sguardo si fa tattile e sonoro e quasi brama di assimilare, di divorare ciò che osserva.
Ma questa sorta di ipervisione lascia affiorare il mistero delle cose – in un’altra parola chiave, ‘enigma’. Il film nasce dallo scacco della visione, e da una superficie vuota, misteriosa, muta. Scrive ancora Antonioni:
Londra 1952. Un vicolo cieco. Case di mattoni anneriti. Un paio di persiane dipinte di bianco. Un fanale. Un tubo di grondaia verniciato di rosso, molto lucido. Una motocicletta coperta da un telo, perché piove. Voglio vedere chi passerà per questa strada […]. Aspetto tre ore e mezza. Il buio comincia a disegnare il tradizionale cono di luce del fanale quando me ne vado senza avere visto nessuno. Io credo che questi piccoli fallimenti, questi movimenti vuoti, questi aborti di osservazione, siano tutto sommato fruttuosi. Quando ne abbiamo messi insieme un bel po’, non si sa come, non si sa perché, viene fuori una storia. Il soggetto del Grido mi venne in mente guardando un muro (M. Antonioni, ‘Prefazione’ a Sei film, ora in Fare un film è per me vivere, cit., pp. 57-58).
L’attesa mancata di un personaggio, una storia che non inizia: la modalità scettica del racconto disegna uno sguardo che si ingrana sulla superficie delle cose – la grondaia e la motocicletta lucide di pioggia, i mattoni ruvidi e anneriti, un muro – e da lì sgorga il film, che lascerà irrisolto il mistero del mondo – ancora la postura scettica – ma saprà scorgere la presenza di un soggetto imprevisto: le figure femminili.
L’immagine, difatti, resta misteriosa. Basta pensare a Blow Up e alla partita a tennis che chiude il film, enigmatica nel suo statuto reale e illusorio insieme, e al fallimento non solo della detection che sorregge la trama ma della indagine al cuore dell’immagine:
Sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà, assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà» (ivi, pp. 61-62).
Da questo enigma emergono i corpi delle donne. Soggetti imprevisti, come ha visto Lucia Cardone (‘Il Soggetto Imprevisto e la «tetralogia dei sentimenti» di Michelangelo Antonioni’, in L. Cardone, S. Lischi [a cura di], Sguardi differenti. Studi in onore di Lorenzo Cuccu, Pisa, Edizioni ETS, 2014, pp. 139-150), le figure femminili incarnate da Monica Vitti, Lucia Bosè, Jeanne Moreau sono, in una eco di Jacques Lacan, misteri: entità inconoscibili, corpi materici e senzienti capaci di una inedita profondità di affetti. Busni segue il modificarsi delle presenze muliebri in Antonioni, a partire dalla constatazione del loro pressante affacciarsi nelle storie narrate, apparizioni sproporzionate e quasi infestanti. Le prime eroine del regista sono allora «reinterpretazioni, in chiave modernista, della femminilità doppia del melodramma, ossia di tutte quelle madonne a due volti nate tra le pagine del feuilleton e sui palcoscenici dell’opera lirica che si sono poi reincarnate nei corpi-paesaggio delle maggiorate italiane anni Cinquanta» (Busni 2019, p. 94). Sono donne che muovono nel territorio dell’ambiguità, di una zona grigia tra realtà e posa, «identità multiple, stratificate, corpi traslucidi che si incarnano di continuo nell’ombra, nel simulacro, nel riflesso, nella cornice, nella citazione, nell’alterità» (ivi, p. 98): ancora una questione di superfici che si fanno pelle opaca e volti impenetrabili di «sirene incantatrici» (ivi, p. 99) abitanti di un altrove radicale.
Da L’avventura in poi le protagoniste divengono personaggi-guida, «filtro sottile e sincero» (M. Antonioni, ‘Un documentario sulla donna’, in Il mio Antonioni, a cura di C. Di Carlo, Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, 2018, p. 111) attraverso il quale provare a interrogare una realtà altrimenti inaccessibile. Inscritte nei corpi nuovi di attrici slanciate e sottili – Vitti, Moreau, Lea Massari – le personagge antonioniane divengono tali perché radicalmente diverse, irriducibili alla norma patriarcale: volti fotogenici e perciò incantevoli e misteriosi, corpi impossibili da penetrare che lo sguardo dell’alienista pedina nella speranza «di afferrare in un’unica visione tattile il groviglio stratificato delle loro figure» (Busni 2019, p. 105). Anna, Claudia, Lidia passeggiano, flâneuses moderne intente a sfiorare, ad appoggiarsi, a sentire le superfici per conoscerle e come assaporarle nella dimensione affettiva dei corpi. Forse è in questo contrasto tra sguardo cieco maschile, segnato dalla ragione scientifica, e sensibilità materica del corpo femminile, capace di aprire e includere l’alterità facendola baluginare come dietro a un velo – altra superficie fotogenica e inafferrabile – sta l’intuizione più feconda di Simona Busni, sulla quale mi piace chiudere:
Corpo come ricettacolo esistenziale di infinite aperture e soglie, che l’occhio dell’alienista scettico prova a esplorare, a esaminare con la perizia del medico specialista, nel tentativo di conoscere l’Altro – sempre oltremodo ineffabile, inaccessibile – senza arrivare a riconoscerlo mai e, conseguentemente, senza riconoscere mai se stesso. Corpo come velo deputato a celare, a nascondere, a seppellire, ciò che normalmente dovrebbe essere esposto, offrendosi alla nostra vista e alla nostra comprensione (un’immagine, un aspetto, una parola, un pensiero, una verità) (ivi, p. 114).