Quando un’opera sembra in anticipo sulla sua epoca, semplicemente la sua epoca è in ritardo su di lei.
J. Cocteau
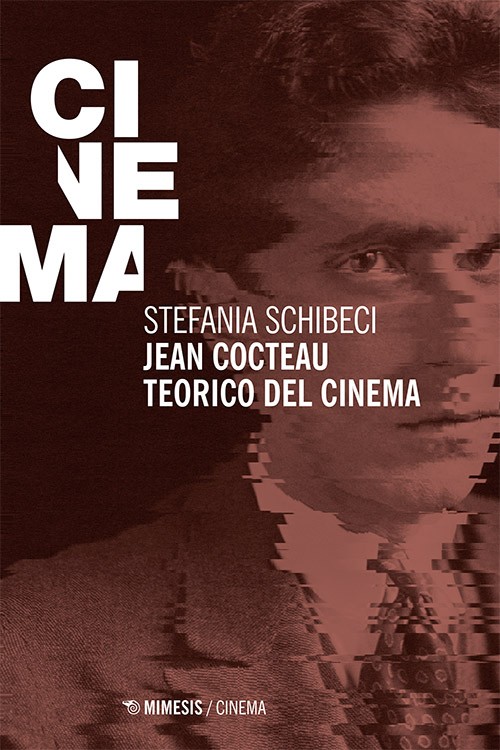
Nell’apparente instabilità epistemologica degli ultimi tre decenni dalla teoria alle ‘teorie del cinema’, la pubblicazione del volume Jean Cocteau. Teorico del cinema da parte della casa editrice Mimesis nel 2018 poteva sembrare solo un’operazione storico-retrospettiva. Il lavoro di Stefania Schibeci, docente di Pittura e Arti del XX, è la prima monografia italiana sul tema dedicata all’artista ma getta le basi per un ponte verso il quadro teorico del secondo Novecento e in parte verso quello contemporaneo.
L’attualità della pubblicazione è legata senz’altro alla scelta della figura di Cocteau: poeta, pittore, drammaturgo, romanziere, disegnatore, pittore, regista, attore, ecc. Una personalità che ha incarnato l’apertura interartistica del secolo scorso e anticipato ‒ come sembra emergere da questo contributo ‒ alcune riflessioni teoriche successive di tipo filosofico, fenomenologico e mediale intorno alle immagini in movimento. Anche se si avverte, forse, la mancanza di alcune connessioni suggerite al lettore proprio da alcuni temi affrontati nel testo. Riprendendo, per esempio, gli elementi centrali della sua teoria sul cinema come veicolo insieme alle altre arti della «poésie» (p. 11), conoscenza del mondo attraverso la soggettività del poeta, e la sua specificità come scrittura per immagini capace di «rendere visibile l’invisibile» (p. 13), sarebbe stato interessante accogliere tra le pur ricche relazioni del testo somiglianze e differenze con le idee di Pasolini da un lato e con la filosofia di Merleau-Ponty dall’altro.
In tre capitoli, dedicati al profilo tematico-concettuale ed (est)etico, agli assunti della sua teoria cinematografica e alla loro applicazione ad alcuni dei suoi film ‒ in cui la poesia e la figura del poeta si fanno anche tema unificante e portante come Le Sang d’un poète e la «trilogia orfica» (La Belle et la Béte, Orphée, Le Testament d’Orphée) ‒ l’autrice ne delinea la visione del cinema strettamente intrecciata alla dimensione esistenziale, creativa e riflessiva.
Il recupero di Cocteau dalle ‘teorie sommerse’, formula pensata da Francesco Casetti, a partire da un insieme di pensieri, articoli, omaggi e note sparse ‒ raccolti però in gran parte nel 1973 in Du cinématographe ‒ non è nuovo in realtà. Si cominciò a parlare della sua figura come teorico del cinema già nel 1988 con il secondo volume dell’antologia French Film Theory and Criticism (1907-1939) di Richard Abel e in tempi più recenti con il contributo monografico Jean Cocteau di James Williams nel 2006. Testi che avevano dedicato all’autore alcune sezioni al loro interno, delineandone sinteticamente gli elementi portanti. Il libro di Stefania Schibeci, però, fa dell’aspetto teorico il focus centrale e lo trasforma in un motivo di approfondimento per offrirlo come chiave di lettura del suo stesso cinema. Mette così in evidenza in modo paradigmatico l’inscindibilità tra aspetto teorico e pratico, con una contestualizzazione più ampia che crea una serie di connessioni tra il milieu storico-culturale, il profilo artistico-biografico e il panorama della storia e delle teorie del cinema (per cui consigliamo una lettura estesa). Rispetto ai precedenti, quindi, l’attività teorico-pratica di Cocteau è proiettata indietro e in avanti lungo un continuum che prosegue fino all’apertura della prospettiva intermediale, che rappresenta uno dei principali contributi negli ultimi anni alla ricerca intorno alla sua figura, giustamente ripreso a partire dal lavoro di Caroline Surman nel 2012 (Cinéma et théâtre chez Jean Cocteau. Intérmedialité et estétique). L’approccio dell’autrice ricorda, così, il necessario legame tra vecchie e nuove teorie per continuare a problematizzare e arricchire la sensibilità di un dibattito che non può che avvicinarci all’oggetto delle nostre riflessioni, anche da prospettive diverse. Non trascura, poi, la necessità di considerare in toto i vari media, le forme e i generi affrontati da artisti pluri-talentuosi come Cocteau, di cui troppo spesso si tralascia l’importanza dell’unitarietà degli elementi in gioco.
Nato nel 1889, a pochi anni dalla ‘nascita del cinema’, di cui diceva ironicamente di esser stato testimone, fu come tanti scrittori della sua generazione un assiduo frequentatore delle sale, ricevendo una formazione visiva che segnò il suo immaginario e la sua attività interartistica. Il cinema diventò ben presto per Cocteau non soltanto un elemento tematico nella produzione letteraria, come ci spiega l’autrice, ma anche fonte di scambi linguistici tra il visivo, la letterarietà (come forma di sintassi astratta) e la teatralità attraverso la sovrapposizione intermediale dei procedimenti compositivi tra letteratura, cinema, pittura, disegno, animazione, balletto, ecc. Con le sue riflessioni si inserì nel dibattito intellettuale e poi dal 1930 con l’attività pratica tra quei registi che, con le loro scelte riflessive, contribuirono alla costruzione e teorizzazione del suo statuto. Fu così uno dei primi scrittori francesi a riconoscerne pionieristicamente la peculiare funzione artistica, come espressione dell’unica verità possibile per Cocteau che è quella soggettiva, interiore, veicolata dal poeta, memoria dei desideri e dei ricordi più profondi delle esperienze collettive quotidiane.
Nel suo «realismo irreale» (p. 106) riconobbe, secondo la studiosa, tutte le potenzialità di sviluppo future del cinema: uno «stile vero», «documentario» (p. 129), una finzione fantastica capace di dire il vero. Come il poeta diventa medium che può rivelare le meravigliose sfaccettature della realtà, nascoste dietro l’apparenza del visibile dal cieco riduzionismo dei nostri patterns percettivi. La costante messa a nudo delle contraddizioni del mondo attraverso l’«espirazione» (p. 20) dell’artista di una natura più profonda ‒ basta pensare alla dirompenza della sua dichiarata omosessualità e al tema dell’androginismo dell’artista nel suo pensiero ‒ fa di ogni opera un’«automitografia» (p. 111) non fine a sé stessa, ma difficile confronto per i contemporanei con l’alterità, in cui risiede la bellezza del diverso che è sempre «l’altra faccia di ciò che viene visto normale, che non è altro che il nostro stesso doppio» (p. 128).
Da qui la capacità di Cocteau di riconoscere la differenza e i limiti del «cinema» (p. 64), che non può attendere per ottenere i favori di un pubblico «anestetizzato di fronte a ciò che vede» (p. 54), rispetto al «cinématographe» (p. 64), mezzo sperimentale per artigiani, ‘anticineasti’ o poeti come lui, capace di sedimentare nel tempo attraverso il suo stile non solo lo spirito del poeta, destinato così a rinascere, ma anche quello di un’intera epoca.
Le ‘teorie di Cocteau’ si aprono infine a un insieme di riflessioni sulla spettatorialità, come esperienza di visione collettiva, e sullo sguardo.
La nostra nonostante quel che si creda, non è un’epoca visuale. Troppo rapida, troppo distratta, troppo istigata contro l’individuo. Non si sofferma più sul viso. L’espressione non la tocca. L’amore l’annoia. È meschina, distruttrice. Non venera che silhouette, che bersagli da tiri da fiera (p. 54).
Davanti alla visibilità intesa come moda, successo, ripetizione del già noto o convenzione superficiale, lamenta l’incapacità di abbandonarsi a una forma di comprensione immediata, senza filtri pregiudiziali, con la sospensione della propria incredulità di fronte alla meravigliosa allegoria del reale sullo schermo. Per questo la sperimentazione deve provocare una ferita dello sguardo della società, immergerla dentro la liminalità delle «zone» (p. 132): soglie intermedie per Cocteau tra le pieghe semiaperte del reale, in cui si svelano i limiti delle nostre percezioni, i rapporti e i ritmi più intimi delle cose umane. Il cinema, vera opera d’arte totale wagneriana ed estensione mediale della percezione sensibile, nella compenetrazione tra vita e morte, reale e irreale, visibile e invisibile data dalla natura stessa del dispositivo è la «macchina che ci autorizza a prenderci le libertà del sogno» (p. 90), lavorando proprio sui meccanismi dell’immaginario. Solo agendo sulle regole compositive e le abitudini ogni confine è destinato a (dis)piegarsi. Così da un lato è necessario provocare uno choc percettivo attraverso trucchi e strategie per andare oltre le apparenze riflesse in superficie: tutti i suoi film sono caratterizzati dalla sovrapposizione di media e generi, dall’uso di specchi come porte, apparizioni e sparizioni, ralenti, montaggi all’inverso e figure o temi destabilizzanti. Dall’altro bisogna produrre un’autoriflessione, in un momento di rottura dei limiti che circoscrivono la visione e percezione della realtà, per mantenere un rapporto con gli interrogativi umani. Il visibile si fa quindi strumento di conoscenza aperta dentro un momento di invisibilità, di cecità logica, perché irriducibile a un’unica interpretazione. La vera bellezza delle immagini così per Cocteau è quella che scuote un’attività intellettuale ed emotiva profonda, un’«erezione morale» (p. 26), in cui le immagini anticipando certe idee teoriche contemporanee lanciano una sfida di partecipazione dialettica, ci ‘chiedono qualcosa’: «odiami, bucami, fermati, fermatemi, è brutto, è atroce, grida il quadro moderno; ma il pubblico non fiata» (p. 55).
Ci sembra quindi che il testo riesca così ‒ anche se tra qualche imperfezione formale a mio parere ‒ ad avvicinarci sensibilmente al pensiero dello stesso Cocteau che in modo visionario si rivolgeva proprio ai futuri lettori-spettatori degli anni duemila che avrebbero potuto, più dei contemporanei, leggere, svelare e riattualizzare il senso generale della sua opera.
