La scelta di un testo come Wunschloses Unglück (1972)[1] per parlare di fototestualità e autobiografia/biografia nella scrittura di Handke può suscitare qualche perplessità. La presenza di immagini, a un’analisi ‘oggettiva’ del volume, risulta circoscritta alla sola copertina, che nella prima edizione raffigurava un paesaggio a tutta pagina e sulla quarta, immerso nel paesaggio, l’autore a figura intera, sostituito in quelle successive dallo stesso paesaggio ridotto a un riquadro, e poi da foto in vari formati dell’autore, come nelle edizioni di molte altre opere di Handke, o in alternativa dalla riproduzione fotografica di un chiostro di un convento. Tutte immagini che non sembrerebbero avere particolare attinenza con i fatti narrati, a conferma dell’atipicità dell’opera, che nonostante le sue anomalie si può leggere come un fototesto.
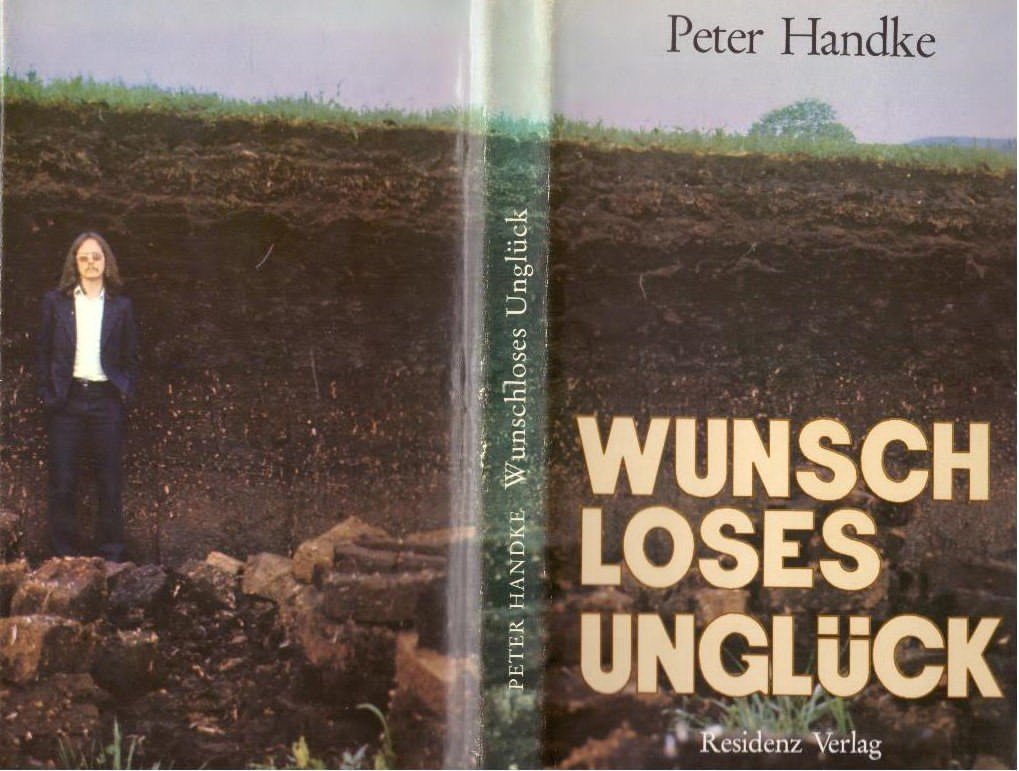
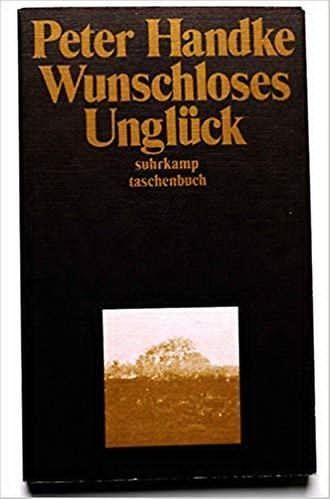
Il racconto di Handke inizia con un breve trafiletto tratto dalla Volkszeitung in cui si dà notizia della morte di una casalinga cinquantunenne, avvenuta nella notte tra un sabato e una domenica: si tratta di un suicidio per intossicazione da farmaci, e la donna morta è la madre di Peter Handke. Lo scrittore comunica al lettore il legame personale con la donna suicida dell’annuncio in modo scarno, incidentale, più che altro per spiegare l’antefatto da cui il racconto prende le mosse, e si preoccupa anche di rimarcare subito la distanza temporale che separa l’evento luttuoso dal momento in cui la narrazione ha inizio, un lasso di tempo di quasi sette settimane. Il racconto sarebbe nato dal «bisogno di scrivere di lei», prima che questo bisogno si trasformi nell’«ottuso mutismo» che aveva caratterizzato in un primo momento la reazione di Handke alla notizia della scomparsa del genitore. Irritabilità e insensibilità sono le emozioni che l’io narrante registra nel proprio animo al pensiero di ciò che è avvenuto, sensazioni ‘negative’, ma comunque ben accolte, perché capaci di sottrarlo al senso di torpore che altrimenti lo pervade: «Eppure desidero questi momenti, perché allora il torpore non c’è più e la testa diventa lucidissima. È un orrore in cui torno a star bene: niente più noia finalmente, un corpo che non fa più resistenza, non più lontananze faticose, l’innocuo passare del tempo» (WU, p. 9, S. 11).
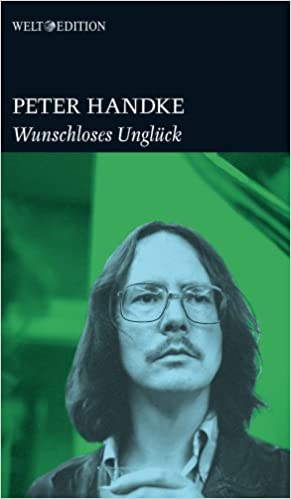
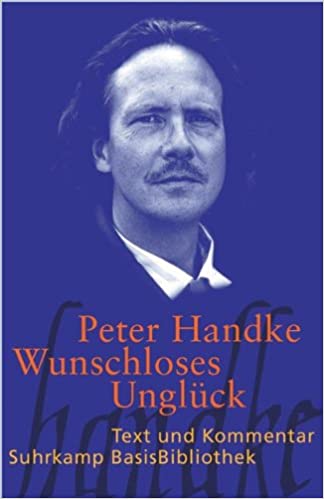
Il ricorso alla scrittura viene presentato da subito come un tentativo di reperire un rimedio terapeutico capace di neutralizzare quegli attacchi di panico che di tanto in tanto paralizzano i pensieri del narratore (WU, p. 10, S. 12), un farmaco capace di arginare ogni accesso patologico – quella paura che sconfina talvolta in un senso di irrealtà – tramite il ‘principio attivo’ della distanza. La scrittura viene presentata dunque come un filtro che presuppone non già immediatezza ma la capacità di frapporre una certa distanza rispetto all’evento, quella fisiologica distanza che nasce dal riaffiorare di ogni avvenimento nella memoria. I fatti avvenuti devono essere sottoposti inoltre a un qualche tipo di trasposizione letteraria per poter essere narrati;[2] per l’io narrante, uno scrittore di professione, scrivere è innanzitutto «fare della letteratura», significa trasformarsi in un soggetto «estraniato e reificato: una macchina che ricorda e che formula» (WU, p. 11, S. 13), capace di produrre quella «esattezza artistica» [genaue Künstlichkeit] che è modalità rappresentativa privilegiata di ogni storia, anche nel momento in cui questa dovesse essere una storia autentica, presa dalla vita reale.[3]
Le ‘motivazioni’ che spingono l’io narrante a raccontare la sua storia sono di ordine diverso, e rispondono allo stesso tempo a tre differenti tipologie di bisogni: la necessità di rendere omaggio alla persona scomparsa, quella di permettere a chi resta l’elaborazione del lutto, e in ultimo quella di rispondere a una sorta di mandato documentario, in virtù della propria condizione di figlio, di testimone presente ai fatti:
E scrivo la storia di mia madre, in primo luogo perché credo di sapere su di lei e su come maturò la sua morte più di qualunque intervistatore estraneo, che probabilmente risolverebbe senza fatica questo interessante caso di suicidio con una tavola sull’interpretazione dei sogni (religiosa, psicologica o sociologica), poi nel mio stesso interesse, perché, quando qualcosa mi dà da fare, torno a vivere; e infine perché come qualsiasi intervistatore esterno, anche se in altra maniera, vorrei fare di questa MORTE VOLONTARIA un caso (WU, p. 11, p. 13).
La minuzia di particolari con cui vengono introdotte le singole motivazioni non conferisce loro alcuna concretezza né le preserva dall’essere il frutto di una scelta arbitraria; più che motivazioni sono pretesti – come viene detto poco dopo – addotti per assecondare l’unico vero impulso che guida il narratore, «l’impulso di sempre alla scrittura» (WU, p. 11, S. 13). Le questioni fondamentali sono state a questo punto introdotte tutte quante. Andando a ritroso, si tratta di dare consistenza al suicidio della madre senza lasciare che questo sia derubricato a un fatto di cronaca come tanti, si tratta di dare un volto e una storia alla donna, di spiegare il suo gesto a partire da una buona conoscenza dei fatti, elemento questo che investe il figlio scrittore del ruolo di narratore onnisciente, e gli permette, attraverso la scrittura, di trovare una modalità legittima e più o meno efficace di gestione e rielaborazione del trauma. Le due istanze fondamentali e per certi versi antitetiche sono quella documentaria del resoconto e quella ‘poetica’, legata al grado più o meno significativo di finzione letteraria che anche questo racconto finisce per assumere, come ogni costruzione narrativa. La trasposizione letteraria dei fatti rischia tuttavia di spingersi oltre il ‘lecito’, così da ridurre tali fatti a semplice materia prima con cui inventare una storia, e di privarli in questo modo della loro autenticità biografica. Le astrazioni tendono infatti «a rendersi autonome. Dimenticano la persona da cui sono partite» sacrificandola a «un rituale letterario» che trasforma l’esistenza di un individuo in «un’occasione». La scrittura, annota Handke, deve essere costantemente sottoposta a verifica, perché costantemente esposta al pericolo di degradarsi a «semplice referto» o di causare la scomparsa «indolore di una persona in una serie di frasi poetiche»:
Ciò vale per qualunque attività letteraria, ma particolarmente in questo caso, dove i fatti sono così perentori che non c’è quasi più niente da inventare. Per questo all’inizio sono partito dai fatti e ho cercato delle formulazioni. Poi mi sono accorto che nella ricerca delle formule mi allontanavo dai fatti. Allora, anziché dai fatti, sono partito dalle formule già esistenti, dal patrimonio linguistico sociale, scegliendo dalla vita di mia madre quei fatti che erano già contenuti in queste formule; perché solo in un linguaggio non elettivo e pubblico sarebbe stato possibile rintracciare, fra i tanti dati che non dicono niente, quelli che espressamente richiedono di venir pubblicati (WU, p. 34-35, S. 33).
Un rischio, questo, che incombe sin dall’esordio del racconto, nel momento in cui l’autore esprime, comunicandoli al lettore, i propri dubbi sull’opportunità di usare per l’incipit un’espressione quasi fiabesca come «cominciò che…», un’espressione che rischia appunto di trasformare l’intero racconto in una «storia assolutamente fantastica» (WU, p. 12, S. 14), che ridurrebbe di intensità la partecipazione personale del lettore. Ma le remore vengono messe da parte e la storia in qualche modo comincia, fornendo i primi dati essenziali, immancabili in ogni biografia, sebbene qui comunicati con estrema vaghezza: «Cominciò, insomma, che mia madre nacque, più di cinquant’anni fa, nello stesso luogo in cui anche è morta» (WU, p. 13, S. 14). Alle brevi note personali, che non forniscono alcuna indicazione precisa dal punto di vista spazio-temporale, segue un lungo excursus che contiene invece una dettagliata analisi sociologica del contesto in cui la donna viene al mondo: uno dei primi dati forniti è quello relativo alle condizioni di povertà generale [allgemeine Mittellosigkeit] della gente del posto, per lo più contadini. Povertà che Handke pone subito in una relazione di causa-effetto rispetto alle peculiarità caratteriali di questa gente: il senso di impotenza e la mancanza di volontà, elementi che si congiungono e potenziano in una climax dal ritmo inesorabile: privi di mezzi, impotenti, abulici [Mittellos, Machtlos, Willenlos].
Dalla massa informe dei contadini emerge e prende forma tra le righe del racconto la figura del nonno materno, figlio illegittimo come gran parte degli abitanti della zona (e come lo stesso Handke) e nipote di un contadino facoltoso, erede, in quanto tale, di una piccola proprietà sufficiente, per quanto esigua, a garantirgli quel margine di libertà che secondo il narratore è il presupposto fondamentale perché un individuo possa sviluppare una qualche forma di volontà: «la coscienza di possedere qualcosa era tanto liberatrice, che dopo un’abulia di generazioni poté formarsi improvvisamente una volontà» (WU, p. 14, S. 15). In una sorta di circolo vizioso, la volontà si estrinseca nel desiderio di aumentare ulteriormente quel margine di libertà ricevuta in dote, incrementando l’entità del possesso, e ciò con l’unico mezzo a disposizione in circostanze del genere, ossia tramite la tendenza parossistica al risparmio. Il nonno materno avrebbe così sviluppato un’attitudine maniacale al risparmio che paradossalmente mortifica fino a vanificarla proprio quella volontà di recente acquisizione, fiaccata sul nascere da una vita passata per intero a pensare al futuro, nella costante preoccupazione di limitare – quando non azzerare del tutto – ogni bisogno o desiderio, ogni necessità relativa al presente. In questa situazione di estrema indigenza emotiva ancora più che materiale, «nascere donna […] era, in assoluto nefasto»; l’unica consolazione era quella che, in quanto donna, non c’era alcuna necessità di preoccuparsi per il futuro e di dover dunque vivere secondo i dettami dell’imperativo paterno. Nascere donna in un contesto del genere significava acquisire quanto prima la consapevolezza dell’assoluta impossibilità di un futuro:
Nessuna possibilità, tutto già previsto: piccole galanterie, risolini, un’ebbrezza breve, poi repentinamente la faccia severa, riservata, che diventava subito un’abitudine, i primi figli, stare ancora un po’ lì dopo le faccende di cucina, non essere ascoltata mai sin dall’inizio, fingere lei stessa di non udire, parlare da sola, reggersi poi a fatica, le vene varicose, niente più che un mormorio nel sonno, cancro all’utero, e con la morte alla fine la predizione si avvera. Le varie fasi di un gioco che facevano le bambine di quei posti si chiamavano: Stanca-Debole-Malata-Moribonda-Morta (WU, p. 16, S. 17).
È questo destino riepilogato in maniera stringata a essere toccato in sorte alla madre di Handke. Con un procedimento analogo a quello seguito pochi capoversi più su per introdurre la figura del nonno, in un repentino passaggio dal generale al particolare, il narratore discosta ora lo sguardo dalle donne e bambine di allora per raccontare il caso specifico di una bambina, la madre appunto. Il cambio di prospettiva è determinato da una fotografia, che offre spunto e supporto alla narrazione:
Le domeniche: il manzo lesso con la salsa di rafano, la partita a carte, le donne che stanno a guardare umili, una foto di famiglia con la prima radio.
Mia madre aveva un carattere spavaldo, nelle fotografie si piantava le mani sulle anche o cingeva col braccio la spalla del fratellino. Rideva sempre, e pareva che non sapesse farne a meno (WU, p. 17, S. 17-18).
Quella menzionata è la prima di una serie di fotografie che l’io narrante descrive al lettore, senza però mai mostrargliele; nel testo non c’è traccia delle fotografie, queste vengono soltanto raccontate, sicché Wunschloses Unglück non può essere catalogato, da un punto di vista formale, come un esempio di fototesto letterario. Le foto, vere o presunte tali, che Handke vede e descrive o immagina di vedere e descrivere, esplicitamente nominate come foto quattro o cinque in tutto, svolgono un ruolo significativo nell’economia del testo, ora come espediente narrativo da cui prendere le mosse, ora come elemento capace di supportare la narrazione, conferendole ‘veridicità’. Ma al lettore non è dato di scoprire se queste fotografie esistano davvero, l’unica concessione che gli viene fatta è di ‘vederle’ leggendone la descrizione:
Tuttavia la gente aveva un rispetto secolare per i fatti compiuti: una gravidanza, la guerra, lo stato, le usanze e la morte. Quando mia madre, a quindici o sedici anni, semplicemente se ne andò di casa e imparò a fare la cuoca in un albergo sul lago, il nonno la lasciò fare, dato che ormai se n’era andata, e poi, a far la cuoca, c’era poco da imparare. Ma ormai le possibilità erano già esaurite: aiuto sguattera, cameriera, aiuto-cuoca, capocuoca. «Mangiare si mangerà sempre». Nelle fotografie, una faccia arrossata, guance lucide, a braccetto delle amiche, che si era trascinate dietro, timide e serie; un’allegria cosciente di sé: «Non può più succedermi niente!». Il piacere aperto, esuberante, della compagnia (WU, p. 18, S. 18-19).
Anche in questo caso il passaggio dal piano della narrazione documentaria dei fatti al racconto della vita interiore della madre avviene mediante un’immagine, una foto che il narratore descrive e commenta, traendone spunto per supportare le proprie congetture:
Il ritmo diventò esistenziale: come un rituale. “Il bene comune viene prima del bene individuale, il senso della comunità viene prima dell’egoismo”. Così era come se fosse dappertutto a casa sua, la nostalgia non esisteva più. Tanti indirizzi dietro alle fotografie, si dovette acquistare (o donare?) un taccuino, per la prima volta: tutto a un tratto si conosceva tanta gente, e succedevano tanti fatti, che uno poteva DIMENTICARE qualcosa (WU, p. 20, S. 21).
Il valore testimoniale delle fotografie non è legato soltanto all’immagine che esse riproducono, ma anche alla loro qualità di reperti del passato, ‘scrigni della memoria’[4] di un tempo ormai trascorso, che queste però in qualche modo documentano, al di là dell’immagine, in una dedica o in un indirizzo vergato sulla loro superficie. Le immagini possono allora essere interrogate, seguendo lo schema di una sorta di procedimento indiziario che è un’altra delle caratteristiche di questo racconto.
Anche il difficile e come si vedrà fallimentare tentativo di emancipazione della madre rispetto al contesto d’origine e di riscatto da un destino inesorabilmente ipotecato è ‘documentato’ da alcuni scatti fotografici:
Questo periodo servì a mia madre per uscire da se stessa e diventare autonoma. Acquistò un contegno, perdette quella estrema paura di essere toccata: il cappellino tutto scivolato in avanti, perché il giovane appoggiava la testa alla sua, mentre lei, soddisfatta di sé, rideva nella macchina fotografica (WU, p. 21, S. 22).
Il cappellino non perfettamente al suo posto, l’abbraccio del giovane e il sorriso della madre così come appaiono nella fotografia vengono letti dal narratore come segni di un avvenuto cambiamento interiore; la conquista di una maggiore autonomia, una maggiore apertura verso il mondo esterno, e di conseguenza una minore ritrosia nei confronti dell’altro sesso. Allo stesso modo è documentato da scatti fotografici il fallito tentativo di «diventare UN TIPO», trasformandosi da «comparsa d’anteguerra in comparsa del dopoguerra, la fresca contadina in cittadina» (WU, p. 31-32, S. 30), come pure è dalle fotografie che si intuiscono i primi segni del definitivo crollo psichico, la perdita di controllo, che trovano corrispondenza nell’incapacità di continuare a fingere nella realtà come davanti all’obiettivo:
Non poteva più recitare la parte della casalinga. A casa si svegliava col corpo già ferito. Lasciava cadere tutto per terra, aveva voglia di lasciarsi cadere dietro a ogni oggetto (WU, p. 58, S. 53-54).
Non sapeva più fingere; si era spalancata. Chiunque la guardasse, doveva capire quello che succedeva (WU, p. 59, S. 54).
Wunschloses Unglück segnerebbe una sorta di spartiacque nell’ambito della produzione letteraria dell’autore; si è parlato di una ‘svolta realistica’ della narrativa di Handke,[5] di un approdo alla storia come antidoto al ‘formalismo’ a oltranza degli esordi.[6] La scelta di raccontare la storia della propria madre avrebbe indotto Handke a misurarsi con un genere codificato quale quello della biografia, e la delicatezza degli argomenti trattati, il loro carico emotivo, lo avrebbero ‘costretto’ a lasciare definitivamente quella torre d’avorio rivendicata ancora pochi anni prima, in un saggio dal titolo volutamente provocatorio come Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, quale residenza d’elezione.[7] In realtà già nel saggio del ’67 la polemica contro il realismo in letteratura, e in particolare contro il descrittivismo documentario non viene condotta in nome di una letteratura d’evasione, avulsa dalla realtà, ma a partire dalla riconosciuta necessità di trovare un adeguato metodo di rappresentazione della realtà stessa: «Il problema, secondo me, non è creare attingendo direttamente dalla vita, ma trovare un metodo appropriato. È noto che la vita scrive le storie migliori, solo che purtroppo non sa metterle poi per iscritto».[8] Richiamandosi alla distinzione cara al grande realismo di fine Ottocento tra finden [trovare] e erfinden [inventare], Handke accorda la propria preferenza al primo termine e individua nel progressivo allontanamento della letteratura dalla finzione, dalla Erfindung, appunto, un chiaro elemento di progresso, che le avrebbe permesso di dedicarsi a quello che sarebbe il suo compito più vero, ossia la «comunicazione di esperienze vissute»[9] [Mitteilung von Erfahrungen].
Riconosciuta la superiorità della ‘vita’ in fatto di estro creativo, ma constatata d’altra parte la sua incapacità a raccontare materialmente le storie che inventa, compete alla letteratura il compito di mettere a sua disposizione i propri servigi, dando voce alla ‘vita’. Un’operazione tutt’altro che semplice, quella della trasposizione letteraria, che comporta il rischio di continue ricadute nella finzione, come ben sa il lettore di Wunschloses Unglück, un testo in cui sin dalle prime battute l’idea dell’artificio incombente sui fatti narrati assume a tratti toni di particolare drammaticità, poiché implica una sorta di reiterazione del gesto originario che ha segnato la tragica esistenza della madre, quella spersonalizzante negazione di ogni diritto a rivendicare una propria individualità che è stata la traccia lungo la quale si è srotolata la sua intera esistenza, dalla nascita alla morte.
Il problema è ancora una volta metodologico;[10] lo scrittore dovrà trovare un’adeguata modalità espressiva, nella consapevolezza, tuttavia, dell’ipoteca fallimentare che grava in modo pressoché fisiologico su ogni suo sforzo. La tendenza quasi ossessiva a interrogarsi su modi e mezzi di rappresentazione, in cui si è voluto identificare uno dei tratti distintivi del cosiddetto formalismo handkiano, nasce dunque da questa necessità di sondare i propri strumenti euristici, per accertarne di volta in volta validità ed efficacia, una procedura di vaglio che effettivamente sembra investire soltanto il livello formale dell’opera, poiché per l’individuazione dei ‘contenuti’, la scelta dei temi, stando alle dichiarazioni dello stesso Handke, non sussistono margini di dubbio:
Come prima cosa si tratta del metodo. Io non ho argomenti sui quali mi piacerebbe scrivere, io ho sempre e solo un unico argomento: fare chiarezza, sempre più chiarezza sulla mia persona, conoscermi o meno, imparare ciò che sbaglio a fare, a pensare, quel che penso senza volerlo, ciò che dico senza volerlo, in automatico, ciò che gli altri fanno, pensano, dicono come automatismo. Diventare attento e rendere attenti gli altri: rendere e diventare a mia volta più sensibile, più empatico, più preciso, affinché io e gli altri si possa vivere con maggiore esattezza e sensibilità, affinché sia più facile comprendersi e avere a che fare gli uni con gli altri.[11]
Il passo offre un valido esempio di quel «percorso dal basso, che non sentenzia ma osserva»,[12] che a ragione è stato individuato come una cifra caratteristica di questo autore. La ‘soggettività’[13] diventa in quest’ottica approccio d’elezione per ogni scambio comunicativo con l’esterno, come testimonia il passaggio repentino, articolato in una sorta di climax che parte dall’‘io’ per culminare negli ‘altri’: il conseguimento di un grado via via maggiore di attenzione, sensibilità e precisione del singolo individuo è la condizione imprescindibile affinché il soggetto e una generica umanità, ‘gli altri’, possano vivere e interagire nel migliore dei modi. Se l’individuazione dell’argomento da trattare non costituisce alcun problema, dato il suo carattere quasi necessario, ben diverso è invece l’impegno richiesto nella scelta della modalità rappresentativa, poiché ogni schema letterario è costantemente a rischio di veder inficiata la sua validità, snaturandosi in cliché che ne compromettono qualsiasi autenticità:
Perciò mi scelgo un metodo, quello di prestare attenzione a schemi letterari ormai consolidati a livello inconscio, cosicché questi tornino a essere consapevolmente non letterari. Non mi interessa smascherare i cliché (questo lo può fare qualsiasi individuo dotato di una modesta sensibilità), ma con l’aiuto di una realtà fatta di cliché ottenere nuovi risultati in relazione alla (mia) realtà: tornare a rendere produttivo un metodo riprodotto in automatico. Ma per il prossimo lavoro sarà necessario trovarne qualche altro.[14]
Non meno insidiosa della forma scelta è poi lo strumento di cui lo scrittore si serve nel suo lavoro, ossia il linguaggio, quel linguaggio letterario che non può essere considerato in alcun caso un «pezzo di vetro», una «lente trasparente» attraverso cui guardare al mondo senza incorrere nel rischio di una falsificazione, né tantomeno può essere ridotto a una forma di «parlare scritto» [geschriebenes Sprechen],[15] come si legge in un saggio del ’66. Le parole che lo scrittore impiega non restituiscono gli oggetti così come sono fatti, ma «come dovrebbero essere secondo l’idea di chi li descrive».[16] Le cose, nel momento stesso in cui vengono nominate, e le parole, quando adoperate in forma di citazione letteraria, perdono la loro originaria innocenza. Le parole non sono più capaci di «mostrare le cose, ma solo se stesse: non fanno altro che mostrare se stesse».[17] Qui Handke polemizza in realtà con la possibilità di una letteratura impegnata, sostenendo l’assoluta inconciliabilità dei due termini, che a suo avviso possono essere accostati solo a partire dall’equivoco assunto che la letteratura possa ‘snaturalizzarsi’ al punto di rinunciare alla propria forma e al proprio linguaggio, continuando a essere, ciò nonostante, letteratura. In realtà, sostiene Handke, la letteratura è in ogni sua espressione artificio, e ciò a partire dagli strumenti che impiega, la lingua, appunto; qualsiasi oggetto questa accolga diventa, nel momento stesso in cui viene trasposto letterariamente, a sua volta artificio. Anche il Manifesto del partito comunista – continua Handke, con buona pace di Brecht – nel momento in cui viene messo in versi diventa un poema sul Manifesto, sicché la sua carica politica sarà ineludibilmente neutralizzata dalla veste letteraria che gli si impone, sarà quest’ultima ad attirare l’attenzione dei lettori ben più dei contenuti:
La letteratura trasforma la realtà, anche la realtà dell’impegno, in stile. Rende inutilizzabili le parole, rovinandole, in un modo o nell’altro. Travisa ogni cosa; anche le parole pensate come molla per l’azione diventano gioco. Riduce a gioco ogni realtà, quella linguistica, che cita, e quella reale, che nomina. La letteratura è irreale, non è realistica.[18]
La realtà, qualsiasi realtà perde nella trasposizione letteraria il suo contenuto di verità. Ma la soluzione non può essere cercata in una ‘regressione’ al puro descrittivismo, ammesso che davvero sia raggiungibile un simile ‘grado zero’ della scrittura:
Io credo che al giorno d’oggi sia necessario guardare il mondo più da vicino così da poterlo cogliere nel minimo dettaglio. Ma cosa succede se questo mondo passato alla lente di ingrandimento viene solo trascritto [abgeschrieben], senza che accada alcunché alla lingua? Perché ci si tormenta nella ricerca inesausta della cosiddetta parola appropriata, se poi ci si limita a trascrivere utilizzando forme stantie, come se fossimo scienziati di ripiego [Ersatzwissenschaftler]. A questo punto sarebbe molto più semplice fotografare. Se accettiamo il presupposto che la lingua va utilizzata come fosse una semplice lente, una superficie di vetro, allora con una macchina fotografica ci si potrebbe avvicinare molto meglio alle cose. Una letteratura del genere degrada la lingua a surrogato della macchina fotografica, una sorta di preparazione alla fotografia, un’indicazione di regia per la giusta disposizione della macchina fotografica, del tutto priva di ironia, una scienza ausiliaria. Si ha l’impressione che questo tipo di scrittori, a poterselo permettere, si risparmierebbero tempo e fatica e conseguirebbero risultati di gran lunga migliori.[19]
La fotografia viene qui intesa da Handke, in modo senza dubbio alquanto ingenuo, come trascrizione immediata della realtà, una forma oggettiva di rappresentazione elementare, e viene contrapposta alla ben più complessa e mediata operazione di resa letteraria della realtà che contraddistingue invece la scrittura letteraria. Il ricorso alle fotografie nel racconto Wunschloses Unglück potrebbe allora giustificarsi in quest’ottica. Nella loro ‘innocenza’ le fotografie della madre potrebbero farsi garanti del contenuto di realtà della narrazione, opponendosi, in quanto espressione di una materiale oggettività, di una maggiore vicinanza al reale, alla tendenza fagocitante e manipolatoria del linguaggio letterario.[20]
«Se la fotografavano non era più capace di assumere un’espressione. Corrugava la fronte e rialzava le guance per un sorriso, ma gli occhi guardavano con pupille che erano scivolate via dal centro dell’iride. In una tristezza inguaribile» (WU, p. 67, S. 60). La capacità degli scatti fotografici di mettere a nudo la realtà è percepita come minaccia dalla madre, come dimostra la sua progressiva ritrosia nei confronti dell’obiettivo. All’apice del malessere, è la madre stessa a occultarne le tracce, nascondendo da occhi indiscreti le fotografie: «Non aveva predilezioni, un hobby; non collezionava niente, non scambiava niente; non risolveva più i cruciverba. Già da tempo non incollava neanche più fotografie, le toglieva soltanto di mezzo» (WU, p. 55, S. 51). L’incapacità della donna di conservare un contegno nelle fotografie, il suo bisogno di cancellarle in quanto testimonianze dello stato avanzato della malattia, è avvertito dal figlio, che – circoscrivendo il pensiero in una parentesi – ne intuisce le pericolose ripercussioni sul piano del racconto: «Da questo momento devo stare attento che la storia non si racconti troppo da sola» (WU, p. 67, S. 60). D’altra parte, anche la validità probatoria degli indizi che il figlio raccoglie studiando le immagini e intrecciandole a racconti e ricordi viene ben presto messa in crisi dai primi dubbi metodologici sulla liceità del procedimento seguito, dubbi che investono in modo inesorabile anche il grado di autenticità della riproduzione fotografica, la sua attendibilità documentaria,[21] che lungi dall’essere in grado di neutralizzare il carattere manipolatorio della resa linguistica, non riesce nemmeno ad arginarne e contenerne gli effetti. La «forza dell’evidenza» delle fotografie le confina infatti in un mutismo che ben si presta a essere ‘invaso’ dalla narrazione letteraria, sicché anche quella attestazione di realtà che ne è caratteristica fondamentale, quella certezza «di ciò che è stato»[22] che la fotografia tra tante reticenze afferma, perde ogni perentorietà:
La finzione che le fotografie possano “dire” qualcosa: ma non è forse vero che ogni formulazione, anche di ciò che è realmente accaduto, è già più o meno fittizia? Meno, se ci si limita a fare una relazione; più, quanto più esattamente si cerca di formulare? E quanto più si finge, tanto più la storia diventerà interessante anche per qualcun altro, perché è più facile identificarsi con delle formulazioni che con dei fatti semplicemente riferiti? Di qui il bisogno di poesia? “Mancanza di respiro sulla riva del fiume”, secondo una formulazione di Thomas Bernhard (WU, p. 21-22, S. 22).
Anche le fotografie mentono, o sono indotte a mentire rivelando la componente di artificio insita nella loro natura ambivalente, frammento di realtà e «captatio retorica» a un tempo;[23] esse non sono «tanto uno strumento della memoria, ma una sua invenzione o sostituzione».[24] Anche le fotografie ‘spersonalizzano’ e uniformano, come percepisce chiaramente lo scrittore davanti al cadavere della madre, sottoposta all’ultima fotografia di rito:
Poi la fotografarono. Qual era il suo lato migliore? «Il lato fotogenico della morta».
Il rituale del funerale la spersonalizzò definitivamente, e fu un sollievo per tutti. Nella neve fitta camminammo dietro i resti mortali. Nelle formule religiose non c’era altro da fare che inserire il suo nome. «La nostra sorella…» (WU, p. 73, S. 64).
È durante il funerale che Handke avverte la necessità di scrivere della madre, a partire da una percezione che si fa strada in lui al momento della sepoltura, la percezione del divario che contrappone il bosco immobile alla gente intervenuta al rito, «un episodico agitarsi di figure che uscivano sempre più dal quadro» (WU, p. 74, S. 64). La scrittura nasce dunque dal bisogno di dare voce e contorni a queste immagini, di riportarle all’interno di una cornice, per attribuire loro un senso, e in linea con un tale assunto, è anche un tentativo di conferire identità alla propria madre, di accoglierne desideri, pensieri e segreti, di dare loro voce. A ragione si è voluto leggere in questo racconto il desiderio di realizzare – attraverso la narrazione – una «tardiva attribuzione di soggettività»,[25] un desiderio di difficile realizzazione quest’ultimo, destinato a rimanere inappagato, come mostra il bilancio tutto negativo consegnato alle ultime pagine del racconto:
Non è vero che scrivere mi sia servito. Nelle settimane in cui mi sono dato da fare con la storia, la storia non ha cessato di darmi da fare. Scrivere non era, come pensavo all’inizio, ricordare un periodo concluso della mia vita, ma una costante simulazione di ricordo, in forma di frasi che si limitavano ad affermare la distanza (WU, p. 74, S. 65).
Naturalmente il descrivere è un processo di puro e semplice ricordare: non serve a impedire che le cose accadano una seconda volta; dagli stati di angoscia attraverso il tentativo di accostarvisi con formulazioni il più possibile precise, si ricava solo un piccolo piacere: dalla beatitudine dell’orrore la beatitudine del ricordo (WU, p. 75, S. 65).
Scrivendo questa storia mi capitava, a volte, di averne abbastanza della sua sincerità e della sua onestà e di aver voglia di tornare presto a scrivere qualcosa in cui potessi mentire e nascondermi un po’, un lavoro teatrale, per esempio (WU, p. 75, S. 66).
In una intervista televisiva del 2008, con Gero von Boehm, Handke spiega: «Io non ho alcun ricordo, mi invento ogni cosa e spesso è anche meglio del ricordo… poiché il ricordo ti confina quasi sempre in te stesso, mentre l’invenzione può, per così dire, liberarti».[26] Lo sguardo del figlio che guarda le foto della madre e racconta la sua storia sembrerebbe lasciarsi ispirare da un analogo principio. I ricordi vengono ‘costruiti’ attraverso un’operazione che convoca allo stesso titolo sguardo, immaginazione e memoria,[27] per essere poi fermati sulla carta, tradotti letterariamente in racconto: Erzählung recita appunto il sottotitolo di Wunschloses Unglück.
Se l’attenzione si appunta sulla componente visiva di questo articolato procedimento creativo, si può comprendere quali siano i termini di quell’equilibrismo tra una «percezione che distanzia» [distanzierende Wahrnehmung], quella del puro descrittivismo, di per sé inefficace e poco rispettosa nei confronti dell’oggetto percepito, e la «percezione fagocitante» [verschlingende Wahrnehmung] dell’appropriazione letteraria, inopportuna per motivi di segno uguale e contrario.[28] Equilibrismo che si riverbera nella scelta di una terza possibilità, capace di superare le altre due riconvocandole all’interno di una modalità percettiva ‘terza’, quella «ambivalenza del processo visivo» [Doppelsinnigkeit des Sehvorgangs][29] che si destreggia tra uno sguardo che si limita a ‘registrare’, e uno sguardo ‘empatico’,[30] e che è condizione ‘perfetta’ per lo scrittore, poiché è quello stato di grazia in cui la fantasia, intesa come «commistione di vedere e sentire»,[31] può operare al meglio. È lo stesso Handke a spiegare la sua modalità ideale di percezione, che formula rivisitando una nota affermazione di Robert Musil: «non ‘io sto lì a guardare la gente’ […], ma ‘faccio in modo che la gente esista, mentre la osservo’ (questo almeno è il mio ideale)».[32] Secondo un simile procedimento l’atto del vedere presuppone una riduzione, se non la capacità di neutralizzare, la distanza tra soggetto e oggetto, così da fornire l’accesso a una superiore tipologia esperienziale, che convochi a un tempo l’oggetto percepito, ma anche la percezione del soggetto che percepisce. Un procedimento di appropriazione della realtà non dissimile da ciò che Wim Wenders definisce, in fotografia, la ‘disposizione’[Einstellung].[33]
In Falsche Bewegung,[34] una rivisitazione del Wilhelm Meister goethiano che segna gli esordi della collaborazione tra Peter Handke e Wim Wenders, il protagonista Wilhelm vuole diventare scrittore in virtù della sua caratteristica di saper scrivere non già a partire dall’‘osservazione della realtà’ [das Beobachtete], ma dalla sua capacità di ‘viverla’ e ‘sperimentarla’ [das Erlebte]:
Lo so, non sono dotato di quel che si definisce il dono dell’osservazione, ma della capacità di una sorta di sguardo erotico. All’improvviso mi salta agli occhi qualcosa che ho sempre trascurato. In quel momento non mi limito a vedere qualcosa, ma la percepisco anche. È questo che intendo per sguardo erotico. Ciò che io vedo in quel momento non è più solo l’oggetto della mia osservazione, ma anche una parte del mio io più profondo. Un tempo si è parlato in proposito di sguardo ‘d’essenza’ [Wesenschau]. A quel punto la singola cosa diventa segno per la totalità. A quel punto io non mi limito più a scrivere ciò che osservo [etwas bloß Beobachtetes], come fanno i più, ma la mia esperienza vissuta [etwas Erlebtes]. È proprio per questo motivo che voglio essere uno scrittore.[35]
Anche un procedimento del genere non è però privo di insidie; in questo tipo di sguardo l’oggetto visto diviene una cosa sola con il soggetto vedente, sicché i suoi contorni si dilatano fino ad accogliere «una parte profonda di me». L’oggetto della percezione, nel caso di Wunschloses Unglück le immagini della madre morta consegnate alle fotografie, rischiano costantemente di essere distorte dallo sguardo di chi le scruta, dal narratore che – dopo averle ‘contraffatte’ riguardandole con il suo «sguardo erotico» – le usa sistemandole con perizia all’interno del tessuto narrativo, ora come supporto ora come spunto per raccontare la storia della madre,[36] cosicché il ricordo ancora una volta per Handke non è «conservazione, ma principio di una decostruzione».[37]
Ho l’impressione che quasi tutto ciò che in passato ho visto o sentito perda in me immediatamente la forma originaria e non sia più descrivibile mediante parole né riproducibile mediante figure, ma che si trasformi invece in una crisalide priva di forma; e che debba essere appunto lo sforzo vero di questo mio scrivere quello di trasformare le innumerevoli ed informi esperienze in qualcosa di completamente diverso, cosicché lo scrivere corrisponda a un loro generale risveglio, alla formazione di nuove figure, laddove però queste non potrebbero non essere collegate, proprio attraverso la mia sensazione, alle esperienze originarie. Anzi, non potrebbero non rappresentare, di fronte a queste cose autentiche e vere, ma insignificanti, le raffigurazioni mitologiche della mia coscienza e della mia esistenza – e questo concetto nasce ora dagli innumerevoli e terribilmente informi incroci di crisalidi dentro di me, a metà strada fra cose e immagini, ma decisamente irriducibili all’una o all’altra specie. E quale lavoro mi si prospetta in futuro, se davvero vorrò renderli idealmente e linguisticamente accettabili, questi incroci per ora privi di idea come di linguaggio, tutt’al più esistenti, ma come embrioni, in divenire, se davvero vorrò arrivare a qualcosa di radioso, di nuovo, che però denoti, almeno a livello di intuizione, l’antico, l’esperienza originaria, proprio come la farfalla contiene il bruco![38]
Ma l’«antico», l’«esperienza originaria» non è un bene acquisito una volta per tutte, e la narrazione si dipana all’interno di una bipolarità ossessiva tra conoscenza della storia e disprezzo nei suoi confronti;[39] l’equilibrio va riconquistato di volta in volta, ed è costantemente a rischio di infrangersi. Nelle ultime pagine del racconto la resa del narratore ai fatti è pressoché totale. Le frasi si susseguono affastellandosi, senza alcun legame le une con le altre. Al contrario del procedimento seguito fino a questo punto,[40] la voce narrante si limita a registrare episodi, circoscrivendo a sparuti interventi ogni pretesa autoriale di intrecciarli in una narrazione articolata. Scene di vita della madre si alternano a immagini e ricordi della vita del figlio, nel flusso di pensieri di una coscienza che non conosce più confini e affonda nell’orrore:
L’orrore è qualcosa di conforme alla legge naturale: l’horror vacui nella coscienza. L’immagine si sta giusto formando, e improvvisamente si accorge che non c’è più niente da immaginare. Allora precipita, come un personaggio dei cartoni animati quando si rende conto di stare camminando nel vuoto. Più avanti scriverò di tutto questo in modo più preciso (WU, p. 78, S. 68).
Anche le immagini non sono più in grado di fornire alcun supporto, prive come sono di consistenza, di rimando a una realtà ‘autentica’; ancora una volta si spalanca lo iato tra descrizione e riflessione,[41] e allo scrittore non resta altro che rimandare a un momento successivo il tentativo di scrivere della madre: «Più avanti scriverò di tutto questo in modo più preciso» (WU, p. 78, S. 68). Per questa volta ciò che Handke consegna al lettore non è la storia di sua madre, ma un racconto su di lei, un libro come tutti gli altri, fatto di ‘vita’ e ‘finzione’.[42]
1 P. Handke, Wunschloses Unglück, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 20175. L’opera esce nel 1972 per Residenz Verlag di Salisburgo. La traduzione italiana, a cura di B. Bianchi, è citata da P. Handke, Infelicità senza desideri, Milano, Garzanti, 19883. D’ora in avanti si citerà con la sigla WU con relativa indicazione del numero di pagina delle edizioni italiana (p. e il numero arabo) e tedesca (S. e il numero arabo).
2 «Am Schluß kann der Erzähler nicht mehr verbergen, daß er selbst Teil der Geschichte ist. Allein schon die Unstimmigkeiten seiner Äußerungen zum Schreib-Motiv sind ein Indiz dafür, daß unterhalb der Schicht des 'Falles' eine Macht im Spiel ist, die die Geschichte mitschreibt. Das Ich, daß hier berichtet, ist nicht das eines Chronisten, der einfach nacherzählt. Indem er formuliert, deutet er, geht etwas in die Person der Mutter ein, das ihr vermutlich nicht zugehört. Seine Erzählhaltung – die beabsichtigte nicht weniger als die tatsächliche – ist also Teil des Textes» (W. Mauser, ‘Peter Handkes Wunschloses Unglück – erwünschtes Unglück?’, Der Deutschunterricht, 34, 1982, pp. 73-89: p. 78).
3 G.M. Stoffel, ‘Antithesen in Peter Handkes Erzählung Wunschloses Unglück’, Colloquia Germanica, v. 18, n. 1, 1985, pp. 40-54: p. 42.
4 L’espressione tedesca è «Zeitkapsel», e l’adopera Wim Wenders in un suo fototesto. Cfr. W. Wenders, 4 Real & True 2. Landschaften. Photographien, Düsseldorf, Museum Kunstpalast, 2015, p. 92.
5 Si veda a riguardo la brillante analisi di Elena Stramaglia, che illustra la poliedrica natura dello sperimentalismo handkiano, assolutamente non riducibile entro i limiti di un estetismo di maniera, e ridimensiona di conseguenza la portata della sua presunta svolta realistica («La forma è veicolo essenziale di impegno: attraverso l’estraniazione dell’immagine di realtà dominante, che non può che cominciare a livello linguistico e narrativo, Handke mira a creare distanziamento nel lettore, dando forma a vie alternative di percezione e di comprensione del mondo che frantumino il “contesto di accecamento” (Verblendungszusammenhang) abituale, smascherino i condizionamenti e affranchino le coscienze dalle abitudini mentali alla base del consenso»; E. Stramaglia, Il peso del mondo e la scrittura in frammenti. Poetica della percezione e della lingua in Das Gewicht der Welt di Peter Handke, Berlin, Peter Lang, 2018, p. 33). L’idea di una ‘svolta’ è chiamata in causa dalla critica per caratterizzare più aspetti della narrativa di quest’autore. Oltre a una ‘svolta’ che segnerebbe il passaggio dal formalismo al realismo, si è ad esempio parlato di una ‘svolta’ a livello percettivo, che avrebbe permesso a Handke di superare una fase iniziale di straniamento parcellizzante in favore di uno sguardo empatico. Anche in questo caso si ritiene ben più condivisibile l’idea di una «Akzentverschiebung», come teorizza nel suo saggio Gerhard Melzer (cfr. G. Melzer, ‘Lebendigkeit: ein Blick genügt. Zur Phänomenologie des Schauens bei Peter Handke’, in G. Melzer, J. Tükel (a cura di), Die Arbeit am Glück. Peter Handke, Königstein, Athenäum, 1985, pp. 126-152, in particolare p. 131).
6 Cfr. A. Estermann, ‘Vom “bloß Sprachlichen” zu einem “allenumfassenden Realismus”. Handkes ‘realistic Turn’ um 1970’, in A. Estermann, H. Höller (a cura di), Schreiben als Weltentdeckung. Neue Perspektive der Handke-Forschung, Wien, Passagen Verlag, 2014, pp. 97-134.
7 P. Handke, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 201613.
8 Ivi, p. 22 («So geht es mir nicht darum, unmethodisch aus dem Leben zu schöpfen, sondern Methoden zu finden. Geschichte schreibt das Leben bekanntlich am besten, nur daß es nicht schreiben kann»).
9 Ivi, p. 24.
10 Cfr. A. Estermann, ‘Vom “bloß Sprachlichen” zu einem “allenumfassenden Realismus”’, che definisce «la ricerca di modalità narrative alternative un punto essenziale della poetica di Handke» (p. 116).
11 P. Handke, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, p. 26.
12 E. Stramaglia, Il peso del mondo e la scrittura in frammenti, p. 30.
13 Elena Stramaglia invita a parlare di soggettività in luogo di soggettivismo (cfr. ivi, p. 113).
14 P. Handke, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, p. 22.
15 P. Handke, ‘Die Literatur ist Romantisch’ [1966], in Id., Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, pp. 41-42.
16 Ivi, p. 41 («geben nicht die Dinge wieder, sondern die Meinung des Beschreibenden, wie die Dinge sein sollten»).
17 Ivi, p. 47 («Sie zeigen […] nicht mehr auf die Dinge, sondern auf sich selber: sie zeigen sich selber»).
18 Ivi, pp. 49-50.
19 P. Handke, ‘Zur Tagung der Gruppe 47 in USA’ [1966], in Id., Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, p. 32.
20 Sul rapporto tra scrittura e immagine in Handke si veda H.-P. Preusser, ‘Die Wirklichkeit der Bilder. Peter Handkes leuchtender Alltag’, Alltag. Handkeonline, 8 agosto 2013
21 Cfr. R. Coglitore, ‘La verità dell’io nei fototesti autobiografici’, in M. Cometa, R. Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteratura e cultura visuale, Macerata, Quodlibet, 2016, pp. 49-68, in particolare p. 60 sgg.
22 Le espressioni citate tra caporali sono entrambe di R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia [1980], trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 20032, p. 107. Anche Barthes, come Handke, racconta di fotografie della madre, in particolare di una, senza mostrarle al lettore. Il saggio di Barthes è del 1980, il racconto di Handke del 1972.
23 R. Coglitore, ‘Dispositivi autobiografici. Retoriche e verità fototestuali’, Between, IV, 7, 2014, pp. 1-37: p. 5.
24 S. Sontag, ‘Il mondo dell’immagine’, in Ead., Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società [1973], trad. it. di E. Capriolo, Torino, Einaudi, 20043, pp. 131-156: p. 142.
25 L’espressione è di Moser, che nel suo saggio scrive: «“Nachgetragene Subjektivität” oder “nachgetragenes Selbstsein” könnte man die erschüttende Erzählung Wunschloses Unglück nennen» (T. Moser, ‘Das falsche und das verschüttete Selbst. Über Gefühl, Verstand, Sprache und Subjektivität in Peter Handkes Erzählung Wunschloses Unglück’, in Id., Romane als Krankgeschichten, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1985, pp. 153-175: p. 162).
26 «Ich habe keine Erinnerung, aber ich bilde es mir ein, und es ist oft besser als Erinnerung… Erinnerung schließt dann sehr oft einen in sich selber, während Einbildung kann – so zu sagen – einen befreien» (Intervista con Gero von Boehm, in ‘Peter Handke - Begegnung mit Gero von Boehm’ (2008), min. 5’40’’, <https://www.youtube.com/watch?v=TWdA8Kx-Gh8> [accessed 01.09.2020]). Si veda a riguardo anche il capitolo ‘Memoria, Oblio, variazioni sulla durata’, in E. Stramaglia, Il peso del mondo e la scrittura in frammenti, pp. 93-99.
27 A proposito dello scritto di Siri Hustvedt, Three Emotional Stories: Reflection on Memory, the Imagination, Narrative, and the Self (2011) e della sua affermazione che «scrivere narrativa è come ricordare ciò che non è mai accaduto», Michele Cometa, richiamandosi anche al commento di Vittorio Gallese, osserva: «La premessa da cui entrambi gli autori muovono è che la memoria e l’immaginazione partecipano dello stesso processo mentale, poiché sono entrambe legate all’emozione», e ancora: «Memoria e immaginazione sono dunque complementari, ma differenti. La memoria da sola sarebbe un peso, se non fosse mobilizzata dall’immaginazione» (cfr. M. Cometa, ‘Verso una topica dell’immaginazione: Lo iato e la nascita delle immagini’, in L. Follesa (a cura di), Il ‘pensiero per immagini’ e le forme dell’invisibile / Das ‘Denken in Bildern’ und die Formen des Unsichtbaren, Berlin, Peter Lang, 2019, pp. 235-252).
28 G. Melzer, ‘Lebendigkeit: ein Blick genügt’, pp. 126-152: p. 133. Alla difficile arte di destreggiarsi tra descrittivismo e interiorità, Handke dedica il racconto Nachmittag eines Schriftstellers (P. Handke, Nachmittag eines Schriftstellers [1987], Frankfurt a.M., Suhrkamp, 20175).
29 G. Melzer, ‘Lebendigkeit: ein Blick genügt’, p. 127.
30 Entrambe le tipologie di sguardo sono in grado di fornire un certo tipo di approccio alla realtà, e lo spazio intermedio che si apre all’interno della loro contrapposizione dialettica fornisce notevoli indizi per comprendere quale sia la visione del mondo di Handke, nonché, dato lo stretto legame tra sguardo e creazione, un utile strumento di analisi per alcune costanti dell’estetica di questo autore.
31 Melzer parla di «Zusammenhang von Sehen und Fühlen» (G. Melzer, ‘Lebendigkeit: ein Blick genügt’, p. 135).
32 «Nicht: ‘ich sehe mir die Leute an’ […], sondern: ‘ich lasse sie, betrachtend, sein’ (jedenfalls ist das mein Ideal)» (P. Handke, Die Geschichte des Bleistifts, Salzburg/Wien, Suhrkamp, 1982, p. 187). Sull’argomento cfr. E. Stramaglia, Il peso del mondo e la scrittura in frammenti, in particolare il paragrafo ‘Poetica minima della fenomenologia’, pp. 143-168.
33 La disposizione è racchiusa in quel controscatto, tipico del gesto del fotografare, che ci consegna insieme all’immagine dell’oggetto riprodotto, quella del fotografo che l’ha catturata. Si veda a riguardo W. Wenders, Die Pixel des Paul Cézanne und andere Blicke auf Künstler, Frankfurt a.M., Verlag der Autoren, 2015, p. 126.
34 P. Handke, Falsche Bewegung, Frankfurt a.M.,Suhrkamp,1975.
35 Ivi, p. 58.
36 Cfr. F. Arribert-Narce, ‘Photographs in Autobiographies: Identities in Progress’, GRAFT & TRANSPLANT, 1, 2008, pp. 49-57.
37 M. Cometa, Mistici senza Dio: Teoria letteraria ed esperienza religiosa nel novecento, Palermo, Edizioni di Passaggio, 2012, pp. 239-277: p. 254. Si veda anche quanto scrive a proposito dell’effetto di distorsione della memoria, anche fotografica, Lefcowitz: «Contrary to the traditional view that memories, once constructed in the brain’s synapses, are consolidated and hence stable, contemporary psychiatrists and neurobiologists believe a memory is never static. Rather it is malleable and subject to constant change – or else no one would ever learn. More precisely, one can change one’s perceptions of the memory through analysing its contents at a later time thanks to a more enlightened take on past events as shaped by subsequent experience. Given their malleability, memories are, of course, open to distortions and “corrections” – especially if another person shares the memory but adds or deletes certain details. But photographs, too, can involve distortions of reality» (B. F. Lefcowitz, ‘Memory and Photography’, Southwest Review, v. 96, n. 2, 2011, pp. 231-239: p. 233).
38 P. Handke, Das Gewicht der Welt. Ein Journal (November 1975 - März 1977), Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1977, pp. 30-31.
39 «Das Wichtigste: die Geschichte nicht für sich zu reklamieren, sich nicht von ihr definieren zu lassen, sich nicht auf sie herausreden – sie verachten, in denen, die ihre persönliche Nichtigkeit mit ihr kaschieren – und doch sie kennen, um die andern zu verstehen und vor allem zu durchschauen (mein Haß auf die Geschichte als Asyl für die SeinsNichtse)» (ivi, p. 20).
40 «Was als Text vorliegt, ist nicht eine Art Autobiographie, sondern eine künstlerisch gestaltete, auf Sinn-Vergegenwärtigung hin verdichtete Erzählung, die mehr ist als eine Ansammlungund Auswertung von Fakten» (W. Mauser, ‘Peter Handkes Wunschloses Unglück’, p. 78). In proposito si veda anche H. Höller, Interpretation nell’edizione tedesca di WU, in particolare p. 83.
41 H. Höller, Interpretation, p. 94.
42 «“Die Bücher, die Sie schreiben sind aus der Luft gegriffen oder aus dem Leben?” fragte der Alte. “Aus beidem”, antwortete ich» (P. Handke, Das Gewicht der Welt, p. 84).