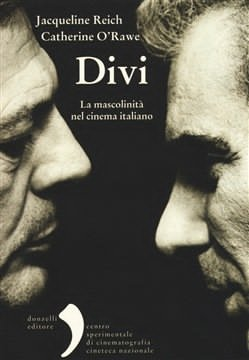
Già nel 1967, con il suo Films and Feelings (Faber & Faber), Raymond Durgnat coglieva uno dei nessi cruciali del rapporto fra estetica filmica, sociologia e divismo: «Le star sono un riflesso nel quale gli spettatori scrutano e adeguano la propria immagine di se stessi [...]. La storia sociale di una nazione può essere scritta alla luce delle sue star cinematografiche» (pp. 137-138). Su questa scia Reich e O’Rawe orientano lo studio dedicato ai divi nostrani (Divi. La mascolinità nel cinema italiano, Donzelli 2015), un testo che offre una galleria di ritratti agili ma rigorosi, posti dentro una cornice marcatamente teorica. La doppia matrice del discorso, divulgativa e accademica a un tempo, lungi dal disperdere il denso patrimonio di storie e riflessioni di cui il volume si compone, offre invece un appiglio sicuro agli studiosi di cinema e un viaggio a occhi aperti nel variegato mondo delle stelle made in Italy ai curiosi di costume e ai fan di ogni età.
La prima parte del testo, articolata in quattro sezioni (I. Mascolinità all’italiana, II. Divismo, divi e storia italiana, III. L’italianità del divismo italiano, IV. Star studies, interpretazione, celebrità e nuovi media), chiarisce le premesse metodologiche dello studio mettendo in campo le diverse implicazioni che il tema porta con sé. Le autrici dichiarano immediatamente di voler analizzare la «mascolinità all’italiana» attraverso tre componenti essenziali – divismo, italiano, maschile – declinate però in ordine inverso: si parte da questioni relative al genere, si inquadra poi «la celebrità in una prospettiva storica» per giungere infine all’esplicitazione del concetto di «italianità» (p. 5). L’esito di tale ‘pedinamento’ è l’individuazione di alcuni caratteri peculiari della mascolinità italiana: l’importanza della sfera pubblica come spazio identitario, l’ossessione per «la bella figura» (p. 6), la relazione dialettica con i codici della castità femminile, da cui discende la rilevante reputazione del maschio, nonché la protezione del suo onore. Se l’esibizione della virilità in pubblico rappresenta per l’uomo mediterraneo una sorta di imperativo, i culti della mascolinità richiedono «“costante vigilanza e difesa” contro le minacce della femminilizzazione, della sessualità femminile e dell’omosessualità» (p. 7). Fin qui, in poche ma incisive battute, la premessa di genere del discorso, che lascia fuori campo l’attualità del dibattito intorno alle politics of queers[1] ma insiste efficacemente sulla dialettica tipicamente italiana fra maschile e femminile. Rispetto a tale quadro – da intendersi come realtà in divenire – il cinema è stato in grado di rappresentare e (de)codificare le oscillazioni economiche, sociali, politiche e culturali dell’Italia del XX e del XXI secolo, dando corpo a figure del desiderio dai tratti mossi, ambigui, e per questo tanto più affascinanti anche se spesso (come nel caso del divismo maschile) rimaste in ombra, almeno sul versante degli studi di settore. A fronte di un cospicuo dibattito sulle star italiane (si pensi alla popolarità nazionale e internazionale di Sophia Loren), è mancata finora una riflessione attenta sulle funzioni culturali e artistiche del divismo maschile, ed è proprio da questa mancanza che prende le mosse il discorso di Reich e O’Rawe.
Oltre a constatare il carattere effimero e disorganizzato del divismo italiano rispetto alla portata del fenomeno hollywoodiano, le due autrici descrivono la parabola della mascolinità delle star dagli anni del muto fino al primo decennio degli anni zero, strizzando l’occhio al consolidarsi di un divismo televisivo in grado di competere con le icone del grande schermo. Dal fitto intrecciarsi di volti e generi cinematografici emerge, innanzitutto, la divaricazione durante il periodo fascista tra la robusta virilità incarnata dall’onnipresente figura pubblica di Benito Mussolini (di cui sarebbero campioni Amedeo Nazzari e Fosco Giachetti) e la scanzonata spavalderia degli uomini dei telefoni bianchi, ritratta mirabilmente da Vittorio De Sica. Anche il neorealismo presenta una certa ambivalenza nella caratura dei modelli mascolini: si pensi al fosco Massimo Girotti, homme fatale in Ossessione e «forzuto» in La corona di ferro; alla pregnanza simbolica dei «bambini-maschi» destinati a inscenare il processo del ‘diventare uomo’ (su tutti Enzo Staiola, protagonista di Ladri di biciclette); o ancora all’eroismo tormentato dei molti ‘reduci’, espressione dello «sforzo per ricostruire una virilità egemonica dopo l’umiliazione bellica dell’Italia, a fronte di una rinnovata indipendenza e mobilità femminile» (p. 20). L’affermazione della commedia all’italiana proietta sullo schermo nuovi tipi, non sempre rassicuranti, che portano soprattutto la ‘maschera’ di Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi, capaci – come sottolinea Gianpiero Brunetta – di radiografare per quasi vent’anni «le bassezze e i mali ereditari dell’italiano medio» e di costruire «un grandioso affresco alla rapidità con cui si imbocca la strada verso la civiltà dei consumi».[2] Il patetismo, il graffio satirico, il ghigno incerto di questi quattro campioni della risata all’italiana producono nello spettatore un sentimento di «devota complicità» (p. 24), di compiaciuto rispecchiamento, che non esclude però un moto di autocritica, almeno secondo la lettura di O’Leary.[3] Se nell’ultimo scorcio del XX secolo il potere delle star italiane è compromesso dalla popolarità crescente del cinema americano (con felici eccezioni dovute alla stretta collaborazione fra registi e divi – Fellini/Mastroianni, Risi/Gassman, Petri/Volonté fino a Sorrentino/Servillo), il nuovo millennio decreta il ritorno alla ribalta dei divi e il predominio (quasi) assoluto di star e registi maschi – almeno secondo la «Power List» pubblicata da Ciak nel 2013. Lo scenario del divismo attuale registra, infatti, la crescente ascesa di attori carismatici, spesso impiegati nello stesso film a rinsaldare l’idea di una «solidarietà omosociale» (p. 27): è quel che accade nel 2005 con Romanzo criminale di Michele Placido, che schiera insieme Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Elio Germano e Claudio Santamaria, accanto al già affermato Stefano Accorsi. Dopo la ‘svolta cinematografica’ della televisione italiana del decennio sessanta-settanta, che aveva determinato un regime di concorrenza fra star del grande e del piccolo schermo, assistiamo oggi a dilaganti fenomeni di rimbalzo fra i due media, così che ormai sempre più spesso si producono commedie e film comici interpretati da celebrità affermatesi in prima istanza in ambito televisivo. La fluidità del divismo maschile degli anni zero, le diverse forme di contagio intermediale (fra cinema, tv e social media) sono alcuni degli indizi della trasformazione del regime divistico in atto nell’epoca della convergenza, di cui si dà conto nell’ultimo paragrafo della prima parte: questa apertura serve a riconfigurare le categorie storicamente elaborate dagli star studies (in primis da Weber, Morin e Dyer) e a rilanciare l’opportunità di un’indagine a tutto tondo sulla consistenza e le funzione dei divi come «celebrità», come «professionisti» e come «performer».
La seconda parte del volume esemplifica le premesse teoriche e metodologiche attraverso la composizione di un atlante di volti (13 in tutto: da Bartolomeo Pagano a Riccardo Scamarcio), che restituisce il carattere mosso del coté divistico nostrano. Leggendo tra le righe è possibile cogliere la tensione fra il modello di una mascolinità robusta, fiera, a tratti perfino sbruffona (che trova nel latin lover l’insegna più luccicante) e le pose di una virilità malinconica, tenebrosa, mai paga. Può succedere che uno stesso attore riesca a farsi carico di tali ambivalenze affettive (è il caso del Mastroianni de La dolce vita o del Servillo de La grande bellezza), oppure che si giunga a forme di tipizzazione seriale a più facce (come accade per i ‘mostri’ della commedia all’italiana: Gassman e Sordi). Indubbiamente quel che emerge dalla galleria allestita da Reich e O’Rawe è la fragilità del maschio italiano sullo schermo, stretto in un nodo di galanteria e disincanto, che avrebbe prodotto i tic, gli atti mancati, le nevrosi di Benigni e Verdone, antesignani del campione d’incassi Checco Zalone (non presente tra le schede ma ampiamente evocato nella prima parte del volume), e in misura diversa il piglio grottesco del Volonté attore civile. Grazie a un discreto corredo iconografico, che isola sguardi e gesti pregnanti, il discorso non si limita a questioni storiografiche o sociologiche, ma coglie quelli che Dyer definisce «segni di performance»,[4] indispensabili per misurare lo stile recitativo di un divo in relazione al genere dell’opera e alle sue marche espressive. Lo sguardo, la voce, il respiro di un attore contribuiscono a rilanciare il carisma della star, e nello stesso tempo concorrono a catturare l’attenzione dello spettatore; il potere delle celebrità non risiede allora solo nell’abbaglio dei riflettori ma si fonda anche sulla qualità dell’interpretazione, sulle traiettorie empatiche che la performance è in grado di attivare.
Dopo aver sfogliato l’ultimo ritratto contenuto nella galleria, e sintomaticamente dedicato alla metamorfosi divistica di Riccardo Scamarcio, vien da pensare che tutto quanto ruoti intorno al mondo delle star non può non interessarci, perché riguarda il modo in cui una società costruisce la propria vocazione identitaria, contrattando logiche di produzione e sfere del desiderio. Sotto la ‘polvere di stelle’ si nasconde e pulsa il battito di una nazione: non è più – con buona pace di Samuel Goldwyn («Dio fa le star. È compito del produttore trovarle») – solo questione di soldi.
1 Cfr. almeno R. Dyer, The Culture of Queers, London, Routledge, 2002.
2 G. Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, Roma-Bari, Laterza, 2003, II voll., p. 291.
3 A. O’Leary, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e Memoria, Angelica, Tissi, 2007.
4 R. Dyer, Star, tr. it. di C. Capetta, D. Paggiaro, A. Verze, Torino, Kaplan, 2009, pp. 163-181.