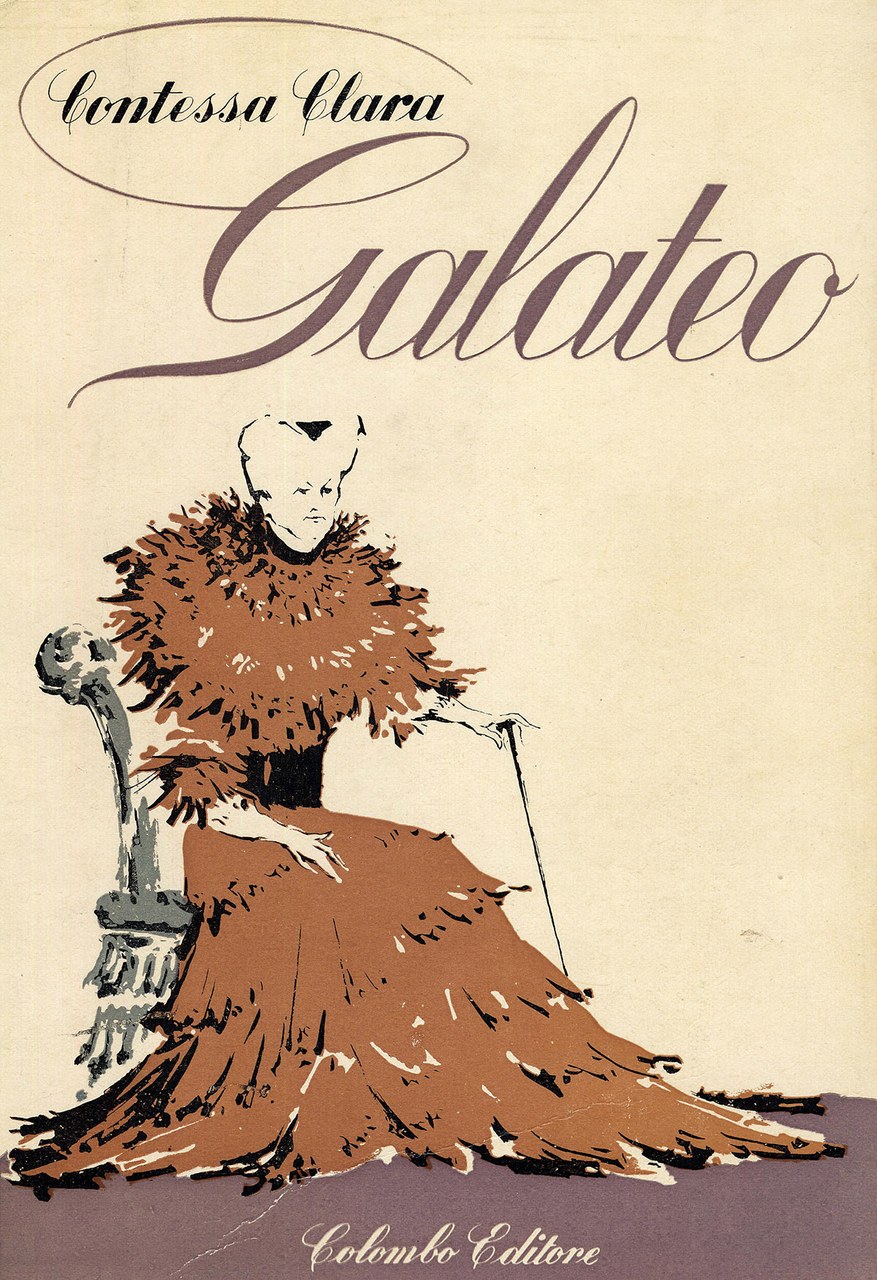È il 16 marzo 1974 quando, sul programma nazionale televisivo, si accendono per la prima volta ‘mille luci’ sulla storia dello spettacolo musicale: si tratta di una rievocazione in grande stile, destinata a segnare una tappa ineguagliata per la televisione italiana non solo per l’ingente dispiegamento di mezzi finanziari, ma anche per l’attenta rilettura dello spettacolo musicale che lo show propone. Il pubblico mostra di gradire l’operazione, assicurando al programma un successo attestato da 24 milioni di spettatori, che costituiscono un assoluto record per l’epoca,[1] forse attratti dal titolo del programma che, oltre a richiamare l’opulenza e la retorica altisonante dello show business, costituisce una pausa rilassante nel difficile clima dell’austerity.
In effetti, le misure introdotte dal governo Rumor nel dicembre 1973 per contrastare le conseguenze della crisi petrolifera non hanno ripercussioni solo sui trasporti, ma investono numerosi aspetti della vita quotidiana tra cui il consumo di media, come cinema e televisione, che subiscono contrazioni nella programmazione.[2] Perciò le ‘mille luci’ del varietà diretto da Antonello Falqui – da spegnersi rigorosamente prima dell’ora fatidica del coprifuoco – aprono a una pluralità di aspettative e di direzioni cui lo show cerca di far fronte.
È d’altra parte difficile inventare un format musicale inedito e originale. Come hanno messo in luce Luisella Bolla e Flaminia Cardini, la «macchina sonora» della Rai[3] ha già prodotto decine di programmi che fanno della musica il loro punto di forza. Accanto ai consolidati Canzonissima – un vero e proprio cavallo di battaglia del varietà sostenuto da una competizione canora, in onda dal 1956 al 1975 – e Teatro 10, che nel 1972 raggiunge la terza edizione, presentata da Alberto Lupo con Mina, le tipologie di show musicali più frequentate sono diverse. Oltre alle proposte dedicate ai singoli generi musicali (dal pop al jazz alla musica classica) e ai loro principali protagonisti,[4] in particolare dall’inizio degli anni Settanta si avviano percorsi più innovativi, organizzati come viaggi alla scoperta di territori, culture, tematiche che prendono forma anche attraverso le canzoni. È il caso di Europa Folk e pop (di Gianni Minà e Gian Piero Ricci), seguito, l’anno successivo (1973) da Folk e pop nell’America latina, due itinerari di perlustrazione e conoscenza di spazi geografici e musicali; ma anche di format come Milledischi, trasmesso dal 1971 con l’obiettivo di arginare la crisi del disco valorizzando tutte le novità (dalla musica classica al jazz e folk e canzonette) o Adesso musica dell’anno successivo con la medesima formula.