Affrontare i rapporti di uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento con il cinema risulta complesso perché sottende in generale la questione del confronto tra i due codici e, nello specifico, il rapporto problematico e ambivalente che Calvino intrattiene con il cinema.
Con queste premesse, tre sarebbero gli approcci possibili: dar conto di Calvino come spettatore e/o critico cinematografico (si va dall’esperienza autobiografica di un osservatore vorace e dilettante al territorio della critica del cinema); verificare come la scrittura di dell’autore sia variamente reattiva rispetto al cinema attraverso l’interpretazione delle forme testuali e la comparazione tra codice scritto e codice visivo; considerare i film tratti da testi di Calvino.[1] I primi due aspetti, che qui si prendono in esame, sono tra loro interconnessi.
Esiste un testo che esemplifica entrambe le tipologie – Calvino come critico/spettatore e come scrittore – e che rende manifesta in modo esemplare la calviniana oscillazione tra attrazione e repulsione nei confronti del cinema. Si tratta di un articolo pubblicato da Calvino sulla rivista Cinema Nuovo nell’agosto del 1955, scritto come reportage dalla Mostra di Venezia, pochi giorni dopo la morte di Thomas Mann. La prosa, che assume la forma dell’apologo, s’intitola La noia a Venezia. Cosa accadrebbe – si chiede Calvino – se Gustav Von Aschenbach, il protagonista della Morte a Venezia, ricapitasse al Lido oggi, al tempo della mostra? Abbiamo dunque la simulazione narrativa del confronto fra un eroe letterario ‘intellettuale’ novecentesco e il cinema moderno, in uno dei suoi luoghi allegorici.
Calvino, da cronista mondano e arguto, immagina che Von Aschenbach, osservando nel suo paese i cartelloni di un cinema di periferia in cui si proietta un film americano, venga colto da un senso di inferiorità e al contempo da attrazione. A causa del decaduto prestigio e della minore capacità attrattiva della sua scrittura, rimane soggiogato e sedotto dalla potenza del cinema, «tecnica e baraccone, volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi lo fa e per chi lo vede»,[2] e decide quindi di ripartire per il Lido. Giunto tra i riflettori, tra divi e giornalisti, Aschenbach non è più attratto dall’efebo Tadzio ma da una starlette, un’attricetta ai primi passi della sua carriera, «tutta seno e coscienza che nulla al mondo conti più di quel seno».[3] E l’attraente volgarità della ragazza-oggetto lo spinge a trovar lavoro come sceneggiatore. Alla fine, lo scrittore muore non di colera ma di noia «eterna nemica del cinema e sua sorella carnale», fissando lo sguardo sul seno della ragazza che «a furia di essere ostentato non significa più nulla»:[4]
Aschenbach è preso da un senso d’inferiorità, lui con le sue pagine così avare ed esangui, e gli viene un terribile desiderio di tutte le cose che il cinema è e dà, la realtà più immediata e l’idealizzazione più smaccata, una libertà d’espressione grande quanto il mondo visibile e una convenzione codificata all’estremo, la fama più altisonante e impudica, l’atmosfera di ricchezza onnipotente, e insieme il senso di lavorare per un mondo di povera gente, per le folle anonime che si stiperanno nelle sale buie. Per tutto quel che il cinema è: tecnica e baraccone, volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi lo fa e per chi lo vede.[5]
La noia, eterna nemica del cinema e sua sorella carnale, come sorelle si riconoscono, nel dialogo leopardiano, Moda e Morte. Il cinema, gran macchina e baraccone e industria, che aveva affascinato Aschenbach, il cinema che crea e assimila miti e poi li ripete e li rimastica, il cinema, la cosa più divertente che esista, basta si stacchi dalla scoperta di qualcosa di vero e nuovo […] e subito comincia a macinare noia.[6]
Questa breve prosa, apologo o parabola, mobilita al cospetto del cinema sia la vicenda letteraria di Von Aschenbach che il leopardiano Dialogo della moda e della morte, che interessò Benjamin, per alludere – in modo solo apparentemente scherzoso – ai due campi conflittuali, a proposito dei quali è all’opera quella costante stilistica calviniana che Asor Rosa ha definito per la Giornata d’uno scrutatore il «carciofo della dialettica»: l’alternarsi di tesi e antitesi, come le foglie d’un carciofo, intorno a un centro vuoto. Su una nozione di valore estetico di tipo si direbbe settecentesco, sensista e leopardiano (l’opposizione emozione/noia) s’instaura infatti una spirale di opposizioni incentrate sulla coppia cinema/ letteratura: cinema come arte da baraccone e industria, divertimento di massa; letteratura come arte elitaria e solitaria; cinema come produzione superficiale di miti sempre nuovi e pericolo di saturazione degli stessi; letteratura come esperienza profonda ma saturnina, minacciata dalla sua propria desuetudine, soverchiata dal cinema. Come Humbert Humbert, Aschenbach s’invaghisce di una lolita ma finisce col morire di noia: la concorrenza del cinema sulla letteratura è soverchiante, lo scrittore ne è attratto, eccitato, divertito ma alla fine ne è annullato.
In una successiva conferenza del 1961, Dialogo di due scrittori in crisi, Calvino, fingendo di parlare con Cassola, metterà a nudo mediante figure angosciosamente naturalistiche a lui care (la desertificazione e l’invasione delle termiti, che compaiono anche nella Formica argentina e nelle Città invisibili) il centro vuoto di questa spirale contraddittoria:
Se il cinema restringe molto il campo del romanzo non è perché in qualche modo lo valga, ma perché dove passa il cinema non può più crescere un filo d’erba. Ancora tanti scrittori insistono nello scrivere romanzi in concorrenza con i film: e non raggiungono che risultati poetici minimi. Ambienti, personaggi, situazioni che il cinema ha fatto propri non possono più essere accostati dalla letteratura: come se fossero stati rosi dall’interno dalle termiti, appena gli s’avvicina la mano non ne resta che polvere.[7]
Calvino attribuisce dunque al cinema, in rapporto alla letteratura, l’ambiguità contraddittoria e perturbante della vitalità e dell’immediatezza: il fascino e la repulsione che il cinema esercita su di lui, sono condensati da termini come «smaccata», «altisonante», «impudica», e da folle che nelle sale «sbuffano», «sghignazzano», «ansimano».
1. Calvino spettatore e critico del cinema
Calvino ha divulgato un’immagine di sé come spettatore appassionato ma occasionale, ingenuo e dilettante. Inoltre, a rinforzo di questa tesi, ha affermato più volte che fra la sua passione per il cinema e quella per la letteratura vige un rapporto di ‘successione’: nell’adolescenza, dai tredici ai diciotto anni, si nutre quotidianamente di cinema e non di letteratura, e trova nei film di Hollywood degli anni Trenta la prima risposta al suo bisogno estetico primario.
In seguito, la letteratura si sostituisce al cinema: in tal modo il cinema sembra caratterizzarsi nella biografia intellettuale di Calvino come un ‘primo amore’, una fase propedeutica alla letteratura:
Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno, ed erano gli anni tra diciamo il Trentasei e la guerra […]. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo. […] Andavo al cinema al pomeriggio, scappando di casa di nascosto, o con la scusa di andare a studiare da qualche compagno…
Entrare all’ora dell’apertura mi garantiva la rara fortuna di vedere il film dal principio.[8]
Le predilezioni del giovane frequentatore di sale cinematografiche a Sanremo si desumono dal citatissimo scritto Autobiografia di uno spettatore (1974), prefazione al volume che raccoglie le sceneggiature di quattro film di Fellini, e dalle diverse risposte a questionari e interviste: esemplificative sono le Quattro domande sul cinema italiano (1961) e l’intervista di Lietta Tornabuoni apparsa sul quotidiano La Stampa il 23 agosto 1981, quando Calvino è designato presidente della giuria alla Mostra di Venezia. Si tratta di rievocazioni di un’epoca aurorale, perduta, legata a emozioni ‘unidimensionali’, forti e elementari (sensualità, esotismo, avventura). L’esperienza giovanile del cinema è al contempo ‘miracolo’ e ‘inganno’:
Ho pochi ricordi del muto, ma ricordo l’inizio del parlato: Africa parla, un documentario sulle belve feroci; o Trader Horn, che pure si svolgeva in Africa, ma credo che ci fossero scene di tortura inflitte dai selvaggi agli esploratori, e mia madre mi portò via, diceva che le scene impressionanti fanno male al sistema nervoso.[9]
La mia epoca va pressappoco dai Lancieri del Bengala con Gary Cooper e L’ammutinamento del Bounty con Charles Laughton e Clark Gable, fino alla morte di Jean Harlow (che rivissi tanti anni dopo come morte di Marlyn Monroe, in un’epoca più cosciente della carica nevrotica di ogni simbolo) […].[10]
Si può considerare la visione di Trader Horn del 1931 – esperienza filmica conturbante infantile interrotta dalla severità materna – come archetipo dell’incontro di Calvino con il cinema, avvenuto intorno ai dieci anni, nell’età ancora non «cosciente della carica nevrotica di ogni simbolo»: interamente all’insegna dell’immediatezza avventurosa, voyeuristica, esotico-erotica e dell’overdose emotivo-percettiva. Trader Horn è uno dei primi film sonori ricordati da Calvino, diretto da Van Dyke, il regista di Tarzan, l’uomo scimmia e dell’Uomo ombra. Si tratta della scoperta nel cuore dell’Africa nera – esemplare per la condensazione di stereotipi coloniali orientalisti e sessisti – di una bianca e bionda regina della giungla, figlia perduta di un missionario, impersonata da Edwina Booth, inselvatichita e seminuda, che frusta sadicamente i suoi sudditi neri ma poi s’innamora dell’esploratore e s’incivilisce. L’esperienza cinematografica per il giovanissimo Calvino ha dunque il carattere di un piacere ignoto: un «canto delle sirene» che agisce attraverso «le assurde voci del film, metallicamente deformate dai mezzi tecnici dell’epoca».[11]
Nel passare dal Calvino giovane spettatore al Calvino critico cinematografico, va detto in anteprima che sono trentasei le voci bibliografiche calviniane inerenti il cinema raccolte nell’appendice del volume L’avventura di uno spettatore: si tratta soprattutto di reportage sui set o di riflessioni come giurato o, ancora, di risposte a inchieste.
I primi resoconti risalgono agli anni Quaranta, scritti per l’edizione piemontese dell’Unità. Calvino è attento alle scazzottature degli attori, alle bellezze delle star. Uno dei primi articoli è il reportage da Lignana, nel vercellese, sul set di Riso amaro di Giuseppe De Santis, alla fine degli anni ’40. Lo scritto dal titolo Tra i pioppi della risaia la «cinecittà» delle mondine, del 14 luglio 1948, descrive la bellezza trionfale di Silvana Mangano nei panni della mondina che balla il boogie woogie e che mastica chewing gum: nuova versione italiana del sex appeal americano.
Lo sguardo di Calvino sul cinema è, dunque, al contempo voyeuristico e antropologico: quando per Il Contemporaneo, nell’aprile 1954, curerà una nuova corrispondenza (La televisione in risaia) dal medesimo paese in cui è stato girato Riso amaro, noterà come dopo un solo quinquennio stia subentrando ovunque la televisione, modificando a fondo le abitudini della vita associata, e le famiglie, nei luoghi della Mangano, non si riuniscano più nelle stalle ma nei bar o al circolo Enal.
I testi calviniani sul cinema divengono più numerosi tra gli anni Cinquanta e Sessanta, pubblicati soprattutto su Cinema Nuovo, la rivista di Aristarco. Il primo di questi scritti appare il primo maggio 1953 come contributo al dibattito su Realismo italiano nel cinema e nella narrativa, nel corso del quale erano intervenuti anche Alvaro, Carlo Bo, Vittorini e Sereni. La riflessione di Calvino si sposta ora dal cinema americano a quello francese e italiano ma il segno lasciato dalla fase aurorale hollywoodiana della sua esperienza primaria di spettatore è rimasto indelebile e produce una nostalgia che sembra del tutto atipica e inattesa in un dibattito degli anni ‘50 sul realismo:
A me il cinema quando assomiglia alla letteratura dà fastidio; e la letteratura quando assomiglia al cinema anche. […] Il mio cinema ideale resta – forse perché mi ha nutrito quotidianamente per tanti anni della mia adolescenza – quello americano dell’anteguerra, col suo catalogo di divi-personaggi, di convenzioni-situazioni, che corrispondono ad altrettante realtà o ad altrettante ipocrisie anch’esse storicamente reali e importanti; quei film mi divertivo a vederli, e mi divertivo ancor di più a rifletterci sopra, a smontarli, a demolirli […] cosicché anche quelli brutti erano interessanti e istruttivi. […] il film non è più quello strano fiore d’una pianta spuria e contaminata, con radici che vengono su dal circo equestre, dal castello dei misteri, dalle cartoline al bromo, dai tabelloni dei cantastorie. Ed è un fatto che io mi diverto meno.[12]
Di grande interesse qui è l’attenzione precoce, modellata dai film americani, sia per le forme semplici dei dispositivi narratologici (più ‘divertenti’ dei film neorealisti) che possono essere decostruiti nei loro elementi di base, che per quella fruizione spettacolare che imparenta il film ad altre forme di arte popolare.
Qualcosa, tuttavia, sembra mutare radicalmente negli anni del Miracolo economico, quando Calvino tenta di individuare una forma e una poetica filmica più congeniali al se stesso adulto e scrittore: rispondendo con altri scrittori (tra cui Anceschi, Ferrata, Pasolini, Fortini, Soldati) alle Quattro domande poste da Cinema Nuovo, Calvino infatti passa in rassegna i tre grandi capolavori italiani apparsi nel 1960: L’avventura di Antonioni, La dolce vita di Fellini e Rocco e i suoi fratelli di Visconti. I tre film per lui rappresentano «tre possibilità attuali di metodo d’espressione».[13] Dei tre, predilige nettamente la via di Antonioni, «la ricerca dei rapporti meno palesi tra gli esseri umani, tra le azioni, tra le parole, tra le cose».[14] Calvino infatti difende strenuamente L’avventura di Antonioni dal giudizio di Aristarco che inscrive il film nelle coordinate critiche e valutative tipiche del marxismo degli anni ’50, riconducendolo all’«esistenzialismo» e all’«avanguardia decadente».
La parola chiave stessa ‘Avventura’ in Calvino in questo scritto ha mutato, tramite Antonioni, il suo significato: non allude più al modo avventuroso-esotico di Tarzan o dei Lanceri del Bengala ed è divenuta un’ambigua occasione, un labirinto del desiderio e un geometrico groviglio da interpretare. I personaggi (Anna-Lea Massari, Claudia-Monica Vitti e l’architetto Sandro-Gabriele Ferzetti) vicini agli eroi calviniani della Speculazione edilizia o della Giornata d’uno scrutatore, l’ellissi narrativa rappresentata dalla scomparsa di Anna, i «rapporti meno palesi tra esseri umani, tra le azioni, tra parole, tra le cose»;[15] il paesaggio lunare delle Eolie che contiene la cifra del film, l’evanescenza della figura umana, la sua sparizione nel paesaggio, amplificate in Antonioni attraverso la precisione di alcune dissolvenze incrociate, sembrano davvero elementi comparabili o compatibili con la ricerca letteraria di Calvino, specie dalle Cosmicomiche in poi.
Eppure, questa forte intuizione è destinata a non aver corso: nel medesimo scritto, Calvino subito dopo aver valorizzato Antonioni si accanisce, con una serie di negazioni, a allontanare tra loro cinema e letteratura: «Raccontare in letteratura e raccontare in cinema sono operazioni che non hanno nulla in comune».[16] Una negazione perentoria che manterrà fino alla fine della sua vita: «Credo di non aver mai letto storie del cinema né testi di teorica cinematografica»; fino alla paradossale asserzione: «Per orientarmi mi basta la pubblicità».[17]
2. Calvino scrittore e il cinema
Questo cocciuto divorzio fra scrittura e cinema può sembrare davvero imprevisto e stravagante poiché, come è noto, Calvino è uno scrittore così eminentemente visivo che la sua vocazione scopica culmina in prose, come quelle di Palomar, interamente descrivibili come esplorazioni del mondo attraverso il senso della vista.
Se sembra mancare al Calvino spettatore una possibilità di dialogo, di comparazione e di mediazione tra i due poli opposti, del cinema e della letteratura, che si succedono nella sua esperienza, ci si può chiedere cosa accada a proposito del ‘tema’ cinema nella sua scrittura letteraria.
Il lavoro critico più noto sulla ‘visibilità’ calviniana è quello di Belpoliti, L’occhio di Calvino (1996). Ed è assai sintomatico che nel terzo capitolo dal titolo Occhio all’opera – in cui Belpoliti intende ripercorrere l’interesse di Calvino per l’arte, la fotografia, la pittura e il cinema – vi siano paragrafi dal titolo Fotografia, Pittura e Collezione e il cinema sia invece assente.
In effetti sono pochissimi i testi d’invenzione di Calvino in cui è tematizzato direttamente il cinema. L’esperienza del cinema compare come tema nella novella del ciclo di Marcovaldo che, secondo Maria Corti, divide esemplarmente la prima dalla seconda serie della raccolta: La fermata sbagliata. Al ciclo di Marcovaldo Calvino ha dedicato due serie di racconti: la prima, costituita da dieci testi, è uscita nel 1958; successivamente, nel 1963, Calvino ha raccolto in un unico volume, col titolo Marcovaldo ovvero le stagioni in città venti novelle, composte in anni diversi.
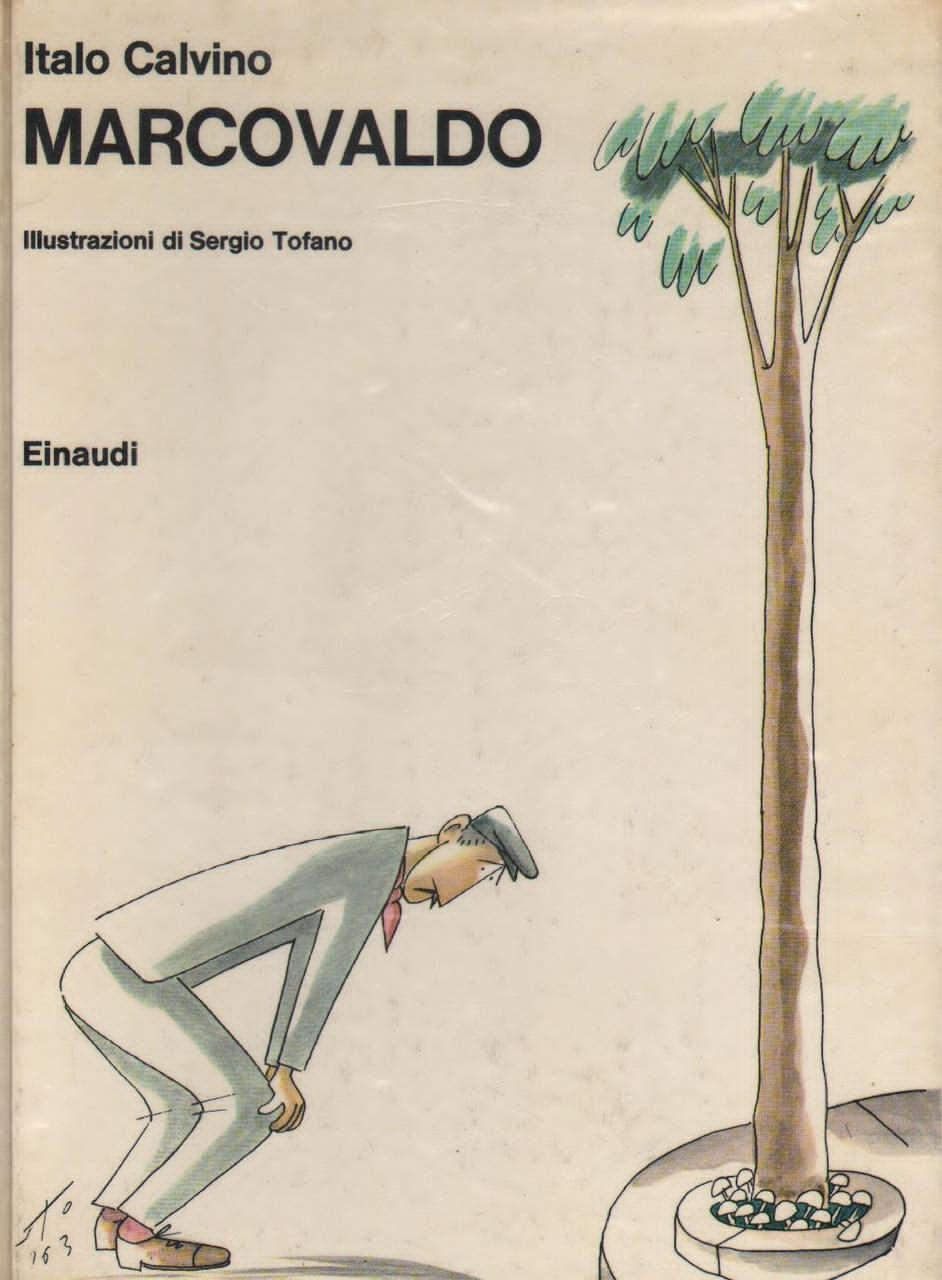
Le prime dieci novelle di Marcolvaldo sono state scritte tra il 1952 e il 1956, dunque negli anni che precedono il Miracolo economico; mentre la raccolta del 1963 invece comprende altri dieci testi interni alla piena modernizzazione italiana, con la rappresentazione dei media, della pubblicità e della cultura dei consumi.
Maria Corti ha studiato le strutture narrative di Marcovaldo, analizzando la prima raccolta e confrontandola con quella uscita nel 1963. [18] Ha rilevato in tal modo che nella prima raccolta la struttura portante è quella dei cicli stagionali secondo uno schema fisso e che le cose cambiano nella seconda raccolta, dove lo schema è più complesso. Subentrano macrosequenze autonome in cui prevale il movimento dal reale al surreale. Al centro delle novelle non è più, insomma, il contrasto binario città-natura ma la trasfigurazione surreale di elementi tecnologici o consumistici: la città vuota d’agosto, il carrello del supermarket, i buoni pubblicitari, i mezzi pubblici e, appunto, il cinema.
Per Maria Corti, la raccolta Marcovaldo non risulta omogenea e non ha l’organicità di un macrotesto: nei racconti più tardi naturale e artificiale si mescolano, si confondono, si scambiano le parti, il cielo stellato visto dall’abbaino è diviso tra l’immagine della luce lunare e quella della scritta pubblicitaria Gnac, le campagne di lancio dei detersivi a base di campioni-omaggio finiscono con l’invasione di una schiuma iridescente, indistinguibile dalle nuvole.
Si legge nell’incipit del racconto che ha per oggetto il cinema:
Per chi ha in uggia la casa inospitale, il rifugio preferito nelle serate fredde è sempre il cinema. La passione d Marcovaldo erano i film a colori, sullo schermo grande che permette d’abbracciare i più vasti orizzonti: praterie, montagne rocciose, foreste equatoriali, isole dove si vive contornati di fiori. Vedeva il film due volte, usciva solo quando il cinema chiudeva; e col pensiero continuava ad abitare quei paesaggi e a respirare quei colori. […] Quella sera, il film che aveva visto si svolgeva nelle foreste dell’India: dal sottobosco paludoso s’alzavano nuvole di vapori, e i serpenti salivano per le liane e s’arrampicavano alle statue d’antichi templi inghiottiti dalla giungla. All’uscita del cinema, aperse gli occhi sulla via, tornò a chiuderli, a riaprirli: non vedeva niente. Assolutamente niente. […] Venne il tram, evanescente come un fantasma, scampanellando lentamente; le cose esistevano appena quel tanto che basta; per Marcovaldo quella sera lo stare in fondo al tram, voltando la schiena agli altri passeggeri, fissando fuori dai vetri la notte vuota, attraversata solo da indistinte presenze luminose e da qualche ombra più nera del buio, era la situazione perfetta per sognare a occhi aperti, per proiettare davanti a sé dovunque andasse un film ininterrotto su uno schermo sconfinato.[19]
Maria Corti schematizza così La fermata sbagliata, racconto a suo giudizio esemplare del cambiamento tra le due parti della raccolta: Marcovaldo vede al cinema un film che si svolge nelle foreste dell’India; esce, c’è nebbia fitta; può riempire il vuoto visivo con le immagini del film (India, Gange giungla); sale in tram e a causa del sogno cinematografico a occhi aperti, sbaglia fermata; vaga disorientato, entra in un’osteria, beve; esce con la carica fantastica accresciuta dal vino; sale su un muro dall’orlo largo e illuminato; a zig zag continua a camminare su un prato con luci basse e su una grande strada asfaltata; sale su quello che crede un autobus dai morbidi sedili e chiede se ferma in via Pancranzietti; si sente rispondere che è in volo per Bombay; intorno sui sedili vede indiani col turbante; l’aereo vola oltre la nebbia.
Il cinema ha dunque messo nei guai Marcovaldo quasi quanto Von Aschenbach. È la vocazione a mantenere in vita l’illusione dei più «vasti orizzonti», creata dalla visione del film («praterie, isole, foreste equatoriali, isole dove si vive coronati di fiori») che, trasfigurando la città in una immaginaria Calcutta, crea desideri e disorientamento nel pulviscolo lattiginoso della nebbia. L’evasione al cinema sfocia in uno smarrimento fra luci e segni sconosciuti e infine in un viaggio aereo surreale – che si sostituisce al sogno – verso la vera Calcutta.
Si chiede Maria Corti: «Ma è partito Marcolvaldo? E che gli succederà? O il suo aereo è una grande allegoria? O è un sottile gioco nel disegno di una favola? Il finale polisemico è proprio tipico degli ultimi racconti della raccolta».
Una risposta ai quesiti interpretativi riguardanti la novella di Calvino che narra l’esperienza cinematografica, può venire da uno scritto dello stesso Calvino: la sua famosa lettura di Forse un mattino andando di Montale; lettura che intercetta il tema cinematografico e si lascia interpretare come un testo programmatico di autocoscienza e di poetica.
Forse un mattino interessa Calvino perché è un «osso di seppia» privo di oggetti (come la notte lattiginosa in cui si perde Marcovaldo), «priva di un paesaggio determinato» ed è una «poesia d’immaginazione e di pensiero astratti, come raramente in Montale».[20] Secondo Calvino è questa la prima volta che un poeta italiano utilizza il termine «schermo» in senso cinematografico:
La ricostruzione del mondo avviene «come su uno schermo» e qui la metafora non può che richiamare il cinema. La nostra tradizione poetica ha abitualmente usato la parola «schermo» nel significato di «riparo-occultamento» o di «diaframma», e se volessimo azzardarci ad affermare che questa è la prima volta che un poeta italiano usa «schermo» nel senso di «superficie su cui si proiettano immagini», credo che il rischio d’errore non sarebbe molto alto. Questa poesia (databile tra il 1921 e il 1925) appartiene chiaramente all’era del cinema, in cui il mondo corre davanti a noi come ombre d’una pellicola, alberi case colli si stendono su una tela di fondo bidimensionale, la rapidità del loro apparire («di gitto») e l’enumerazione evocano una successione d’immagini in movimento. Che siano immagini proiettate non è detto, il loro «accamparsi» (mettersi in campo, occupare un campo, ecco il campo visivo chiamato direttamente in causa) potrebbe anche non rimandare a una fonte o matrice dell’immagine, scaturire direttamente dallo schermo (come abbiamo visto avvenire dallo specchio), ma anche l’illusione dello spettatore al cinema è che le immagini vengano dallo schermo. L’illusione del mondo veniva tradizionalmente resa da poeti e drammaturghi con metafore teatrali; il nostro secolo sostituisce al mondo come teatro il mondo come cinematografo, vorticare d’immagini su una tela bianca.[21]
Calvino utilizza la fenomenologia della percezione, nel senso di Merleau-Ponty e della descrizione husserliana, per dar conto del barcollare senza punti di riferimento in Montale:
Merleau-Ponty nella Fenomenologia della percezione ha pagine molto belle sui casi in cui l’esperienza soggettiva dello spazio si separa dall’esperienza del mondo oggettivo (nel buio della notte, nel sogno, sotto l’influsso della droga, nella schizofrenia, etc.). Questa poesia potrebbe figurare nell’esemplificazione di Merleau-Ponty: lo spazio si distingue dal mondo e s’impone in quanto tale, vuoto e senza limiti. La scoperta è salutata dal poeta con favore, come «miracolo», come acquisizione di verità contrapposta all’«inganno consueto», ma anche sofferta come vertigine spaventosa: «con un terrore di ubriaco». Neanche «l’aria di vetro» sostiene più i passi dell’uomo; l’avvio librato dell’«andando», dopo il rapido volteggio, si risolve in un barcollare senza più punti di riferimento.[22]
Anche la scrittura di Calvino tende all’astrazione, persegue una stilizzazione della precisione concretamente percettiva: strenuo esercizio di stile che cerca, in virtù di un referente visivo, un’invenzione formale. Davanti alla materialità caotica Calvino reagisce purificando la propria prosa, prosciugando guazzabugli e labirinti. Se la scrittura di Gadda, ad esempio, come il cinema, è per Calvino un caravanserraglio, un calderone, un caos, un labirinto, un inganno, l’attitudine descrittiva e l’interesse per lo spazio e la sua percezione accomunano invece Calvino a Perec: lo sguardo dei due scrittori rallenta per permettere una messa a fuoco progressiva dei dettagli. La vista è per Calvino il senso galileiano della distanza critica che percependo le superfici delle cose si identifica con la conoscenza intellettuale.
Questo progetto – che è sensato pensare abbia, per ipotesi, la sua lontana origine reattiva nell’esperienza adolescente e voyeuristica di spettatore cinematografico – trova un suo estremo compimento in Palomar, uscito nel 1983, il cui titolo rinvia al telescopio di San Diego, all’epoca il più potente del mondo. L’immagine scelta da Calvino per la copertina della prima edizione riproduce Il disegnatore con donna sdraiata (1525), una xilografia di Albrecht Dürer.
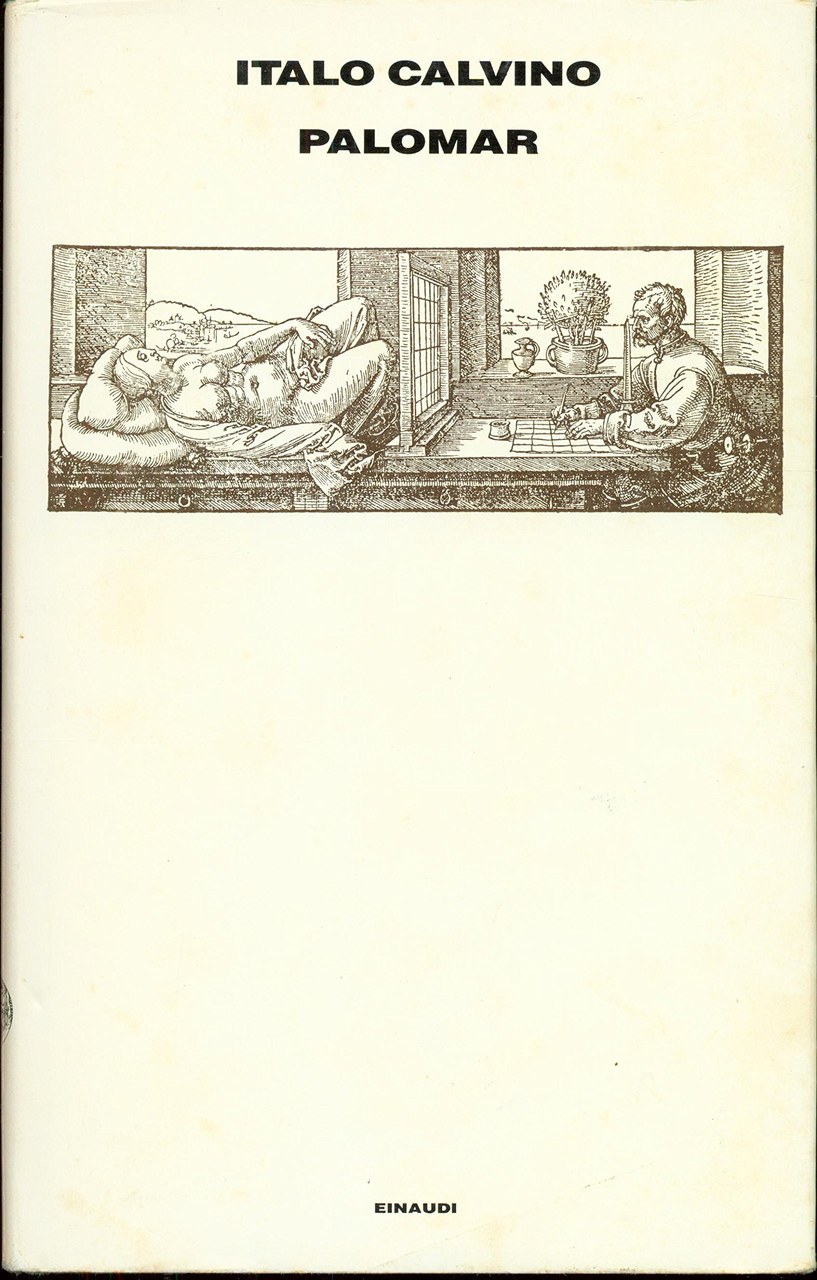
Il disegnatore osserva la modella nuda attraverso un oculare e una griglia a quadretti che gli permette di delimitarne e geometrizzarne i dettagli in modo sistematico, analitico e preciso; deve riportare ogni porzione dell’immagine vista dall’oculare regolabile sul suo foglio munito di griglia quadrettata. Allude non tanto all’imitazione di una realtà visiva, ma a una sua mediata rielaborazione concettuale con strumenti ottici.
Quando il signor Palomar decide di osservare un oggetto o un fenomeno che ha davanti agli occhi, pur nella sua distratta miopia, congettura metodi, traccia confini e dispone limiti. Così nel descrivere a esempio un’onda, cerca di isolare un dettaglio nella caotica realtà, lo scompone nei suoi minimi termini, per imporre le regole dell’ordine al regno dell’entropia o dell’incoerenza:
Un po’ miope, distratto, introverso, egli non sembra rientrare per temperamento in quel tipo umano che viene di solito definito un osservatore. Eppure gli è sempre successo che certe cose – un muro di pietre, un guscio di conchiglia, una foglia, una teiera, – gli si presentino come chiedendogli un’attenzione minuziosa e prolungata: egli si mette ad osservarle quasi senza rendersene conto e il suo sguardo comincia a percorrere tutti i dettagli, e non riesce più a staccarsene. […] presto s’accorge che sta guastando tutto, come sempre quando egli mette di mezzo il proprio io e tutti i problemi che ha col proprio io.
Ma come si fa a guardare qualcosa lasciando da parte l’io? Di chi sono gli occhi che guardano? […] Non è anche lui un pezzo di mondo che sta guardando un altro pezzo di mondo? […] Per guardare se stesso il mondo ha bisogno degli occhi (e degli occhiali) del signor Palomar.[23]
Come ha notato Gianni Celati, in Palomar la ricerca di Calvino approda a un’istanza di abbandono, a un congedo rispetto alla possibilità di padroneggiare l’esperienza.[24]La pedagogia dell’immaginazione e il controllo della visione, propugnati nelle Lezioni americane davanti al diluvio postmoderno delle immagini, possono avere in tal modo la loro lontana origine in un’esperienza delle immagini protomoderna, ancora rozza ma già immersiva e totalizzante: le incursioni al cinema a San Remo nell’adolescenza:
[…] quale sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella che si usa chiamare «civiltà dell’immagine»? Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umanità sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? […] Penso a una possibile pedagogia dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente «icastica».[25]
Che questo programma pedagogico, capitale per capire Calvino, e da lui perseguito in misura crescente specie in Palomar, riceva proprio dall’esperienza primigenia del cinema la sua spinta archimedica, viene confermato dalla consonanza tra questa pagina delle Lezioni e quella relativa a Forse un mattino andando di Montale che tratta come omologhi lo schermo (cinematografico) e l’esperienza del nulla:
Non è una indeterminata sensazione di dissoluzione: è la costruzione d’un modello conoscitivo che non è facile da smentire e che può coesistere in noi con altri modelli più o meno empirici. L’ipotesi può essere enunciata in termini molto semplici e rigorosi: data la bipartizione dello spazio che ci circonda in un campo visuale davanti ai nostri occhi e un campo invisibile alle nostre spalle, si definisce il primo come schermo d’inganni e il secondo come un vuoto che è la vera sostanza del mondo.[26]
Il cinema per Calvino è uno «schermo d’inganni», (montalianamente, un inganno consueto) un fluire seducente, rumoroso e ingombrante di immagini in movimento, una calamita divertente e pericolosa, che colonizza l’immagine-percezione, e non va mai oltre il grado zero di ogni immagine cinematografica, come risposta allo stimolo senso-motorio elementare fatto di azioni concatenate in una trama: grossomodo quello che per il Deleuze dell’Immagine-movimento (1983) e dell’Immagine-tempo (1985) è il ‘cinema classico’. Nonostante le acute osservazioni su L’avventura di Antonioni, non sa teorizzare il ‘cinema moderno’ con il suo proliferare di specchi, di doppi, di personaggi riflessivi più che attivi.
Riconosciamo in filigrana in Von Aschenbach personaggio dell’apologo calviniano che muore un’altra volta al Lido di Venezia osservando un seno, in Marcovaldo spaesato nella nebbia che s’imbarca senza volerlo in un aereo, in Palomar (anch’egli oculato osservatore di seni) che impara a desoggettivare il proprio sguardo per geometrizzare il mondo, una medesima esperienza della modernità.
La scrittura visiva calviniana esige la messa in forma in un sistema di segni diverso dal cinema per fermare, fissare, simulare il piano percettivo: vuole che questi segni si cristallizzino in una forma ben definita, memorabile. Avverte nello schermo d’inganni, tanto amato da ragazzino un’irrealtà ‘immediata, smaccata, altisonante, impudica’. Ciò che questo doppio legame suggerisce riguardo al dialogo fra letteratura e cinema nel Novecento, e riguardo all’attuale rapporto fra scrittura e cultura visiva e intermediale, resta ancora da dire e di certo sfugge alle possibilità di chi scrive. Quanto a Calvino, pare costituisca una non secondaria ragione del suo ‘pathos della distanza’, della sua mediata e meditata ‘registrazione del visibile’.
Marcovaldo, Lezioni americane, Visibilità,, critica cinematografica, Eugenio Montale
1 Per quest’ultimo aspetto questo si rinvia a V. Santoro, Calvino e il cinema, Macerata, Quodlibet, 2011 e alla dettagliata filmografia calviniana presente in L. Pellizzari (a cura di), L’avventura di uno spettatore. Calvino e il cinema, Bergamo, Lubrina Editore, 1990.
2 I. Calvino, ‘La noia a Venezia’, Cinema Nuovo, IV, 65, 25 agosto 1955, pp. 133-134, ora in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, p. 1907.
3 Ibidem.
4 Ivi, p. 1908.
5 Ivi, p. 1907.
6 Ivi, p. 1908.
7 I. Calvino, ‘Dialogo di due scrittori in crisi’, in Una pietra sopra (1980), ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 87. Si ricorda che tra il 1955 e il 1961 si è consumata anche la storia d’amore di Calvino con Elsa De Giorgi, attrice del cinema già negli anni Trenta, testimoniata da un carteggio che Maria Corti (in Ombre dal fondo, Torino, Einaudi, 1997) ha definito il più bell’epistolario d’amore del ’900. Senza in alcun modo dare spazio a una critica biografica o peggio scandalistica, si ricorre a questa nota biografica solo per dare l’idea della forza di seduzione che Calvino avverte nel cinema e per dar conto di una polarità attrattiva e respingente.
8 I. Calvino, ‘Calvino: il cinema inesistente’, intervista a cura di L. Tornabuoni, La Stampa, 23 agosto 1981.
9 Ibidem.
10 I. Calvino, ‘Autobiografia di uno spettatore’, prefazione a F. Fellini, Quattro film, Torino, Einaudi, 1974, ora in I. Calvino, Romanzi e racconti, edizione diretta da C. Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, con una bibliografia degli scritti di Italo Calvino a cura di Luca Baranelli, Milano, Mondadori, 1994, vol. III, p. 33.
11 M. Palumbo, ‘“Quell’altro mondo che era il mondo”. Calvino e il cinema’, Italies, 16, 2012, p. 32.
12 I. Calvino, ‘Il realismo italiano nel cinema e nella narrativa’, Cinema Nuovo, II , 10, 1 maggio 1953, p. 262, ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 1888.
13 I. Calvino, Quattro domande sul cinema italiano, Cinema Nuovo, X, 141, gennaio-febbraio 1961, pp. 32-35, ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 1924.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 I. Calvino, ‘Quattro domande sul cinema italiano’, Cinema Nuovo, X, 141, gennaio-febbraio 1961, pp. 32-35, ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 1926
17 I. Calvino, ‘Calvino: il cinema inesistente’, intervista a cura di L. Tornabuoni.
18 M. Corti, ‘Testi o macrotesto? I racconti di Marcovaldo’, in Ead., Il viaggio testuale. Le ideologie e le strutture semiotiche, Torino, Einaudi, 1978, pp.185-200.
19 I. Calvino, ‘La fermata sbagliata’, in Marcovaldo ovvero le stagioni in città (1963), ora in Id. Romanzi e racconti, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, prefazione di J. Starobinski, vol. I, Milano, Mondadori, 1991, p. 1123.
20 I. Calvino, ‘«Forse un mattino andando»’, in Letture montaliane in occasione dell'80° compleanno del Poeta, Genova, Bozzi, 1977, pp. 35-45, ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 1180.
21 Ivi, p. 1188.
22 Ivi, pp. 1182-1183.
23 I. Calvino, Palomar (1983), ora in Id. Romanzi e racconti, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, introduzione di C. Milanini, Milano, Mondadori, vol. II, 1992, pp. 968-969.
24 G. Celati, ‘Palomar nella prosa del mondo’, in Nuova corrente, 34, luglio-dicembre 1987, pp. 227-242.
25 I. Calvino, Lezioni americane (1988), ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 707-708.
26 I. Calvino, ‘«Forse un mattino andando»’, ora in Id., Saggi 1945-1985, p. 1184.