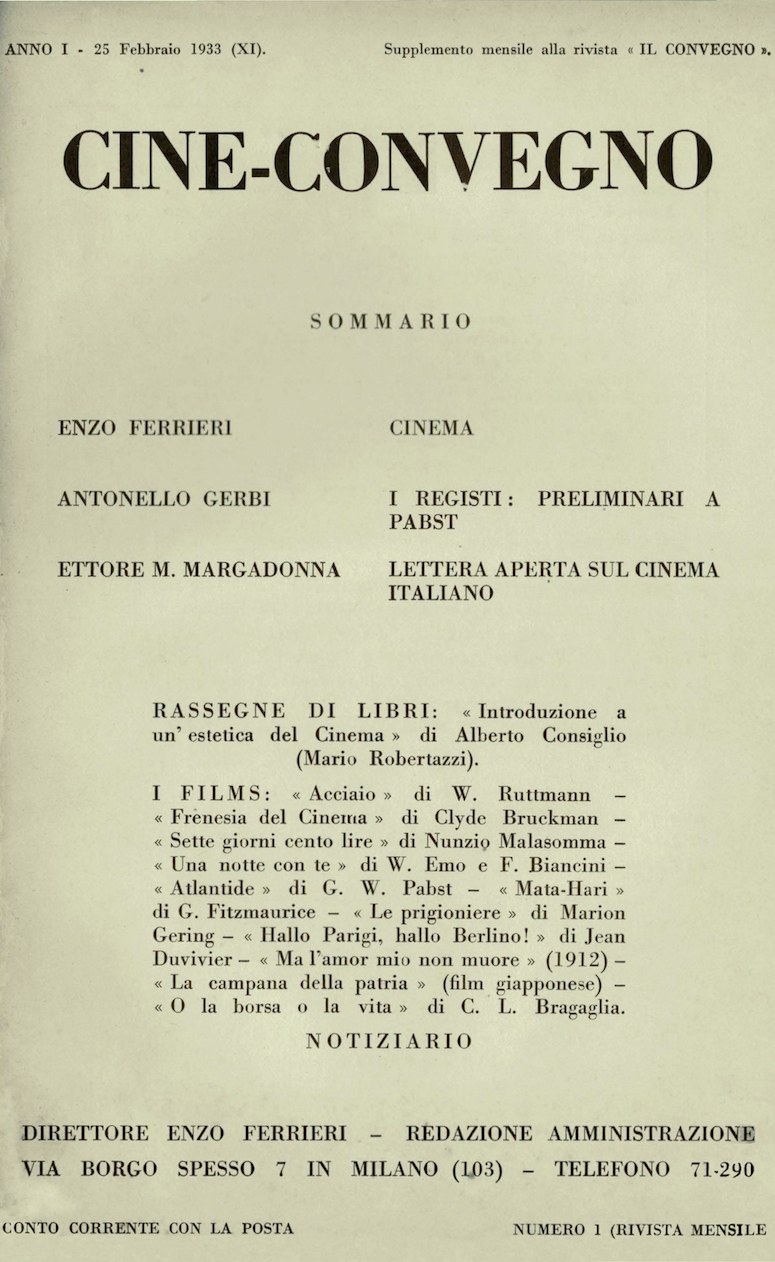Il recente riordino dell’archivio della casa editrice pisana Nistri-Lischi ha riportato alla luce dieci annate della rivista culturale La Rassegna, diretta dall’editore Luciano Lischi, a partire dalla fine degli anni Quaranta e per tutti gli anni Cinquanta.[1] Dallo scrutinio dei numeri del 1952 sono emersi due articoli nei quali un giovane Vittorio Taviani (nato a San Miniato, nel 1929, due anni prima del fratello Paolo) recensisce in modo circostanziato altrettanti studi cinematografici appena pubblicati da Einaudi, la Storia del cinema di Georges Sadoul, nel 1951,[2] e Cinema arte figurativa di Carlo Ludovico Ragghianti, nel 1952,[3] subito inseritisi nell’articolato e acceso dibattito storiografico e teorico di quegli anni.
Le due recensioni, mentre illuminano tratti salienti di quella dialettica di voci e prospettive, restituiscono un’istanza critica militante tipica del periodo e una componente significativa dell’humus culturale e della riflessione cinematografica che contribuirono alla formazione dei due fratelli, marcandone gli esordi realizzativi al fianco di Valentino Orsini. Qui mi occuperò dell’articolo dedicato al volume di Ragghianti, tra i due il più ricco di ragionamenti e riferimenti teorico-critici e capace, per questo, di consegnarci – attraverso il suo posizionamento rispetto alle questioni affrontate, l’atteggiamento estetico-ideologico di fondo e l’indicazione di alcuni numi tutelari – i semi di taluni aspetti significativi dell’opera e del discorso cinematografici venturi.