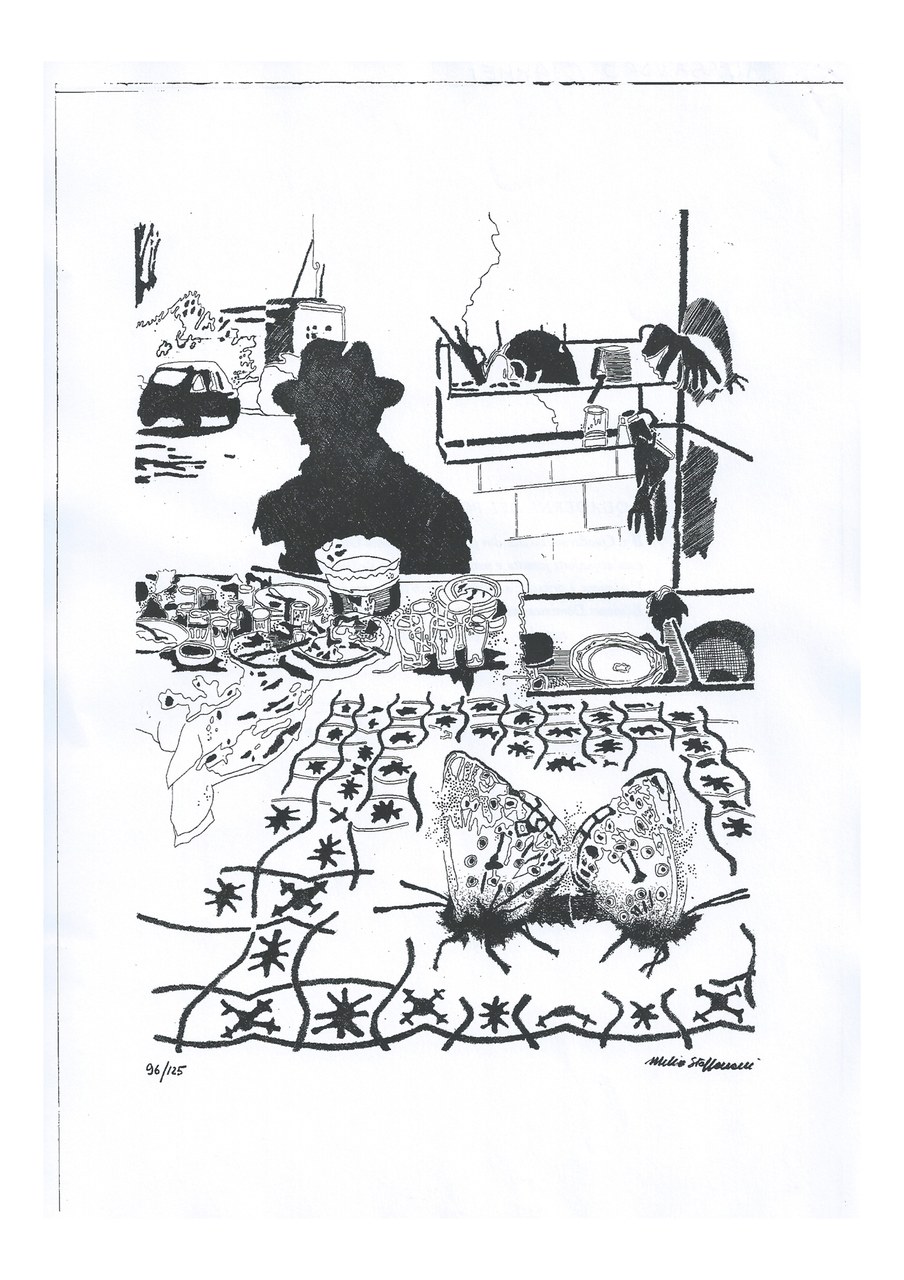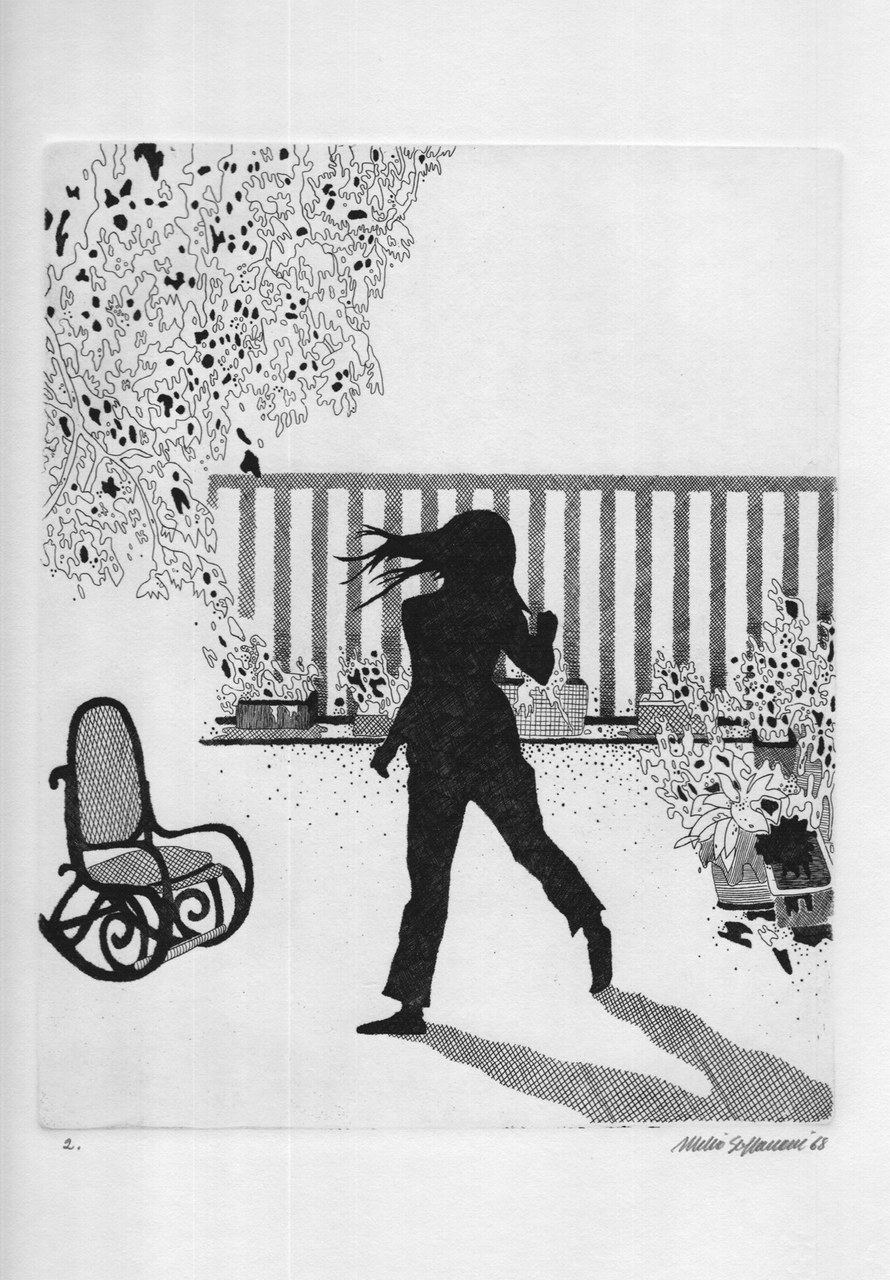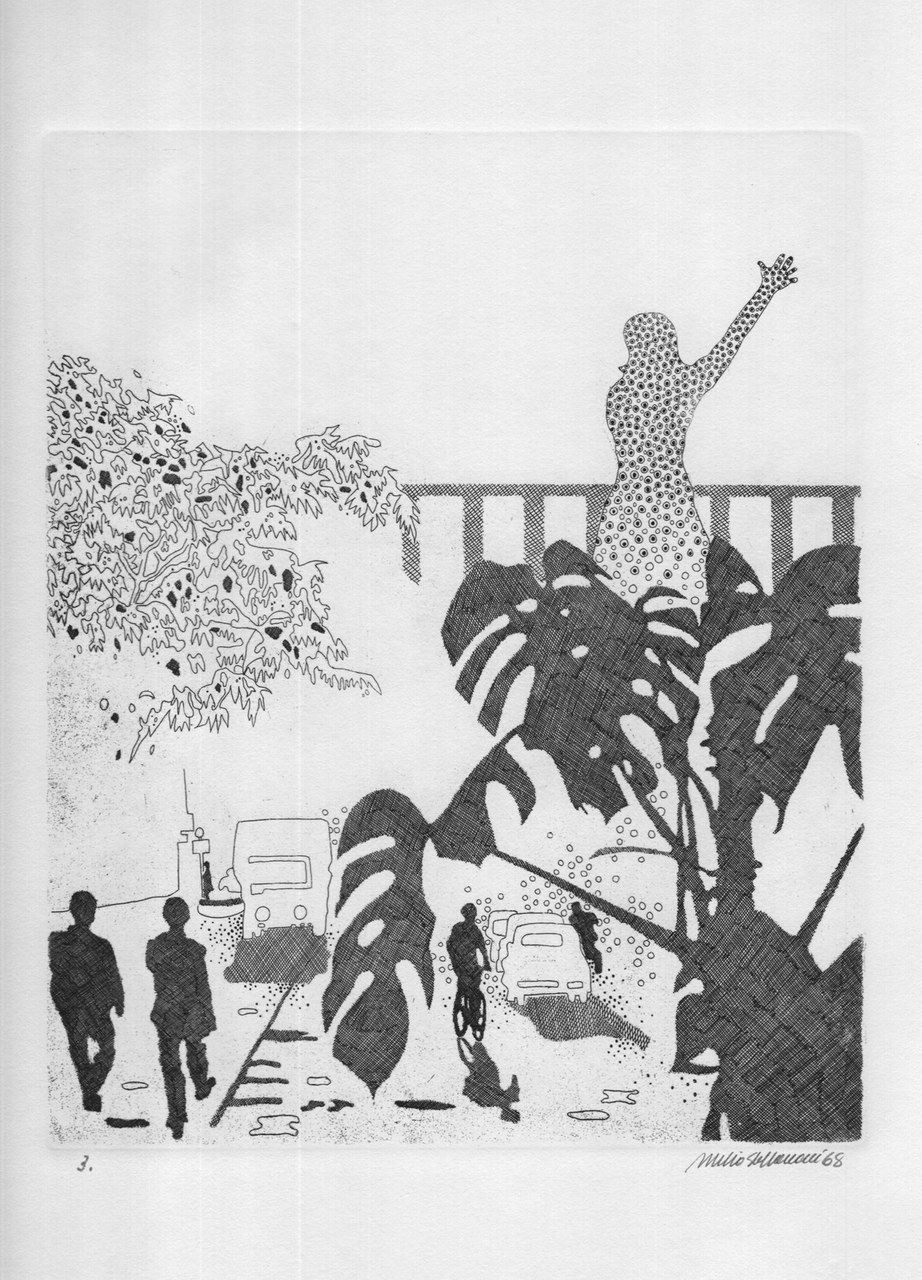Il volume di Marcello Ciccuto (Torino, Aragno, 2018) è una monografia sul fitto intreccio dell’opera poetica e prosastica di Montale con il mondo delle arti. La contaminazione di codici, così tipica della difficoltà (a volte dell’ambiguità) della scrittura montaliana, è al centro della dissertazione dell’autore che insegue la miriade di letture ed esperienze culturali del poeta alla base dell’elaborazione di un personalissimo modello critico applicabile, senza soluzione di continuità, a tutte le espressioni artistiche. Questo vasto approccio ermeneutico, che vede il poeta accostare in maniera significante l’impressionismo storico al verismo musicale, l’opera di Gatto a quella del primo de Chirico, la poesia di Pea alle sculture classiche, viene indagato mettendo in luce consapevolmente ciascun riferimento. L’intera analisi di Ciccuto dimostra come «i cenni di cultura figurativa in Montale siano invariabilmente pluri-direzionali e assommino più esperienze visive e mentali» (p. 281) ricostruendo così una vera e propria teoria estetica montaliana.
La sequenza dei dieci capitoli dell’indice suggerisce un percorso attraverso la coscienza artistica di Montale: nei primi capitoli (Una specchiata indifferenza; Impressionismo, arabeschi, astrazioni; Polifonie cromatiche) l’autore descrive l’allontanamento del poeta dalla «gioia luminosa» impressionista per dimostrare l’adesione ad una «metafisica arida e decolorata» realizzata in «linee profonde, scultoree, monocromatiche» (p. 37, poi in Effetto scultura e Realismo Metafisico). L’aridità, riconosciuta in Sbarbaro, Svevo, Emanueli, Gide, De Falla, è strettamente connessa alla riduzione di tono, espressione di una poetica schiva dalla «seduzione mimetica» e lontana dalle fredde soluzioni delle fotografie realistiche (tema del capitolo Contro il fotografico) per andare, ricalcando i titoli di altri capitoli, Verso una nuova visione classica seguendo il Magistero di Paul Cézanne