Tra il 1966 e il 1985 la casa editrice Rizzoli pubblica nella collana I Classici dell’Arte centoundici volumi monografici dedicati ad una selezione dei nomi più importanti della pittura europea, dai prodromi del Rinascimento italiano (Duccio, Giotto, Martini) sino ad artisti quali Toulouse-Lautrec, Schiele, De Chirico.
Particolarmente felice la scelta editoriale per cui in apertura di ogni volume la presentazione dell’artista e delle opere è affidata, talvolta sì a critici d’arte di professione, ma molto spesso a firme celebri della letteratura italiana del Novecento, istituendo una sorta di parallelo tra i grandi classici delle due arti. Oltre agli esempi indagati dal presente contributo (Flaiano e Paolo Uccello, Buzzati e Bosch, Ungaretti e Vermeer, Testori e Grünewald, Morante e Beato Angelico, Volponi e Masaccio) si citino, a titolo esemplificativo, le prefazioni di Luzi su Matisse, quella di Palazzeschi su Boccioni, di Sciascia su Antonello, di Moravia sul Picasso del periodo blu e rosa e ancora di Quasimodo su Michelangelo.
Nonostante la varietà degli esiti le tipologie testuali censite appaiono classificabili entro categorie che, sebbene non riescano a rendere conto di tutte le possibilità espressive attuate ed attuabili, funzionano comunque da utili linee guida per un approccio di tipo finalmente sistematico all’argomento. Le formule saggistiche qui individuate mostrano tre modalità differenti tramite cui questi scrittori-critici hanno affrontato il fatto artistico: si va dall’adozione di generi dichiaratamente eterodossi, come la drammatizzazione e la novella fantastica (Flaiano e Buzzati), alla più tradizionale forma saggistica, connotata però in senso fortemente personale: se in alcuni casi l’autore interpreta l’artista a partire dal proprio universo poetico-simbolico ed esistenziale in qualche modo appropriandosene (Testori e Ungaretti), in altri preferisce invece porre l’accento sugli aspetti biografici e sulla contestualizzazione storico-culturale alla ricerca di possibili punti di contatto con la contemporaneità (Volponi e Morante).
1. «L’immaginazione che fiorisce sul metodo»
La citazione longhiana[1] che dà il titolo a questa prima categoria illumina la caratteristica fondamentale di quelle tipologie testuali eccentriche il cui comune tratto distintivo risiede nella capacità di coniugare invenzione letteraria e intento critico. La novella fantastica Il maestro del Giudizio universale di Dino Buzzati, così come la drammatizzazione Il tempo dietro il tempo di Ennio Flaiano, costituiscono esempi particolarmente rappresentativi di finzionalizzazione della scrittura saggistica. Al di là dell’analogia riscontrata a livello macro-testuale, differenti risultano però le strategie micro-stilistiche messe in atto dai due autori.
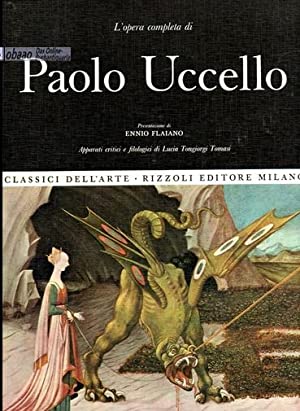
Ne Il tempo dietro il tempo la scelta della forma, un dialogo[2] fantastico tra lo scrittore e il pittore Paolo Uccello, si rivela la chiave più adatta per accedere all’universo di un artista dallo sguardo straniato e fiabesco quale fu quello del fiorentino, ma permette pure a chi scrive un agile sconfinamento verso questioni altre della storia dell’arte, e non a caso Mengaldo indica questa come la forma preferita dai critici più «egocentrici».[3]
Tramite l’espediente dialogico Flaiano tocca, seppur marginalmente, tematiche riguardanti lo statuto ontologico dell’arte e il problema della sua interpretazione, tanto che proprio l’attitudine meta-critica appare come la cifra fondamentale del testo.

L’ecfrasi flaianea si dispiega attraverso i molteplici riferimenti ad altri media (letteratura, fotografia, cinema)[4] e a forme artistiche proprie dell’estetica contemporanea («happening»), oltre che facendo ricorso a specifici fenomeni sintattici e retorici (si veda ad esempio nel brano che segue la ripetizione anaforica[5] del verbo restare, «Restano»/«Resta»/«Resta»). Così a proposito degli errori prospettici nella Battaglia di San Romano farà dire al suo Paolo Uccello:
Con questo errore io insinuo nel riguardante il sospetto che la morte riduce gli uomini, anche i guerrieri più possenti, a poveri fantocci, non solo fuori del tempo, ma dello spazio.
Vista dall’alto, una battaglia può sembrare una festa campestre, vista dal combattente è soltanto confusione, paura e dolore. La verità è nel mezzo, ogni battaglia è un happening, con la logica ferrea che la fa mostruosa poiché si trasforma, nello stesso attimo in cui si realizza, in un continuo mobile. Restano di una battaglia alcuni flashes, non necessariamente cronologici e prospettivi. Resta lo stupore dei cavalli bianchi e neri, e anche di quelli rosa e celeste, lo stesso stupore arrogante dei cavalli delle giostre. Resta l’immobilità dei cavalieri, i loro gesti fissati negli attimi che precedono la morte.[6]
Flaiano/Uccello procede poi per via di paragoni e similitudini con altri artisti,[7] dagli eccentrici pittori-matematici quali il Doganiere, Morandi e Mondrian, sentiti come «di una stessa specie»,[8] a Picasso, la cui opera è considerata sintesi e punto di arrivo dell’intera storia dell’arte proprio per via della sua attitudine meta-riflessiva. Si legge infatti:
“La pittura non si spiega sempre con la letteratura”. Giusto: c’è un punto in cui le spiegazioni sono vane, oppure la pittura non si spiega che con altra pittura, come fa lo spagnolo, Picasso: il quale io dico che è muto che tiene lezioni sulla pittura di molte epoche, facendone un commento e un riepilogo, prima della fine.[9]
Queste righe suggeriscono che soltanto colui che è a sua volta artista è davvero in grado comprendere il linguaggio muto della pittura e farne una critica che non snaturi l’opera nel tentativo estremo di razionalizzarla. Picasso non soltanto ricopre un ruolo speciale nella storia dell’arte ma viene citato anche perché si trova in una posizione simile e allo stesso tempo antitetica rispetto a Paolo Uccello, entrambi sono a modo loro ossessionati dalla prospettiva, tuttavia mentre il fiorentino isola e fissa gli oggetti ognuno col proprio punto di fuga, per lo spagnolo è come se la prospettiva li rifiutasse e perciò lui non può smettere di disegnarli, sempre gli stessi per infinite volte e da infiniti punti di vista.
Ancora Flaiano/Uccello non manca di confrontarsi con l’interpretazione che la critica contemporanea ha dato di lui alla luce di fatti artistici venuti molto dopo nel tempo, portandoci dritti nel dibattito critico che ha realmente interessato la sua opera. Egli stesso racconterà:
La mia naiveté mi ha procurato anche la fugace menzione di precursore dell’odierno surrealismo.[10]
Infatti proprio quegli elementi della sua pittura che in pieno Rinascimento furono giudicati come difetti in quanto scarto rispetto a una norma, segnarono il suo successo presso i moderni, i quali lo hanno giudicato secondo categorie artistiche proprie dei secoli successivi.
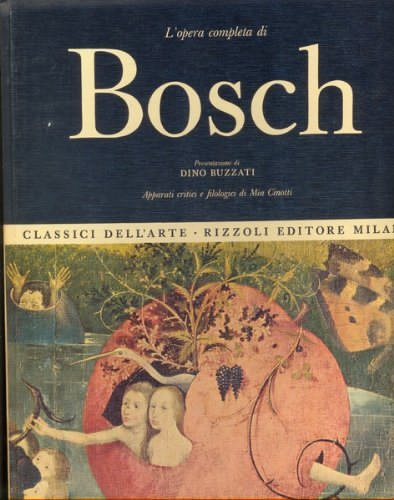
Questa sorta di anacronismo interpretativo ha riguardato, forse ancor di più, l’opera di Hieronymus Bosch:
Parlano dell’inferno, parlano della dannazione eterna, parlano di sant’Agostino, delle eresie, della riforma di Lutero, vanno a frugare nella vita privata di Hieronymus, che nessuno di loro può conoscere, riempiono centinaia di pagine con interpretazioni gigantesche. E la psicanalisi! E l’angoscia esistenziale con quattro secoli di anticipo! E il surrealismo con quattro secoli di anticipo!... C’è stato uno, perfino, che ha registrato uno per uno i mostri – eh, eh, li chiamano mostri – e li ha classificati come fossero tanti coleotteri, e per ciascuno ha trovato il tipo di nevrosi corrispondente. E poi il manicheismo immancabile. E i refoulements sessuali…i complessi aberranti…la componente sodomitica…l’esoterismo negromantico…Quanta fatica inutile![11]
Così si esprime infatti Van Teller, reincarnazione del pittore, protagonista del racconto, e insieme portavoce del pensiero critico di Buzzati. La grandezza di Bosch non sta nell’essere stato l’anticipatore di un’ipotetica corrente artistica del futuro, come tanta critica successiva ha voluto, quanto piuttosto nel suo estremo realismo: nulla di più reale dei suoi mostri, incarnazioni oscene dei fantasmi che abitano l’animo umano, che lui, in possesso di un occhio ben più penetrante del comune, ha potuto vedere davvero. Anche van Teller (e con lui Buzzati) possiede la stessa capacità. Egli può scorgere, in un mondo all’apparenza normale, questa popolazione di esseri ributtanti e laidi persino dietro le rassicuranti sembianze di madri e di bambini. E molti sono non a caso i racconti in cui lo scrittore bellunese indaga quelle forze oscure che governano l’agire umano e alle quali conferisce concretezza proprio tramite l’attribuzione di sembianze animalesche. Appariranno chiare a questo punto le singolari e interessanti analogie che intercorrono tra la penna di Buzzati e il pennello di Bosch.
Oltre alla scelta di una forma letterariamente connotata, ciò che appare più interessante nel testo è l’analisi di quei fenomeni micro-stilistici posti in atto nella traduzione dell’opera da un medium all’altro e volti al tentativo di restituirne la presenzialità. Buzzati si cimenta nella descrizione di un’opera attribuita a Bosch e andata perduta (secondo il racconto in un immaginario incendio del museo del Prado), della quale però si conserva una stampa in bianco e nero, e il cui soggetto è un Giudizio Universale. Siamo dunque di fronte ad una forma di descrizione ibrida, essendo allo stesso tempo reale, poiché basata sulla stampa esistente, e immaginaria, in quanto descrizione di un’opera che non esiste più se non nel racconto, e dove peraltro è ancora in divenire. Possiamo perciò dire che essa si situi al confine tra l’ekphrasis nozionale e quella mimetica (distinzione fatta nel 1988 da Hollander e ripresa da Cometa nella sua classificazione delle tipologie ecfrastiche, per evidenziare la differenza fra la descrizione di un’opera d’arte esistente soltanto nell’immaginario dello scrittore e quella di un dipinto reale).[12]
Nel racconto l’opera non è completa, il lettore/spettatore la vede (la legge) nel suo farsi per mano di un van Teller in trance; intanto nell’incantesimo di quella notte anche allo scrittore/attore Buzzati è concesso di vedere la stessa realtà vista da Bosch e da van Teller, sebbene per un momento.[13] Le case intorno allora si scoperchiano e al loro interno si vedono gli uomini alle prese con le azioni quotidiane e con i sentimenti più comuni («la gente che mangiava, dormiva, litigava, lavorava, faceva l’amore, odiava, invidiava, sperava, desiderava»), soltanto che tra di loro si aggira una popolazione orrenda di mostri, esseri ibridi intenti a consumarsi nei loro vizi in un’apoteosi di sadismo:
si agitavano brulicando innumerevoli cose viventi simili a celenterati, a ostriche, a ranocchi, a pesci ansiosi, a gechi iracondi, simili ai cosiddetti mostri di Hieronymus Bosch; e che non erano altro che creature umane, la vera essenza dell’umano che ci circonda. Latravano, vomitavano, addentavano, sbavavano, infilzavano, dilaniavano, succhiavano, sbranavano. Così come noi ci sbraniamo giorno e notte, a vicenda, magari senza saperlo.[14]
Il linguaggio si mette alla prova nel tentativo di rendere l’equivalente della visione,[15] una visione claustrofobica, satura per quell’agitarsi di moltitudini mostruose e disordinate, da cui il lettore si sente sopraffatto e angosciato. Una serie di otto verbi, sempre collegati per asindeto,[16] si sussegue senza pause sulla pagina cercando di rendere la contemporaneità di queste azioni infernali così come Buzzati le vede durante la sua rivelazione. In ogni angolo della visione una carneficina è in atto, ma ognuna è talmente terribile che lo sguardo non può scegliere su quale soffermarsi e perciò le coglie tutte insieme sintetizzando ciascuna di esse in un verbo. Inoltre lo scrittore mette in atto uno scambio tra i due mondi, tra l’animale e l’umano, in modo da evidenziarne la fondamentale identità: se al primo sono attribuiti sentimenti umani («pesci ansiosi», «gechi iracondi»), al secondo sono imputate azioni tipicamente animalesche («Latravano», «sbavavano», «sbranavano»). Una visione tutt’altro che dissimile da quella che troviamo in uno dei racconti di Buzzati contenuto nella raccolta Il Colombre (1966) e dal titolo Dolce Notte. È il racconto della carneficina notturna che si svolge tra gli insetti all’interno di un giardino, luogo all’apparenza ameno, e che diventa metafora delle crudeltà che gli uomini si infliggono l’un l’altro, una vera e propria galleria di torture e di supplizi:
La kermesse della morte era cominciata al calare delle tenebre. Adesso era al colmo della frenesia. E sarebbe continuata fino all’alba. Dovunque era massacro, carneficina, supplizio. Scalpelli che sfondavano crani, uncini che scavezzavano gambe, scoperchiavano squame e rimestavano nelle viscere, tenaglie che schiantavano scaglie, punteruoli che infilzavano, denti che trituravano, aghi che inoculavano veleni e anestetici, fili che imprigionavano, succhi erosivi che liquefacevano gli schiavi ancora vivi. Dai più minuscoli abitatori dei muschi, i rotiferi, i tardigradi, le amebe, le tecamebe, alle larve, ai ragni, ai carabidi, ai centopiedi, su, su, fino agli orbettini, agli scorpioni, ai rospi, alle talpe, ai gufi, lo sterminato esercito degli assassini di strada si scatenava al macello, trucidando, torturando, dilaniando, squartando, divorando.
Evidenti a questo punto appaiono le differenze che intercorrono tra i due autori presi in considerazione, infatti, sebbene entrambi siano accomunati dalla scelta di una cornice letteraria, differenti sono le strategie che adottano all’interno del testo: Buzzati, il cui universo immaginale abbiamo visto essere molto simile a quello di Bosch, si serve prevalentemente dello strumento della descrizione ecfrastica per rendere al lettore/spettatore il carattere di presenzialità dell’opera al fine di coinvolgerlo il più possibile nella realtà fittizia del racconto; Flaiano invece predilige un approccio meta-critico che procede per via di paragoni, facendoci compiere un originalissimo excursus all’interno della storia dell’arte secondo una prospettiva che è quella strabica del suo Paolo Uccello.
2. La metafora dell’arte
La seconda categoria ravvisabile in questa antologia virtuale di scritti sull’arte si fonda sullo scarto che alcuni dei testi presentano rispetto al linguaggio comune e puramente denotativo, difatti diversi autori risolvono il problema del rapporto tra parola e immagine attraverso un ispessimento linguistico fondato sull’uso di figure retoriche e sulla creazione di immagini analogiche che si pongano come equivalenti verbali dell’opera. In Invenzione della pittura d’oggi dedicato da Ungaretti a Vermeer e Grünewald, la bestemmia e il trionfo di Testori, i due scrittori trasferiscono molti degli elementi tematici e stilistici della propria poetica all’interno della pagina critica, così che i testi appaiono fortemente connotati dalla presenza dell’io autoriale, il quale ne diviene in qualche modo protagonista.
Per quanto riguarda il saggio testoriano sembra lecito parlare di una vera e propria cannibalizzazione dell’oggetto studiato, poiché questo viene interpretato esclusivamente alla luce del proprio paradigma etico, estetico e linguistico. Nel testo di Ungaretti è presente invece un più bilanciato alternarsi tra scrittura oggettiva e ascensioni poetiche, e proprio tramite l’analisi di queste ultime è possibile istituire un parallelo tra la pittura vermeeriana e la concezione poetica dell’autore, sul piano sia formale che contenutistico.
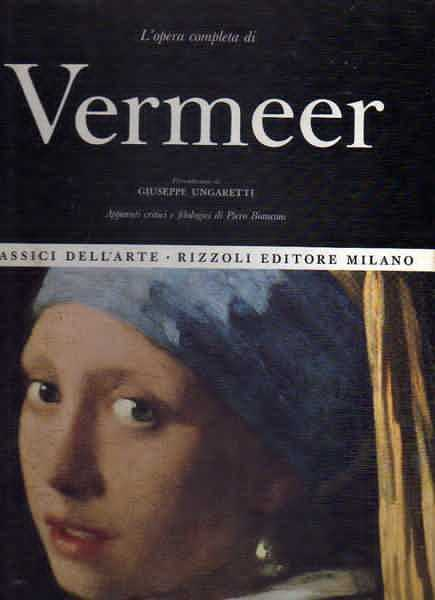
Uno degli espedienti di cui la critica si avvale per spiegare un’opera e un artista è quello di paragonare e confrontare tra di loro opere e artisti anche di epoche differenti. Ungaretti si serve ripetutamente di questo metodo comparativo al fine di chiarire la portata che la pittura del maestro di Delft ha avuto nella storia dell’arte, soprattutto in relazione all’uso della luce e del colore e alla capacità di rendere l’unità inseparabile di idea e natura che lo distingue dai cosiddetti ‘piccoli maestri’ olandesi. Tuttavia Ungaretti, da poeta, quando si tratta di descrivere le immagini, percorre anche la strada battuta da Baudelaire, ovvero quella di una scrittura che ne ricerchi l’equivalente. Egli si comporta dunque sì da critico, nel suo rifarsi all’autorevole fonte longhiana, nell’uso di un linguaggio tecnico proprio della critica artistica professionale, ma l’attenzione alle categorie formali è solo la base per il successivo slancio poetico.

Sono numerosi e più o meno ampi nel testo quei frammenti ecfrastici ove il linguaggio dispiega tutte le proprie possibilità retoriche al fine di rendere quel residuo ineffabile che alberga in ogni opera. Si consideri questo estratto, riferito a Donna che scrive una lettera:
Che cosa mai avrà da raccontare? La fronte spaziosa s’è volta un po’ di lato, china verso gli occhi riflessivi. Cerca di connettere. Le si affollano in mente, in troppi, i pensieri. Le dita si affusolano intanto mostrando la grazia delle mani carezzevoli che posano, un pochino grassottelle, una in abbandono sul foglio, l’altra trattenendo la penna impaziente di tornare a vergare care frasi.[17]
L’ekphrasis fissa quello che è la risultante di un movimento presupposto nel tentativo di rendere più che la temporalità dell’opera la sua astanza. Il senso di un movimento bloccato è ottenuto attraverso la costruzione paratattica e l’uso del presente e dei participi. Qui entra in gioco anche quella che Mengaldo chiama la presupposizione del critico ovvero l’immaginare ciò che nell’opera non si vede,[18] il suo perché, volontà qui palesata dall’interrogativa iniziale («Che cosa avrà mai da raccontare?»). Si tratta della rappresentazione di un’idea attraverso un’immagine quotidiana: è l’idea dell’assenza. Idea non rappresentabile di per sé, in quanto mancanza, in quanto vuoto, ma che si esprime nell’atto stesso dello scrivere una lettera (una lettera è sempre per un assente) e che si specifica per Ungaretti nell’espressione e nei gesti della fanciulla, nella sua metonimica «penna impaziente», come assenza dell’amato.
Altri frammenti ecfrastici presenti nel testo, in qualche caso semplici cenni, si concentrano soprattutto su un aspetto formale, l’uso del colore, mettendo da parte il soggetto vero e proprio del quadro, il suo contenuto. Il poeta descrive il Concerto come un’apparizione di colori, considerati nella loro «isolata assolutezza»,[19] in cui gli oggetti valgono solo in quanto portatori di questi colori: il giallo dell’abito, il rossastro cuoio, le lastre bianche e nere del pavimento. Uno stesso colore però può avere diverse rese, diversi caratteri: il giallo vermeeriano è sulfureo, cioè definito attraverso l’analogia con un minerale ma è anche, per sinestesia, «invadente» e prepotente. Mentre il rosso della Donna dal cappello rosso è «rosso scarlatto, rosso sangue, rosso fuoco».[20] Si tratta di espedienti volti a restituirci la presenzialità dell’opera, il suo essere fisicamente e in flagranza, che è il principale obiettivo di ogni scrittura ecfrastica. Perciò quanto maggiore sarà lo scarto rispetto al linguaggio puramente denotativo, raggiunto tramite l’uso di metafore, sinestesie e in generale con l’elaborazione di correspondances tra gli elementi del quadro e quelli della realtà, tanto più il poeta-critico sarà stato capace di rendere il carattere simultaneo del visivo.
Anche se ogni critica sembra portare con sé il fardello di un ontologico fallimento, ciò non significa che essa sia inutile, anzi è questo che palesa la necessità di mettere alla prova il linguaggio dispiegandone tutte le insite potenzialità. Questa idea della critica è a ben vedere equivalente all’idea ungarettiana della parola poetica: la parola può sì avvicinarsi al segreto che giace nel fondo dell’uomo, della vita, può esserne rivelazione istantanea e folgorante ma non potrà mai afferrare, mai possedere questo mistero. Il segreto della vita e il segreto della pittura sono parimenti ineffabili, in entrambe resterà sempre «quel nulla d’inesauribile segreto»[21] cui Ungaretti ha cercato sempre di avvicinarsi.
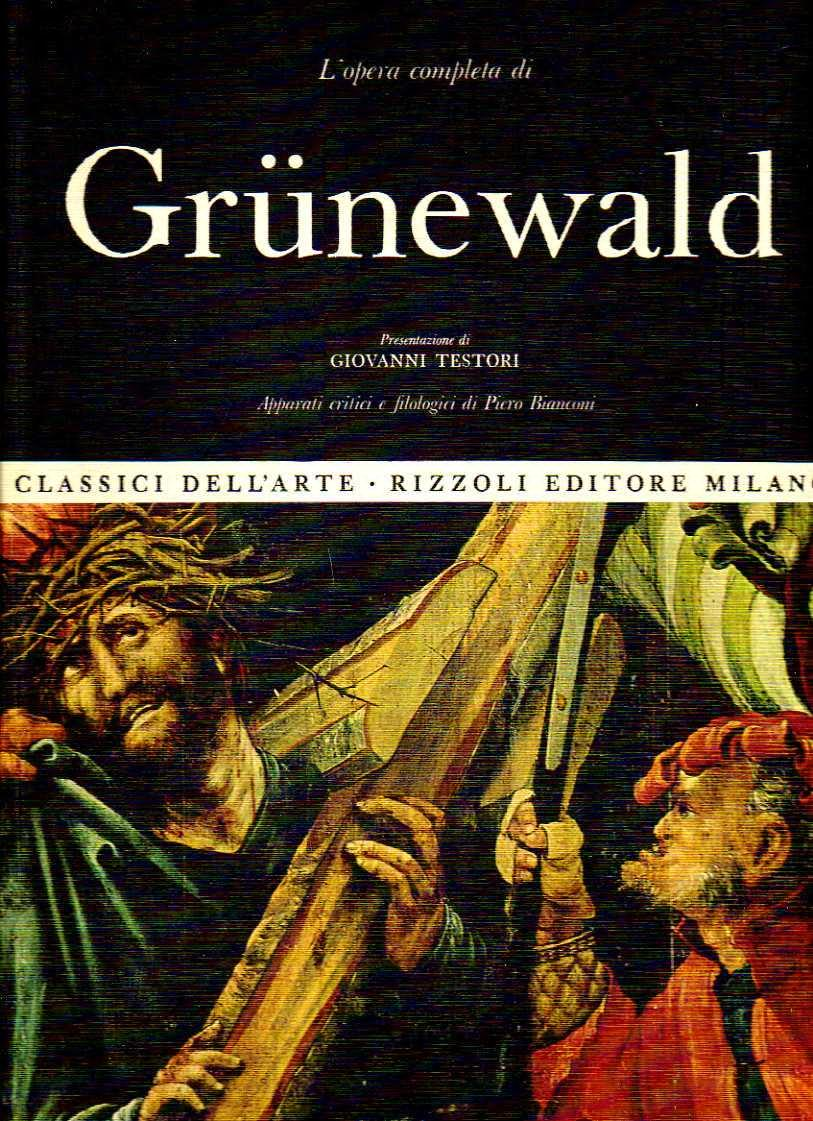
Il discorso critico testoriano è invece interamente costruito come una pagina letteraria, il linguaggio, infatti, non abbandona mai la sua carica metaforica e figurativa, non si abbassa mai alla semplice descrizione, al punto che è difficile isolare dei frammenti propriamente ecfrastici o delle parti stilisticamente più significative. Testori sceglie quegli elementi del quadro che servono al suo discorso e li trascende e trasfigura, innervandoli nella visione complessiva che lui si fa dell’opera e mai descrivendoli semplicemente per come si vedono. Se la critica è sempre scrittura ‘in funzione di’, di norma dell’opera che spiega, in Testori è anche in funzione del proprio io, poiché l’opera passa sempre al vaglio di valori extra-artistici assoluti e istanze soggettive cui lo scrittore la subordina.
Il saggio dichiara già nel titolo il suo carattere provocatorio, scandaloso, ossimorico. L’autore non è stato soltanto uno scrittore, un poeta, un drammaturgo e un pittore ma anche un critico d’arte di professione venuto fuori dalla scuola di Roberto Longhi, l’influenza del cui magistero è percepibile, tra le altre cose, nell’uso espressionistico di un linguaggio sempre volto a cogliere la concretezza dell’opera, sebbene si tratti di un espressionismo diversamente declinato e personalissimo. Esiste, ed è evidente, una forte continuità tra la sua opera propriamente creativa e la sua scrittura critica poiché dall’una all’altra trascorre un’identica tensione narrativa e morale, in entrambe si ritrova «un unico intreccio di tipologie, di insistenze tematiche, di grammatica stessa del colore, di espressione portata al limite»,[22] entrambe portano indelebile il marchio dell’io testoriano.
È tramite il linguaggio che si manifesta tutta la ricchezza di contenuti e allusioni propria della critica testoriana e che trova nell’altare di Isenheim un soggetto particolarmente confacente. Il linguaggio attinge ai serbatoi più diversi: fa uso di termini ricercati e rari, arcaismi («pei vasti»), neologismi composti («autospinazione», «imperqusibile»), termini del linguaggio scientifico (soprattutto tratti dal mondo vegetale), termini plebei e concreti, prestiti dal francese («crachat», «hantise», «d’amblèe») e citazioni bibliche in lingua latina, mentre sono assenti i tecnicismi propri del linguaggio pittorico e il riferimento a categorie o stili, quando c’è («goticismo», «barocco») si specifica sempre in un rapporto concreto con l’opera.
È un linguaggio che si dibatte tra il basso e l’alto, tra la bestemmia e il trionfo, cedendo più spesso al blasfemo che al sacro (ma ci si chiede se per Testori le due cose siano separabili), che si gioca sull’ossimoro e l’antitesi; è sempre ricco, sempre concitato e pieno, perché col suo barocco straripare di immagini che si accavallano, colle sue contraddizioni, con l’abbondanza di figure retoriche (chiasmi, figure di ripetizione, sinestesie, climax, elencazioni, sineddochi anche ricercate come «sulfureo e daviddico») cerca di esaurire tutti i significati possibili dell’opera (e dell’essere) per non lasciare spazio al vuoto e all’insoluto. Solo tramite il cortocircuito semantico generato da termini fra di loro opposti e inaccostabili, almeno per il senso comune, (si veda la serie «sacra»/«immonda», «supremo»/«infernale», «divino»/«maialesco», «celeste»/«stallatico» e più avanti «infimo»/«superno», «immondo»/«adamantino», «nefandezza»/«perfezione») Testori può restituirci il Cristo di Grünewald, questo Cristo dei vinti e degli afflitti, simile ad una bestia condotta al macello.
Sin da subito nel saggio appare evidente come il linguaggio ruoti intorno a due campi semantici fondamentali: quello della carnalità, quasi sempre malata e piagata (leggiamo di sangue, grumi, cellule, gangli, spurghi e corrosioni, sifilidi ecc.), costante in Testori, e quello della vegetalità, spesso anche questa legata a uno stato di malattia, che appare invece come marchio prevalente della pittura di Grünewald sin dalla Crocifissione di Basilea la quale
sembra fabbricarsi e lenticolarmente crescere e proliferare, ogni volta che la guardiamo, da e verso, una sorta di unicità muschiosa; un’unicità di lichene che si costruisce e insieme si rode (e corrode); un muschio un lichene che mostrano, nello stesso tempo, la durezza d’una pietra e la prensilità sudaticcia e repellente di una bava, d’uno sputo uscito da un violento attacco d’etisia clorofillica (e cromatica).[23]
L’estratto è esemplificativo del modo in cui lo scrittore piega e torce la lingua per restituire questa unicità che vede sulla tela, per cui alla natura vegetale del muschio si attribuiscono caratteri minerali, animali e umani, per cui l’etisia può diventare clorofillica (e cromatica) in un intersecarsi e sovrapporsi delle diverse forme dell’essere e così dei rispettivi campi semantici, con un riferimento alla pittura che è messo significativamente tra parentesi, come a dire che l’interesse per l’aspetto formale dell’opera è cosa di minore importanza rispetto al discorso complessivo. Si noti anche l’accostamento di termini bassi e plebei, quali «bava» e «sputo» insieme a tecnicismi come «etisia» e «clorofillica», esemplificativi del plurilinguismo espressionista testoriano. Mentre la sofferenza del Cristo di Isenheim è così naturale da essere paragonata a
la muta, inesplicabile e come strozzata angoscia di ogni tronco nell’acconsentire al suo crescere dentro il giro degli anni; al suo ergersi e al suo torcersi; al crollare dei suoi rami e delle sue braccia e quindi, di tutto il suo corpo roso e smangiato.[24]
La fusione di tutto l’essere in uno è completa e l’ambiguità metaforica del linguaggio ce la rende in una costante sovrapposizione di elementi umani e vegetali per cui l’albero si umanizza nella sua «strozzata angoscia», mentre l’«ergersi» ed il «torcersi» possono alludere sia al tronco sia al corpo di Cristo in croce, lo stesso vale per il sintagma «corpo roso e smangiato», ma già l’ambiguità si è dichiarata completamente nell’uso sia di «rami» che di «braccia», come termini intercambiabili. L’identità si manifesta anche col mondo animale:
il modo di ingigantirsi della propria morte dentro i mattatoi costruiti dall’uomo o pei vasti, liberi spazi della natura, che è proprio ed esclusivo delle bestie: braccate dal destino, l’urlo anzi il muggito, si spegne in loro come se l’”ubi eras, Jhesu bone, ubi eras? Quare non affuisti ut sanares vulnera mea?” (che a Colmar si trova scritto nel pannello della Tentazione) riguardasse non solo i santi che si trovano effigiati nel polittico, ma, ad esempio, i cani, i caprioli, i rettili draghi e qualche orrenda e perduta specie d’uccello, il cui stridio ribelle e convulso sembra schiantarsi e gelare nella memoranda morsa dei palmi e delle dita del Crocifisso.[25]
Qui è l’identificarsi dell’urlo umano col muggito della bestia al macello. É l’umanità, la santità, l’animalità unita nella comune, straziante e straziata, invocazione a Cristo. Il grido, dopo essere diventato muggito, si trasforma in uno stridio d’uccelli così violento da «schiantarsi e gelare» nella mano inchiodata e contratta del Redentore, come se questa, considerata singolarmente, concentrasse in sé per una sorta sineddoche visiva tutto il senso dell’immagine, o, stando dietro a Testori, tutto il senso dell’essere.

3. Il ritratto di un pittore tra biografia e storia
In una terza categoria è possibile comprendere quegli approcci critici che utilizzano quale diaframma interpretativo principale aspetti biografici o legati al contesto storico e culturale, spesso anche con intenti attualizzanti. A questa modello si riferiscono il saggio di Volponi dal titolo Il principio umano della pittura-scienza dedicato a Masaccio e quello di Elsa Morante, Il beato propagandista del Paradiso sull’opera di Beato Angelico. Se nel primo caso il rimando al dato biografico si fa più pressante nel tentativo di cogliere precisi riflessi di traumi infantili nella pittura masaccesca, nel secondo l’attenzione è tesa soprattutto a spiegare (ma potremmo dire a giustificare) l’arte del Beato tramite un certo humus culturale e religioso.
Da rilevare è poi il fatto che gli artisti trattati si pongano tra loro in una sorta di opposizione e allo stesso tempo in consonanza colle rispettive visioni della storia proprie dei due autori: rivoluzionario e progressista Masaccio, conservatore e propagandista Beato Angelico. Parallelamente secondo Volponi la storia procede seguendo uno svolgimento lineare e un percorso evolutivo mentre nella Morante l’idea è quella di uno scarto incolmabile tra una mitica età dell’oro ed un presente sempre più drammatico.

Proprio sullo scarto tra il mondo dell’Angelico e il nostro si fonda gran parte del suo testo, trascendendo talvolta l’attenzione verso il fatto propriamente artistico in favore una riflessione che coinvolga la storia, l’estetica, la morale e il rapporto dell’artista con l’insieme dei valori di un’epoca. Quell’armonia luminosa che risulta essere il carattere dominante delle sue opere appare alla Morante come l’inevitabile scaturigine di un uomo che non fu toccato da dubbi e lacerazioni o dalla visione del brutto (al contrario di Masaccio), ma che nella sua vita ebbe la fortuna di imbattersi solo nella bellezza e di non diffidare mai né della sua fede in Dio, né della sua fiducia nei Padri domenicani, i quali sempre possedevano le risposte alle sue domande. Il discorso inizia seguendo una traccia estremamente soggettiva, ovvero la dichiarazione da parte della scrittrice del proprio difficile approccio nei riguardi del pittore a causa di quell’aura di santità che lo circonda e in cui ella riconosce l’origine del proprio pregiudizio, per poi continuare con l’affermazione del suo credo artistico:
In realtà, nella pittura, i miei santi portavano altri nomi: per esempio Masaccio, Rembrandt, Van Gogh. Difatti, i santi dell’arte mi si fanno riconoscere perché portano nel corpo i comuni segni della croce materna, la stessa che inchioda noi tutti. Solo per avere scontato in sé stessi, fino alla consumazione, la strage comune, i loro corpi hanno potuto, a differenza dei nostri, rendersi al colore luminoso della salute; ma costui, invece, il Beato, si direbbe nato già col suo corpo luminoso.[26]
Il saggio dunque si presenta come il percorso privato della Morante verso una progressiva comprensione dell’opera del Beato rispetto all’iniziale sentimento di diffidenza, percorso in cui viene coinvolto anche il lettore con un allargamento di prospettiva che va dall’io al noi e che si riflette proprio nell’uso dei pronomi personali.[27]
La Morante nel fare ciò si preoccupa di rendere la temperie culturale e religiosa in cui maturarono la personalità e l’arte del pittore, inserendo nel testo non solo alcune citazioni dei Padri domenicani ma un vero e proprio sunto di cosmologia e teologia medievali, così da fornirci una valida cornice interpretativa per l’opera dell’Angelico. Egli è sì considerato come pittore di propaganda e come reazionario, ma la scrittrice ribalta l’accezione negativa di questi termini con una serie di considerazioni che testimoniano il mutarsi del suo punto di vista: è vero che di propaganda si tratta, ma sincera, ed è per questo che le sue opere sono riuscite così belle, altrimenti ne sarebbero venuti fuori soltanto «mostri di bruttezza»,[28] proprio come avviene oggi. L’arte del Beato dunque trova giustificazione nella purezza degli intenti ed paragonabile a ciò che Cristo fece attraverso le parabole, cioè predicare «agli “idioti” nella loro lingua»:[29] infatti sia le immagini sia quei racconti, al di là delle differenze connaturate al mezzo espressivo, servono a dare corpo e concretezza a verità di fede altrimenti inaccessibili per un popolo di indotti i cui «intelletti sono confinati nelle dimensioni dello spazio e del tempo».[30]
Ecco entrare qui in gioco uno degli strumenti interpretativi prediletti dalla scrittrice, tanto da divenire un vero e proprio leitmotiv testuale, è quello del paragone tra la pittura e altri media: la lingua in primis, intesa sia come lingua parlata sia nelle sue declinazioni più o meno letterarie, ma anche la musica, il teatro e persino la televisione.[31]

L’analogia con le forme letterarie, ad esempio, per via della maggiore familiarità dei lettori con queste, consente di distinguere in maniera più immediata i diversi momenti della pittura dell’Angelico e, come si fa per la letteratura, classificarli in base allo stile e ai destinatari. Allora si passerà dagli affreschi del convento di San Marco, che «sono le liriche del Beato Angelico»,[32] al poema storico che è la Cappella Niccolina, per tornare di nuovo, al termine della sua carriera, a predicare «agli “idioti” nella loro lingua» nell’Armadio degli Argenti, ove:
c’è una specie di stupore incantato, come se l’Angelico, stavolta, volesse farsi lui stesso “idiota”, secondo il destino dei suoi poveri fratelli terrestri: per raccontare a sé stesso, nella sua vecchiaia, la più bella storia della terra.[33]
Nel saggio di Volponi la traccia che guida il testo è quella biografica, pratica peraltro inusuale se riferita ad artisti vissuti così tanti secoli fa.
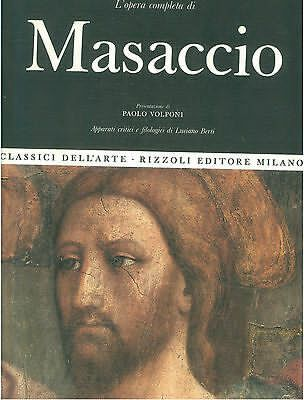
Dopo averci raccontato brevemente la vita del pittore toscano, orfano di padre e lui stesso precocemente scomparso a soli ventisette anni, l’autore passa a interpretarne l’arte ritrovando nei suoi lavori gli echi del rapporto con la madre, dell’assenza del padre, il suo animo di bambino un po’ triste costretto a crescere troppo in fretta «per le strade del paese, sugli scalini, davanti a una rappresentazione umana precoce e violenta, tra il silenzio delle porte gentilizie e le voci degli incontri».[34] Il contesto in cui visse, la sua tristezza adolescenziale, sembrano essere sempre presenti nell’ opera pittorica e sono probabilmente gli elementi che hanno guidato il suo pennello alla rivoluzionaria scoperta del vero, alla rappresentazione drammatica e reale di un’umanità in cui egli cerca «padre e fratelli» e cerca «se stesso tra quegli adulti sbandati e quei giovani intimiditi».[35]
Nei brani ecfrastici il linguaggio volponiano fa frequentemente ricorso a quelle che Cometa chiama «integrazioni sinestetiche».[36]
Ne L’elemosina di san Pietro la protagonista è la madre che tiene in braccio il figlio, «un infante aggrondato e dolente» già «presago»[37] del destino che lo aspetta, intorno a lei una popolazione di storpi e di mendicanti e poi san Pietro, gli apostoli, il corpo esanime di un padre morto troppo presto. Masaccio qui non inventa nulla, egli «si muove, si arrovella, guarda, sbatte, tasta le cose che ha intorno»,[38] affolla la sua opera di persone vere, quelle che popolano il suo mondo, dipinge paesaggi visti e attraversati, cose vissute:
Ognuna di quelle figure, e più ancora ognuno di questi volti, è quello di una giornata nella vita di Masaccio, di un buon incontro, di un affidamento del quale egli trae una forza paterna: facce di struttura greve, massiccia, dalla fronte aperta o bozzuta, dalle occhiaie allargate dalla tenerezza, gonfie ai lati per flettersi sulla tempia amorosa, interrompersi sullo sbalzo delle ciglia, sotto le quali s’apre un occhiaia profonda, dolce come una sponda, mobile, dove la palla marroncina dell’occhio e il bianco della sua vela pongono un pensiero triste, assorto, lo stesso che arriva a gonfiare la nuca, che compenetra gli zigomi e scende fino alle guance tirate, terrose, alle bocche suggellate da uno sgomento di follia paesana.[39]
I sentimenti dei suoi personaggi sono i principi plasmanti che danno vita alle figure dall’interno, che delineano i visi e danno forma ai corpi: allora i tratti del volto nascono dall’allargarsi, dal gonfiarsi, dal flettersi della tenerezza e da un pensiero triste che gonfia, compenetra e scende. Volponi delinea il volto tipo dell’uomo di Masaccio e noi lo seguiamo tratto per tratto, dall’alto verso il basso, dalle fronti fino alle bocche. L’aggettivazione abbondante («greve», «massiccia», «aperta», «bozzuta», «gonfie», «tirate», «terrose») è tesa a rendere la verità di questi volti senza idealizzazioni, volti di uomini che lavorano, volti di padri che hanno «la coscienza degli impegni della vita come della materialità della sua esistenza»,[40] volti portatori di una dolcezza e di una poesia che promanano proprio dai segni che il lavoro lascia su di essi. Ogni tratto è osservato singolarmente ed è portatore di un sentimento: così la tempia è «amorosa» perché occupata tutta dal sentimento paterno del sacrificio fatto per i propri figli, e l’occhiaia, testimonianza della fatica fisica per il lavoro compiuto, è definita «dolce come una sponda», dove l’occhio, simile ad una barca, trova approdo con la sua tristezza. Le guance sono «terrose» per rimandare ancora alla realtà quotidiana di questi uomini, alla dimensione fondamentale del lavoro che si riflette nell’aspetto, nei colori stessi di cui i personaggi sono fatti, dipinti. Si tratta della stessa umanità che Volponi, secoli dopo, vede e conosce nelle fabbriche, la stessa di cui parla nei suoi romanzi. Entrambi, pittore e scrittore, sono testimoni della loro realtà, scrivono e dipingono uomini reali, padri e lavoratori.

La rivoluzione che Masaccio porta nella pittura è vero che nasce e si sviluppa nel suo «cuore di orfano», ma ha il merito di trascendere il dato biografico per divenire espressione di un dolore che è universale, e di sicuro è proprio di quell’umanità che vive ai margini, che silente si porta sulle spalle il fardello della storia e la subisce, si tratta delle stesse masse ignote e sfruttate che attraversano i secoli dai tempi di Masaccio al 1968, anno in cui Volponi scrive questo saggio, fino ai nostri giorni.
4. Artifex additus artifici
Dal censimento e poi dall’analisi dei testi prescelti risultano come costanti la trasmigrazione di motivi letterari cari ad ogni autore all’interno della pagina critica, la ricerca di consonanze con l’artista, di analogie tematiche, stilistiche e formali rispetto alle proprie opere. Queste sono individuabili sia a livello macro-testuale, ad esempio nel genere letterario adottato, sia nei differenti meccanismi di visualizzazione agenti nelle ekphraseis e dunque nei procedimenti retorici, sintattici e grammaticali di traduzione dal medium pittorico a quello verbale.
Pier Vincenzo Mengaldo, il cui lavoro di ricognizione sui fenomeni micro-stilistici caratterizzanti la scrittura della critica d’arte non professionista è stato la base per le analisi qui condotte, ritiene fondamentale proprio l’apporto di scrittori e dilettanti nella critica d’arte e domandandosi a «che valga distinguere lo scrittore che eccezionalmente parli di opere figurative dal critico d’arte en titre, e anche dai rappresentanti della categoria che siano a loro volta fortemente scrittori»,[41] così risponde:
Ciò che forse costituisce la differenza cercata è piuttosto – o sarà un’impressione - che lo scrittore sembra trovare direttamente nella rappresentazione artistica un esemplare dell’umano e un’esperienza vitale […] occasione vitale, incontro da uomo a uomo.[42]
Riproponendo in tal modo quella che fu l’idea baudelariana di critica d’arte, un’idea espressa dal poeta-critico nella premessa al suo Salon del 1846, ove celebrava di fatto l’affermazione di una nuova dottrina interpretativa fondata su una concezione mistica del linguaggio e sui valori della soggettività, della sensibilità poetica e dell’empatia. Insomma proponeva la figura del poeta-critico, cui egli stesso corrispondeva, come alternativa al critico-filologo fautore di un’analisi normativa e pseudo-oggettiva delle opere d’arte:
Credo in coscienza che la migliore critica sia quella che riesce dilettosa e poetica; non una critica fredda e algebrica, che, col pretesto di tutto spiegare, non sente né odio né amore […] ma, - riflessa dall’occhio di un artista, - ci farà vedere un quadro attraverso lo specchio di uno spirito intelligente e sensibile, se è vero che un bel quadro è la natura riflessa. Così la migliore recensione critica potrà essere un sonetto o un’elegia. […] la critica deve essere parziale, appassionata, politica, vale a dire condotta da un punto di vista esclusivo, ma tale da aprire il più ampio degli orizzonti.[43]
Il critico è allora artifex additus artifici, a sua volta creatore di un’opera la quale poi avrà bisogno di un commento che genererà altri commenti e così all’infinito. Se quest’intreccio tra critica e poesia ha una tradizione più viva e forte nella cultura francese anche in Italia non sono mancati esempi di una prosa che si situasse a metà tra critica e letteratura: pensiamo a D’Annunzio, a Cecchi e soprattutto e sopra tutti a Longhi. È nel solco di questa tradizione allora che si inseriscono scelte editoriali come quella compiuta da Rizzoli, mentre la più recente metodologia proposta dagli studi visuali, e qui adottata, è funzionale ai fini di una mise en ordre dei differenti meccanismi di visualizzazione attuati nella trasposizione da un medium all’altro.
I sei testi analizzati in questo contributo si pongono perciò quali validi esempi di una scrittura critica che si mette alla prova, che dispiega tutte le proprie possibilità al fine di colmare quello scarto esistente tra i due linguaggi, verbale e visuale, i quali rimangono pur sempre irriducibili l’uno all’altro. Tale limite costitutivo, quello che massimo Carboni definisce tramite il suggestivo concetto di «Impossibile»,[44] deve infatti funzionare da stimolo per una scrittura che in qualche modo tenti di dire ciò che non può dire, alla ricerca di «possibili itinerari dagli occhi alla sintassi».[45]
1 R. Longhi, Officina Ferrarese, Roma, Le Edizioni d’Italia, 1934, p. 33
2 Oscar Wilde nota come «il metodo del dramma» sia stato spesso usato, non solo dalla filosofia, ma anche dalla critica (artistica e letteraria) poiché il critico attraverso di esso «può sia rivelare che celare sé stesso, dar forma a ogni fantasia e realtà a ogni umore. Per suo tramite egli può mostrare l’oggetto da ogni punto di vista e farcelo vedere a tutto tondo, come fa lo scultore, ottenendo in questo modo tutta la ricchezza e la realtà di affetto che derivano da quelle questioni a margine improvvisamente censurate dall’idea centrale nel suo sviluppo, e realmente illuminano l’idea con maggior completezza, o da quei felici ripensamenti che donano massima compiutezza allo schema centrale, che pur trasmettendo qualcosa del delicato incanto della casualità». (O. Wilde., Il critico come artista, L’anima dell’uomo sotto il socialismo, a cura di S. Perella, A. Ceni, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 119).
3 P. V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, Torino, Bollati Boringhieri, 2005, p. 34.
4 Questa pratica è segnalata da Mengaldo nella sua ricognizione sui fenomeni linguistici e retorici propri della critica d’arte al fine di esprimere meglio alcuni aspetti particolari dell’opera (cfr. ivi, pp. 49-51). Come si vedrà nell’ultimo paragrafo di questo contributo è anche una delle strategie retoriche predilette dalla Morante nel suo saggio su Beato Angelico, e particolarmente lo è il paragone con il medium linguistico e letterario.
5 Scrive Mengaldo: «l’anafora, o comunque la replicazione e il parallelismo […] in quanto ripetizioni simmetriche dell’identico o del simile, alludono anche al comporsi in unità dei vari particolari», ivi p. 37.
6 E. Flaiano, Il tempo dietro il tempo, introduzione a L’opera completa di Paolo Uccello, apparati critici e filologici di L. Tongiorgi Tomasi, Milano, Rizzoli, 1971, p. 6.
7 Tale pratica rientra in quelli che Segre definisce atti di «pertinentizzazione», cioè tentativi di rendere un quidsimile verbale dell’opera. I raffronti «sono dei modi, per via di accostamento, di abbozzare un inizio di linguaggio, additando due momenti di un suo eventuale sviluppo, oppure di trovare, diciamo così, due aggettivi uguali, presenti in due pittori diversi. Confrontando i due pittori io faccio capire qual è l’aggettivo di cui sto parlando» (C. Segre, La pelle di san Bartolomeo, Discorso e tempo dell’arte, Torino, Einaudi, 2003, p. 69). Cometa in una più ampia trattazione definisce questa pratica col nome di integrazione ermeneutica, distinguendola da altri tipi di integrazione. Essa è uno strumento fondamentale della critica divenuto quasi imprescindibile da Winckelmann in poi, di cui anche Longhi fece largo uso (M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Cortina, 2012, pp. 121-126) e, come si vedrà nel paragrafo successivo, anche Ungaretti nel suo saggio su Vermeer.
8 Ivi, p. 7.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 D. Buzzati, Il maestro del giudizio universale, introduzione a L’opera completa di Hieronymus Bosch, apparati critici e filologici di M. Cinotti, Milano, Rizzoli, 1966, p. 6.
12 La distinzione appare per la prima volta in un articolo di J. Hollander, ‘The poetics of ékphrasis’, Word & Image, 4, 1988, pp. 209-219; cfr. M. Cometa, La scrittura delle immagini, pp. 44-62.
13 Siamo davanti ad una forma particolare di integrazione per trasposizione in quanto il setting della narrazione si ispira a ciò che si vede nel quadro, anzi la realtà del racconto e quella dell’opera tendono a quasi ad identificarsi. (Cfr. M. Cometa, La scrittura delle immagini, pp. 135-141).
14 D. Buzzati, Il maestro del Giudizio universale, p. 8.
15 A proposito del tentativo di rendere l’equivalente verbale della visione il pensiero corre subito a Baudelaire che dedica tutto un paragrafo a questo argomento nel suo Salon del 1846 istituendo una vera e propria teoria delle correspondances (C. Baudelaire, Scritti sull’arte, prefazione di E. Raimondi, Torino, Einaudi, 1992, pp. 60-64) e naturalmente all’ «iperscrittura» o «scrittura iconica» di Roberto Longhi (M. Carboni, L’occhio e la pagina. Tra immagine e parola, Milano, Jaca Book, 2002, p. 86). Per un’analisi del suo linguaggio critico si rimanda all’Antologia critica su Longhi scrittore, in R. Longhi, Da Cimabue a Morandi; saggi di storia della pittura italiana, scelti e ordinati da Gianfranco Contini, Milano, Mondadori, 1973.
16 Secondo Mengaldo il legame asindetico è «sintomo di una espressività quasi affannosa indotta dalla serie di chocs emotivi (talora anche in negativo) che provoca lo scorrere l’opera lungo le sue parti, come per continue agnizioni» (P. V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, p. 37).
17 G. Ungaretti, Invenzione della pittura d’oggi, introduzione a L’opera completa di Vermeer, apparati critici e filologici di P. Bianconi, Milano, Rizzoli, 1967, p. 7.
18 «Il critico si rende libero di indicare ciò che, non presente o presente per connotazione nell’opera, si può chiamare in gergo linguistico una sua presupposizione» così Mengaldo in Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, p. 62. Nella tassonomia proposta da Cometa questo procedimento è riconducibile a quella modalità di integrazione che egli definisce traspositiva: «quella che costruisce la narrazione […] interrogandosi sulla storia e l’essenza dell’immagine che la genera» (M. Cometa, La scrittura delle immagini, p. 140).
19 Ivi, p. 8.
20 Ibidem.
21 G. Ungaretti, Il Porto sepolto, in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 1970, p. 23.
22 S. Crespi, Postfazione a G. Testori, La cenere e il volto. Scritti sulla pittura del Novecento, Firenze, Le Lettere, 2001, p. 290.
23 G. Testori, Grünewald, La bestemmia e il trionfo, introduzione a L’opera completa Grünewald, apparati critici e filologici di P. Bianconi, Milano, Rizzoli, 1971, p. 6.
24 Ivi, p. 9.
25 Ibidem.
26 E. Morante, Il beato propagandista del Paradiso, introduzione a L’opera completa di Beato Angelico, apparati critici e filologici di Umberto Baldini, Milano, Rizzoli, 1970, p. 5.
27 Si tratta del cosiddetto «noi sociativo» che Mengaldo classifica come caratteristica dei critici-scrittori o dei critici «egocentrici» (Cfr. Mengaldo, Tra due linguaggi, pp. 34-35). Anche Cometa fa cenno all’uso di «formule “sociative” in cui l’io è sostituito da un noi che mette insieme proprio due spettatori (reali/fittizi) dell’immagine: l’autore e il lettore» (M. Cometa, La scrittura delle immagini, p. 64).
28 Ivi, p. 7.
29 Ivi, p. 9.
30 Ibidem.
31 Cfr. P.V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, pp. 48-52.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 P. Volponi, Il principio umano della pittura-scienza, presentazione a L’opera completa di Masaccio, apparati critici e filologici di L. Berti, Milano, Rizzoli, 1968, p. 5.
35 Ivi, p. 6.
36 «La sinestesia si rivela dunque la via maestra per richiamare nella mente del lettore esperienze condivise che rafforzino il patto ecfrastico. Tali sinestesie, oltre a stimolare l’immaginazione del fruitore, rappresentano una costante e programmatica trasgressione dei confini tra realtà e finzione, tra pittura e mondo reale» (M. Cometa, La scrittura delle immagini, p. 118).
37 P. Volponi, Il principio umano della pittura-scienza, p. 5.
38 Ivi, p. 7.
39 Ivi, p. 6.
40 Ivi, p. 7.
41 P. V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, p. 67.
42 Ibidem.
43 C. Baudelaire, Scritti sull’arte, p. 57.
44 L’«Impossibile» è definito da Carboni come «l’enigma e l’irrappresentabile della critica e della storia dell’arte» (M. Carboni, L’occhio e la pagina. Tra immagine e parola, Milano, Jaka Book, 2002, p. 15).
45 Ivi, p. 28.