1. Premessa
Come sostengono le geografe Mona Domosh e Joni Seager in Putting Women in Place, lo spazio e la sua organizzazione non fanno semplicemente da sfondo neutrale ai drammi umani, ma ne influenzano la condizione e le relazioni (2001, pp. xxi-xxiii). La creazione, l’uso e la disciplina degli ambienti edificati (built environment), spazi intesi sia come entità fisiche in generale (space), sia come luoghi vissuti e associati alla sfera personale (place), sono determinati in parte da presupposti riguardanti ruoli e relazioni sociali. Secondo questo approccio, la ‘genderizzazione’ (gendering) degli spazi quotidiani (abitativi, professionali, ricreativi e così via), ossia il ruolo che lo spazio gioca nella formazione dei ruoli di genere, si presenta come elemento critico per identificare, e mettere in discussione, relazioni di potere fra i sessi di natura gerarchica, binaria e discriminatoria.
La categoria dello spazio diventa, in questo contesto, utile strumento di indagine storiografica per esaminare come l’industria cinematografica italiana rielabori e si rispecchi nei processi di modernizzazione sociale e di urbanizzazione dei costumi che attraversano il Paese tra gli anni Trenta e Quaranta. Un’ottica ‘spaziale’ permette anche di riflettere sulle dinamiche di genere che si sviluppano all’interno della filiera filmica nella sua complessa organizzazione artistica, tecnica ed economico-amministrativa.
2. Il panorama produttivo
L’articolato panorama produttivo del cinema italiano tra l’avvento del sonoro e la fine della seconda guerra mondiale è stato oggetto di ampio dibattito storiografico che qui non si ha la pretesa di rivisitare nella sua complessità. Durante la prima metà degli anni Trenta la filiera produttiva, raggiunta una fase di assestamento in seguito alla graduale conversione al sonoro delle strutture, degli impianti e della formazione tecnico-artistica, si avvia, con la fine del decennio, verso un’ulteriore espansione infrastrutturale dettata in parte, com’è noto, dall’istituzione del monopolio per l’acquisto, l’importazione e la distribuzione dei film stranieri e il conseguente ritiro delle majors americane dal mercato italiano. Esacerbato dall’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania nazista e dalle restrizioni autarchiche, il grande sforzo costruttivo e produttivo incoraggiato dal governo (si calcola siano circa 96 i lungometraggi italiani distribuiti nel 1942, contro i 33 del 1937) si arresta bruscamente all’indomani dell’esautorazione di Mussolini nel luglio del 1943.
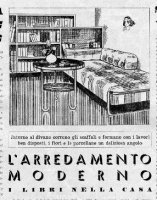
![Fig.2 | Il soggiorno di Violette nei capelli (1942). [Screenshot da terzi del film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xmereu_keating_g_fig2.jpg.pagespeed.ic.wUbWfkyO0a.jpg)
![Fig.3 | Il salotto aristocratico in La principessa del sogno (1942) [Screenshot da terzi del film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xmereu_keating_g_fig3.jpg.pagespeed.ic.2WGnqvuYcu.jpg)
![Fig.4 | Scompiglio nel salotto di Il birichino di papà (1943) [Screenshot da terzi del film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xmereu_keating_g_fig4.jpg.pagespeed.ic.lQd8YWkP6k.jpg)
![Fig.5| Anna Magnani al pianoforte nel salotto de La vita è bella (1943) [Screenshot da terzi del film]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xmereu_keating_g_fig5.jpg.pagespeed.ic.AxUNS2L7eT.jpg)