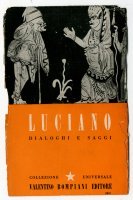L’operazione editoriale che ha portato nel 1944 alla stampa dei due volumi degli scritti di Luciano di Samosata (Luciano 1944, I-II) all’interno della collana Corona dell’editore Bompiani condensa in sé numerosi elementi di valore storico e culturale. Tra questi spicca l’aspetto artistico, legato alla presenza delle preziose illustrazioni di Alberto Savinio, ma una attenzione più specificatamente rivolta alla loro forma editoriale suggerisce anche una interpretazione ulteriore, volta a riconoscere nei due libri un distillato della poetica del Vittorini di quegli anni.
Elio Vittorini, infatti, nel 1942 fonda e dirige Corona, una collana universale che accoglie nel proprio catalogo titoli di autori considerati classici, provenienti dalle più varie epoche storiche e geografiche, operando però, dal punto di vista letterario, una selezione molto particolare, corrispondente ai propri interessi e gusti di lettore e autore, con l’intento dichiarato di rivolgersi a un’ampia comunità di lettori non necessariamente colti, che considerano i libri un bene di prima necessità. Il contesto storico del secondo conflitto mondiale è lo sfondo su cui si colloca il progetto editoriale e ogni testo deve avere un valore innanzitutto nel presente.
Poste queste premesse, Vittorini coordina le fasi di lavorazione dei volumi dedicati ai testi di Luciano di Samosata, che nello specifico erano nati da un’idea di Valentino Bompiani subito accolta da Savinio (cfr. Cianfrocca 2018): in questo margine apparentemente ristretto di lavoro, Vittorini riesce però a realizzare un oggetto pienamente corrispondente alla sua visione letteraria e culturale di quegli anni, facendo ruotare i suoi elementi costitutivi, in particolare iconografici e paratestuali, entro la propria orbita carismatica.