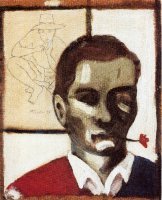Se ci fosse bisogno di interrogarsi ancora sulla rilevanza internazionale acquisita nel tempo dall’opera di Luigi Pirandello, basterebbero i volumi editi per i tipi di Peter Lang a confermarla e per riconoscere nello scrittore e drammaturgo siciliano uno degli interpreti più acuti della modernità. Dopo aver affrontato il nodo narrazione, memoria e identità in un precedente volume allestito da Alessandra Sorrentino e Michael Rössner, l’indagine su ‘Pirandello in un mondo globalizzato’ procede ad esplorare il macrotesto dell’autore siciliano dalla specola della visualità con la raccolta di saggi curata da Bart Van den Bossche e da Bart Dreesen, intitolata Iconografie pirandelliane. Immagini e cultura visiva nell’opera di Luigi Pirandello (2020). I variegati contributi sono raggruppati in quattro sezioni, che scandiscono la ricerca con fitti e numerosi rilanci e rimandi interni. Dopo l’Introduzione dei curatori, la prima parte è dedicata alle coordinate generali del discorso. Le dinamiche di rivelazione e svelamento presenti non solo nella scrittura teatrale, ma anche nella narrativa, vengono individuate da Dominique Budor e Margherita Pastore e ricondotte a due eventi biografici risalenti all’infanzia – la vista dell’amplesso tra un uomo e una donna nella torre-morgue e la scoperta dell’adulterio del padre con la giovane nipote nel convento di Palermo – già raccontati nella biografia autorizzata di Nardelli, ma che qui vengono accortamente inseguiti e ricostruiti attraverso i processi di mascheramento, rimozione, palesamento. La persistente iconicità che permea l’opera pirandelliana viene rintracciata, in questo segmento del volume, in alcuni emblemi ricorrenti: l’immagine copernicana e pascaliana dell’uomo sospeso tra gli infiniti del tempo e dello spazio (Lia Fava Guzzetta), la costante metaforizzazione della teoresi, particolarmente evidente nel Fu Mattia Pascal e nell’Umorismo (Sara Lorenzetti).
Goliarda Sapienza nasce a Catania il 10 maggio del 1924 e muore a Gaeta il 30 agosto 1996. Figlia di Maria Giudice, figura storica della sinistra italiana e prima dirigente donna della Camera del lavoro di Torino, e Peppino Sapienza, militante antifascista iscritto al partito socialista, trascorre l’infanzia a Catania in un contesto familiare eccentrico, libero e anticonformista. Il suo talento multiforme e versatile trova espressione prima nel teatro e nel cinema e poi nella letteratura.
La sua «(ri)nascita» come scrittrice avviene solo in età adulta, quando decide di rinunciare alla recitazione, che da bambina aveva vissuto come la vocazione prediletta attraverso cui esprimere il suo estro e la sua creatività. Lei stessa indica le coordinate all’interno delle quali si sviluppa la propria inclinazione attoriale:
Amante del teatro, il padre Peppino la sostiene con grande fiducia, iscrivendola, a sua insaputa, all’esame di ammissione per entrare all’Accademia di Arte Drammatica di Roma diretta da Silvio D’Amico. Nell’autunno del 1941 Goliarda e la madre intraprendono il viaggio verso Roma. Con la gioia nel cuore e la paura di non esserne all’altezza, la scrittrice viene ammessa all’Accademia grazie all’enfasi della sua recitazione:
L’euforia di poter accedere alla scuola d’arte drammatica più illustre d’Italia si sostituisce presto alla sofferenza di essere stata ammessa con riserva: il talento c’è, ma prima della fine dell’anno, allo scadere di tre mesi, deve dimostrare di aver saputo correggere la sua disastrosa pronuncia siciliana. Quel che sembrava in apparenza impraticabile diviene possibile grazie alla sua incrollabile volontà: