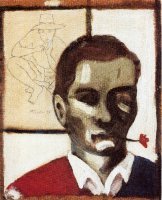Avevo veramente una doppia vita. Ma l’ho avuta sempre. L’ho anche adesso, probabilmente. Avevo questa capacità di amministrare una vita e un’altra vita… Comunque nel rapporto con Pier Paolo questo si poneva: io non rinunciavo ad essere una mascalzona. Avevo bisogno di molte cose, mi piaceva moltissimo la mondanità. Che Pier Paolo detestava.
Laura Betti
Il profilo artistico e biografico di Laura Betti ruota intorno al rapporto con Pasolini: l’incontro con ‘il veneto’ rappresenta una svolta per la funambolica avventura dell’attrice («Fino ad allora, la mia vita non era stata altro che un’abitudine. Lui è diventato la mia vita»),[1] che da quel momento si voterà a una dedizione fatale, con tratti di «folle ambiguità».[2] La loro ‘relazione’ scardina i presupposti dell’industria culturale italiana, perché non resta confinata al modello-Pigmalione: Betti, pur incarnando fino in fondo il ruolo di «pupattola bionda»,[3] sarà l’artefice prima dell’edificazione della mitografia pasoliniana e si trasformerà pertanto da musa a vestale della memoria e dell’opera dello scrittore-regista.[4] Tale sbilanciamento, frutto di una determinazione assoluta, rende le traiettorie della ‘coppia’ inconsuete per il sistema divistico italiano: nessuna amicizia intellettuale riuscirà a eguagliare il primato di una reciprocità così profonda, nessuna partnership sarà tanto longeva e feconda.
La dimensione ‘leggendaria’ di questo legame si deve non solo alle aperture mondane dei due, alla loro disinvoltura nel presenziare a festival, cerimonie, kermesse teatrali o cinematografiche, ma anche alla spiccata propensione di Betti per l’affabulazione romanzesca; non c’è intervista, lettera o manifesto in cui lei non chiami in ballo il poeta, un po’ per la curiosità morbosa di giornalisti e paparazzi, un po’ per la necessità di restare attaccata all’ombra dell’amico scomparso («Il passaggio del tempo, soprattutto da quando non c’è Pier Paolo, per me è disperso al vento. Certo, non sono la sua vestale, ma, per me, è ancora l’unica cosa che vale nella vita»).[5] La storia di questo côté affettivo è dunque puntellata di aneddoti, dichiarazioni, invenzioni più o meno audaci, che testimoniano l’intimità e l’ostinazione della ‘giaguara’, il suo essere irrimediabilmente votata a una fedeltà senza misura, e in ultimo la sostanza mitica di un rapporto capace di superare il limite dell’esistenza.