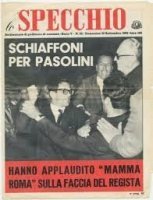1. Scritture
In un passo del 1960 dal titolo Donne di Roma, Pier Paolo Pasolini descrive così la figura di Anna Magnani:
A stagliarsi per primo è il volto dell’attrice, con i contrasti vividi di luce e ombra: gli occhi bistrati di nero si distendono sulla pelle candida come un fazzoletto. Magnani appare bendata, come fosse cieca, una veggente o una profeta: una sorta di idolo. Pasolini vede nell’attrice sì un corpo governato dalla fisiologia (le risate, i piccoli rutti, l’andare al bagno) ma soprattutto una figura ieratica («sta seduta sempre col busto eretto», «come su un palcoscenico»). Magnani è «la pura vita», segno e corpo di una romanità eterna e a-storica (le «generazioni di donne romane che sono state al mondo prima di lei»).
A ridosso delle riprese del film, la figura di Anna Magnani torna ad affacciarsi nella scrittura pasoliniana:
Il brano di Donne di Roma gioca sulla materialità concreta e perfino scatologica per poi aprirsi alla dimensione simbolica (Roma sub specie Magnani). La parola poetica adotta lo stesso passo e lavora per astrazione: riassume per sineddoche il corpo dell’attrice nelle «ciocche» e nelle «occhiaie», e la musicalità quasi scricchiolante dei termini sembra trasformarne il volto, dissolvendolo in un elemento ritmico, battente e ripetuto. Dal canto suo, la dimensione sonora è ossimorica: domina nell’«urlo» che «risuona nelle disperate panoramiche» per acquietarsi subito dopo nelle «occhiaie mute» e culminare nel silenzio sonoro (un canto tanto forte da rendere sordi, dunque impossibile da udire) che chiude l’ekphrasis della celebre sequenza di Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945). Ancora un passaggio dal concreto all’astratto: la voce di Magnani/Pina perde matericità, quasi si stacca dal corpo per assumere una consistenza eterea e distendersi negli spazi senza storia della tragedia, divenendo «canto degli aedi», suono eterno e tuttavia, per paradosso, silenzioso proprio perché assordante.