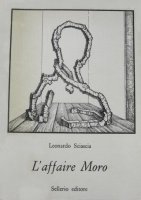6.1. Salinas e Clerici: Amor, mundo en peligro
di Alessandro Giammei
Dopo aver realizzato Frammenti di una sconfitta e Diario Bolognese di Sereni e Gentilini a metà del ’57, Riva si dedicò a lungo a questo secondo volume dei “Poeti Illustrati”. Uscito all’inizio dell’anno successivo e, al pari del precedente, «pubblicato a Milano da Vanni Scheiwiller» (come recita il colophon), Amor, mundo en peligro è il primo libro illustrato delle Editiones Dominicae a raggiungere, forse anche grazie alla natura non poi così privata della sua diffusione, un immediato prestigio internazionale. Compare infatti nel catalogo della mostra The artist and the book 1860-1960, tenutasi a Boston a fine decennio, e lo stampatore lo raccoglierà – insieme ad altri quattro tra i primissimi della serie – nella minima tiratura (sette esemplari) di Cinque poeti illustrati: una vera rarità bibliografica che celebra, nel ’64, la maturità del progetto editoriale.
Affidandosi a Fabrizio Clerici, allora già affermato pittore neo-barocco e post-metafisico, Riva sa di poter contare su un professionista dell’acquaforte e su un lettore raffinato. Appena compiuta la vetrata dedicata a Santa Caterina nella basilica senese di San Domenico e con alle spalle diversi libri illustrati realizzati con Mondadori, l’artista era, alla fine degli anni Cinquanta, in procinto di dedicarsi ad alcuni tra i maggiori cicli della sua carriera: quello del Principe per Laterza, quello, più tardo, per Il Milione introdotto da Moravia (e poi, in una riedizione, da Manganelli), e soprattutto quello monumentale per l’Orlando Furioso uscito, con un saggio di Bacchelli, in una preziosa edizione Electa ancora oggi oggetto di studio. Beniamino della società letteraria, profondamente ispirato dai classici e dagli scrittori suoi sodali, Clerici è scelto dallo stampatore veronese per la sua modernità sorniona, capace di rielaborare il Novecento maggiore senza angosce avanguardistiche. In Il mio dimestico torchio è infatti annoverato tra quegli illustratori che, nel panorama delle sue collaborazioni, «depongono tutt’altro che a favore di un tradizionalismo insensato e chiuso», nel segno di uno sperimentalismo tipografico estremamente consapevole della tradizione ma aperto a nuove soluzioni e insolite figurazioni, specie quando si tratta di sposare un’immagine a versi contemporanei.