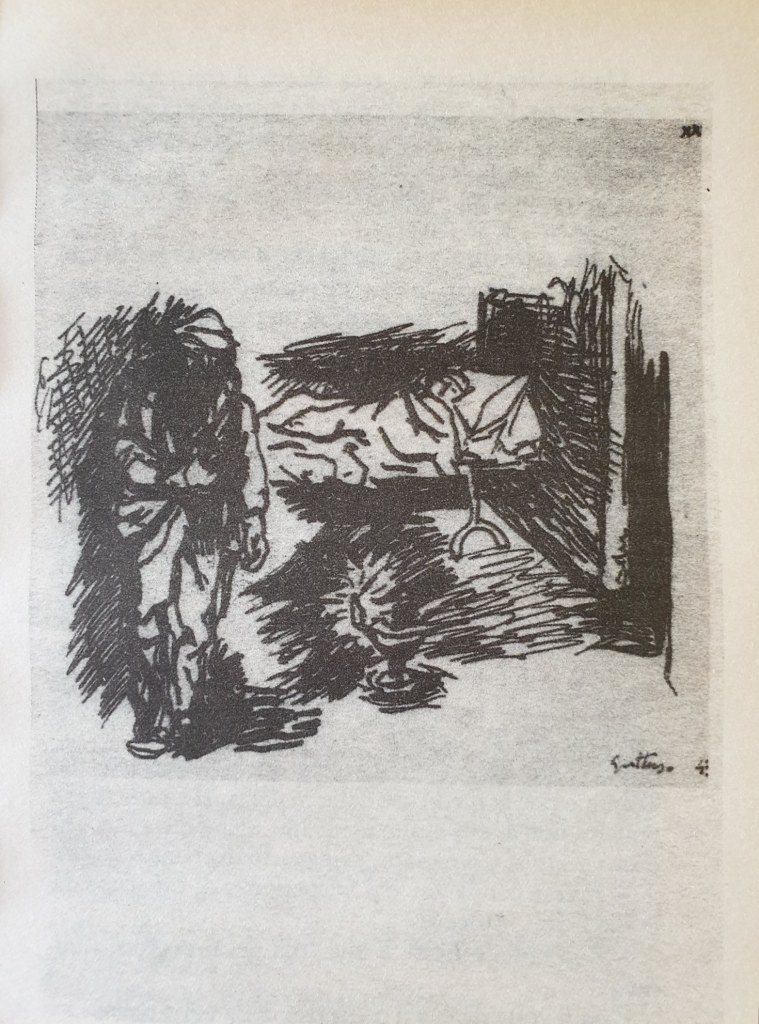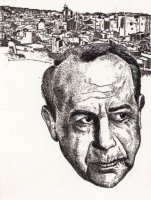La pratica di trasporre in immagini la Commedia prende avvio molto presto e corre parallela a quella del secolare commento, frutto della medesima esigenza – percepita sin da subito – di corredare il testo dantesco di note integrative e appunti interpretativi utili a un lettore sprovvisto di strumenti atti a comprendere a pieno la complessità del poema ed evidentemente disorientato dalla portata straordinariamente innovativa dell’opera di Dante. Se, ai suoi esordi, l’illustrazione della Commedia svolge una precisa funzione di orientamento alla lettura e i primi prodotti manoscritti sono in grado di restituirci il peculiare approccio critico dei più antichi lettori dell’opera (essenzialmente impegnati a inquadrare il poema dantesco entro il sistema dei generi letterari), la storia della trasposizione visiva della Commedia si evolve nei secoli in plurime direzioni, riflettendo di volta in volta gusti, ideali, nuove urgenze di artisti e lettori.
La ricostruzione di una parabola evolutiva tanto affascinante e complessa è oggi offerta dal Dante per immagini di Lucia Battaglia Ricci, che indaga – non senza una rigorosa classificazione terminologica, atta a distinguere le diverse tipologie della traduzione in immagine dell’opera letteraria, e alcune importanti riflessioni di metodo – la lunga storia della ricezione del poema in ambito figurativo. Il lettore può così seguire, guidato dal nutrito apparato di tavole che arricchisce il volume, l’evolversi nel tempo dell’interesse di artisti e committenti per il poema di Dante e ripercorrere le tappe di un lungo percorso di trasposizione in figura del viaggio oltremondano narrato nella Commedia, dagli anni Trenta circa del Trecento, a sole poche lune dalla scomparsa del poeta, sino ai nostri giorni, con prevedibili proiezioni oltre i confini del volume stesso, lungo le linee di una storia di lettura e visualizzazione del poema molto probabilmente destinata a non interrompersi mai.