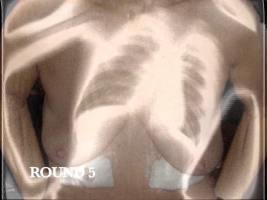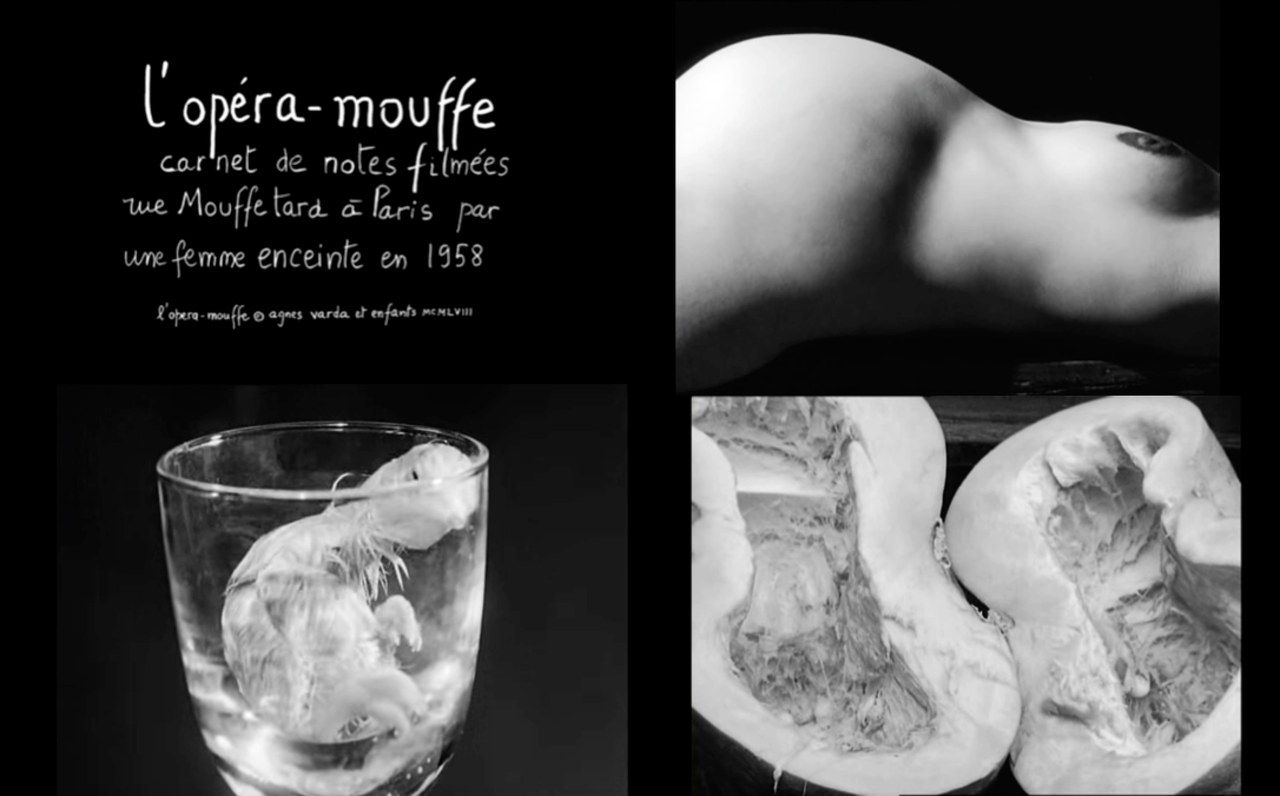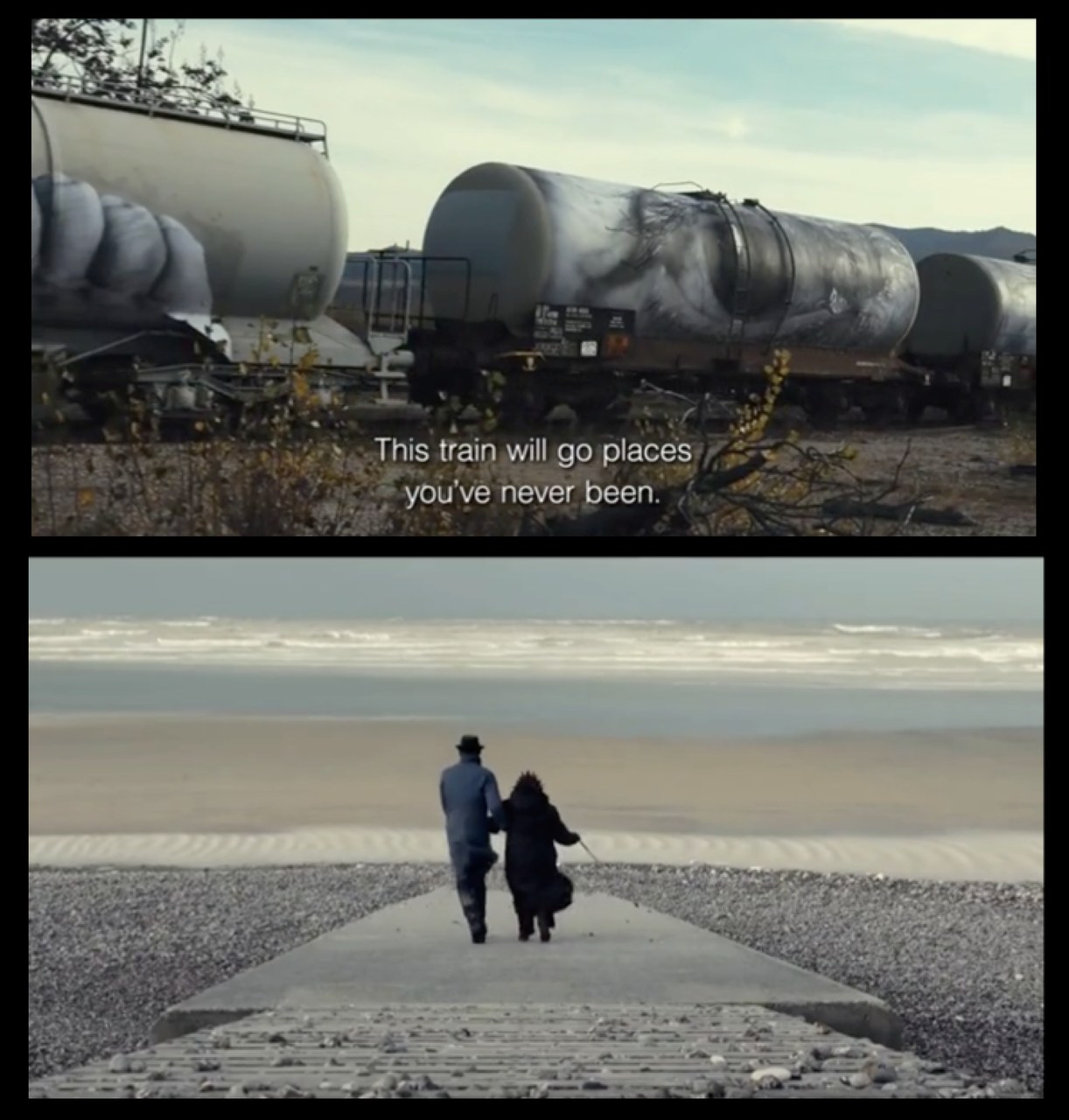Nel 2006, in seguito alla diagnosi di un carcinoma ovarico, Barbara Hammer (Feminist filmmaker and pioneer of queer cinema, come dichiara il sito della sua Fondazione) inizia un oneroso percorso terapeutico, che affronta tenendo con sé la telecamera e andando così a realizzare il film A Horse is not a Metaphor (2008). L’opera, tra letto d’ospedale e spazi naturali dove vive i momenti fra un ricovero e l’altro, si offre nella sua potenza visiva come viaggio esistenziale e testimonianza di un’idea di cinema come strumento di riconoscimento di sé nel mondo. Esistenza che sa sì di lotta (i brevi capitoli che ritmano il film con le sedute di chemioterapia sono significativamente intitolati round), ma soprattutto vocazione alla sperimentazione, restituita da tutta la sua storia artistica, in cui è evidente la volontà di mettere al centro del quadro sé stessa.
Cinema come strumento di pratica del mettersi al mondo, di nascita e rinascita, linguaggio per definirsi e definire, modo con cui riconoscersi e riconoscere visibilità. Visibilità che comincia e finisce con il corpo, centralità sfrontata che si impone già nel 1974 con Dyketactics (con cui mette a fuoco la strettissima connessione tra sessualità e pratica artistica omosessuale, procedimento che la porta a parlare di un processo di riconoscimento cinestetico). La manifestazione corporale colpisce nel lavoro della regista, femminista e lesbica, la cui ricerca visuale è costante affermazione di sé (fisica, intellettuale, politica, erotica), cui giunge indagando nella dicotomia: visibilità/invisibilità, presenza/assenza, solidità/trasparenza, interno/esterno, consistenza/inconsistenza, in sintesi essere/non essere. La ricerca dentro al contrasto diventa esplorazione artistica (sovversiva e ironica) con cui si rende visibile il percorso di vita: il proprio e anche – vocazione politica militante di chi ha preso parte ai movimenti tra anni Sessanta e Settanta – quello delle lesbiche. È un percorso che ha quindi forse anche il senso del risarcimento: come altrimenti leggere il trittico ‘archeologico’ composto da Nitrate kisses (1991), che assembla sequenze da film di finzione, vecchi documentari detournati, riprese di vita contemporanea in cui le immagini di coppie gay e lesbiche si intrecciano con quelle di Lost in Sodom (cortometraggio sperimentale del 1933, il primo film gay della storia), Tender fictions (1995), creazione colta e autoironica della propria autobiografia, che realizza attingendo anche a immagini di archivio, non solo personali, e History Lessons (2000). Qui, partendo dal fatto che la rappresentazione lesbica, almeno fino agli anni Settanta, non esiste, la regista – sottolineando l’operazione archivistica (Hammer è una appassionata ricercatrice) – rintraccia materiali sulle donne girati nel passato, ovviamente da uomini, e le monta creando una nuova sovversiva organizzazione narrativa, sottolineata da interventi anche sonori (su tutti si ricorda la formidabile manomissione vocale all’inizio del film, in cui grazie al doppiaggio vediamo e ascoltiamo la first lady Eleonor Roosvelt [fig. 1] rivolgersi alle donne del pubblico di una conferenza sostituendo alla parola ‘donne’, ‘lesbiche’): strategia formale che porta alla modifica radicale del senso delle immagini che, stravolte e ricomposte con ironia e sarcasmo queer, diventano racconto e testimonianza della realtà delle lesbiche prima di Stonewall. «La storia non dovrebbe appartenere soltanto a quelli che la fanno, ma anche a coloro che non l’hanno fatta e la rifanno. La storia è viva e può essere cambiata con un pezzo di carta ritrovato, una vecchia fotografia, un ricordo. Ogni oggetto culturale, ogni ricordo personale, ogni sogno e visione del futuro può essere considerata storia». L’affermazione si collega al progetto web Lesbians in Cyberspace, per la costruzione di un archivio collettivo di memorie, visioni, frammenti di sé, riprese, disegni, fotografie, musica, così che le lesbiche prendano spazio nel mondo e, anche attraverso il nuovo mezzo, si rendano visibili, esistano. L’operazione (che rimanda anche alle sue produzioni volte alla valorizzazione di artiste lesbiche emarginate dalla storia ufficiale) testimonia la volontà di dare corpo alle donne omosessuali creando immagini che testimonino il loro passato, visualizzandone l’esistenza antecedente il suo essere nominata e riconosciuta. Questa esigenza di affermazione di visibilità passa sempre attraverso i corpi: nessun intento puramente teorico-proclamatorio è del cinema di Hammer, che predilige dichiarazioni di lotta e di accusa ironiche e provocatorie, con un senso tutto queer che emerge anche nelle sue opere ‘archivistiche’ (in cui gioca, manomette e stravolge i piani temporali creando quindi anche un ‘tempo queer’). Di corpo e di corpi sono sature le inquadrature selezionate dalla regista per le sue lezioni di storia: donne che praticano sport, che fanno campeggio o si impegnano in esercizi militari, che passeggiano conversando, che cantano, che danzano e amoreggiano (e cadono vittime di violenza maschile), ma anche impegnate in esplicite performance erotiche e pornografiche (tratte dai primi stagfilms).