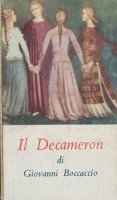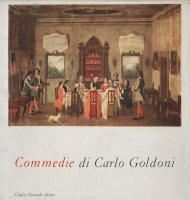Volumi racchiusi talvolta in cofanetti ornati da illustrazioni a colori e impreziositi al loro interno da materiale iconografico fuori testo, rilegature cucite, a filo refe, fregi o caratteri in oro sul dorso, eleganti copertine telate: sono queste le caratteristiche di alcune edizioni della collana einaudiana I millenni, nata nel 1947 sotto la direzione di Cesare Pavese e presentata al pubblico dei lettori attraverso una pregiata veste tipografica.
La serie raccoglie l’eredità dei Giganti, collana d’anteguerra di cui viene realizzata nel 1942 un’unica uscita, Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, e ospita una variegata selezione di classici della letteratura mondiale di tutti i tempi, dalle raccolte di novelle e di fiabe e dal monumentale Parnaso italiano curato da Carlo Muscetta fino ai capolavori della letteratura antica, russa o cinese. L’apparente assenza di un unico nucleo generatore e la mancanza di un unico percorso contenutistico si riflettono nel principio di inclusione dei testi, tutt’altro che univoco. Come testimonia il verbale editoriale del 9 novembre 1949, tra la collezione dei Millenni e le affini Universale e Narratori stranieri tradotti, il «criterio di collocazione è elastico» e tale da essere demandato a una «decisione caso per caso» (Munari 2011, p. 74). Al consapevole diniego di rigidi steccati nelle linee editoriali si accompagnano i differenti punti di vista di volta in volta adottati dai consulenti nel corso delle discussioni sulla collana, che sfugge ai tentativi di definizione nella misura in cui, paradossalmente, si rende riconoscibile anche, e soprattutto, in virtù del suo prestigio culturale. Alla ritrosia di Pavese di includere i contemporanei o di procedere a una loro pubblicazione nella serie solo quando abbiano raggiunto un certo grado di ‘classicità’, abbiano cioè inciso un segno sulla loro epoca (cfr. Mangoni 1999, p. 464), fa da pendant, in fase decisionale, l’eloquente assenso di Calvino all’attribuzione della Vita di Benvenuto Cellini all’Universale, «perché mancherebbe, nel caso del Cellini, quell’elemento di “riscoperta” che è presupposto per l’inclusione di un classico nei “Millenni”» (Munari 2011, p. 447).