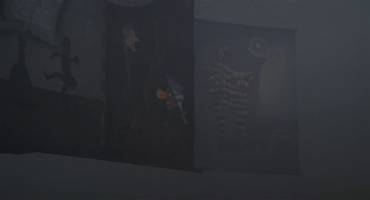1. Premessa
Al di là di qualunque astrazione teorica e retorico-stilistica, l’evoluzione e la rimodulazione del concetto di ecfrasi in epoca contemporanea deve necessariamente intercettare alcune modificazioni materiali dei mezzi di produzione e riproduzione delle immagini.[1]
Nel momento in cui, attraverso l’istantanea fotografica, un’icona si offre all’osservatore secondo modalità di fruizione illimitata, con un incremento progressivo della nitidezza e della resa dei particolari grafici, lo sguardo dispone propriamente di un nuovo oggetto di visione (e, conseguentemente, di rappresentazione). Non si registra più la necessità di recarsi in pellegrinaggio estetico di fronte all’opera né di consultare riproduzioni sgranate e in bianco e nero; l’immagine è accessibile in ogni momento e con un grado di leggibilità e precisione addirittura superiore rispetto alla normale osservazione soggettiva, viziata da accidenti empirici o da allestimenti poco lungimiranti che non consentono un avvicinamento materiale dell’osservatore. La possibilità di disporre di un museo domestico senza barriere o vincoli spazio-temporali (per la durata potenzialmente infinita dell’atto di osservazione e per l’annullamento delle distanze e delle barriere dimensionali tra spettatore e opera d’arte) comporta, in alcune modalità contemporanee di scritture ecfrastiche, una resa iperrealistica e spregiudicatamente mimetica della fonte.
La prima conseguenza statisticamente rilevante riguarda la preponderanza dilagante dei casi di actual ekphrasis (ossia, secondo la definizione di John Hollander, componimenti ecfrastici costruiti a partire da quadri o sculture ‘reali’).[2] Rispetto alla reinvenzione del referente a opera della fantasia dell’autore (fino alla costruzione, a posteriori, di un quadro squisitamente letterario, come avviene spesso nella Galeria mariniana),[3] l’ecfrasi mediata dalla fotografia tende a risolversi in un gioco interlineare con la fonte, considerata alla stregua di un testo visivo con cui avviare una forma eccentrica e medialmente aggiornata di intertestualità. Lo sguardo fotografico, tuttavia, non rappresenta mai una traslitterazione neutra del contenuto iconico, giacché la visualizzazione di un quadro in fotografia (soprattutto se in bianco e nero) comporta alcuni fraintendimenti, errori di prospettiva, e in generale la focalizzazione su elementi diversi rispetto alla visione diretta della fonte – soprattutto per quanto riguarda le sculture, che la fotografia restituisce in una sola dimensione e attraverso la scelta autoritaria di un lato isolato dell’osservazione. Come asserisce Barthes in un saggio capitale dedicato al messaggio fotografico, la presunta oggettività dell’immagine fotografica come analogon del reale, privato del dualismo tra connotazione e interpretazione, è semplicemente un «mito» o un «paradosso estetico».[4]