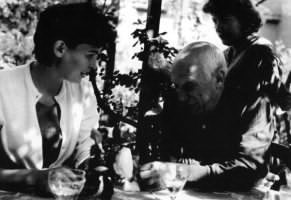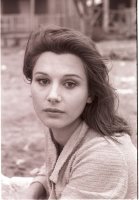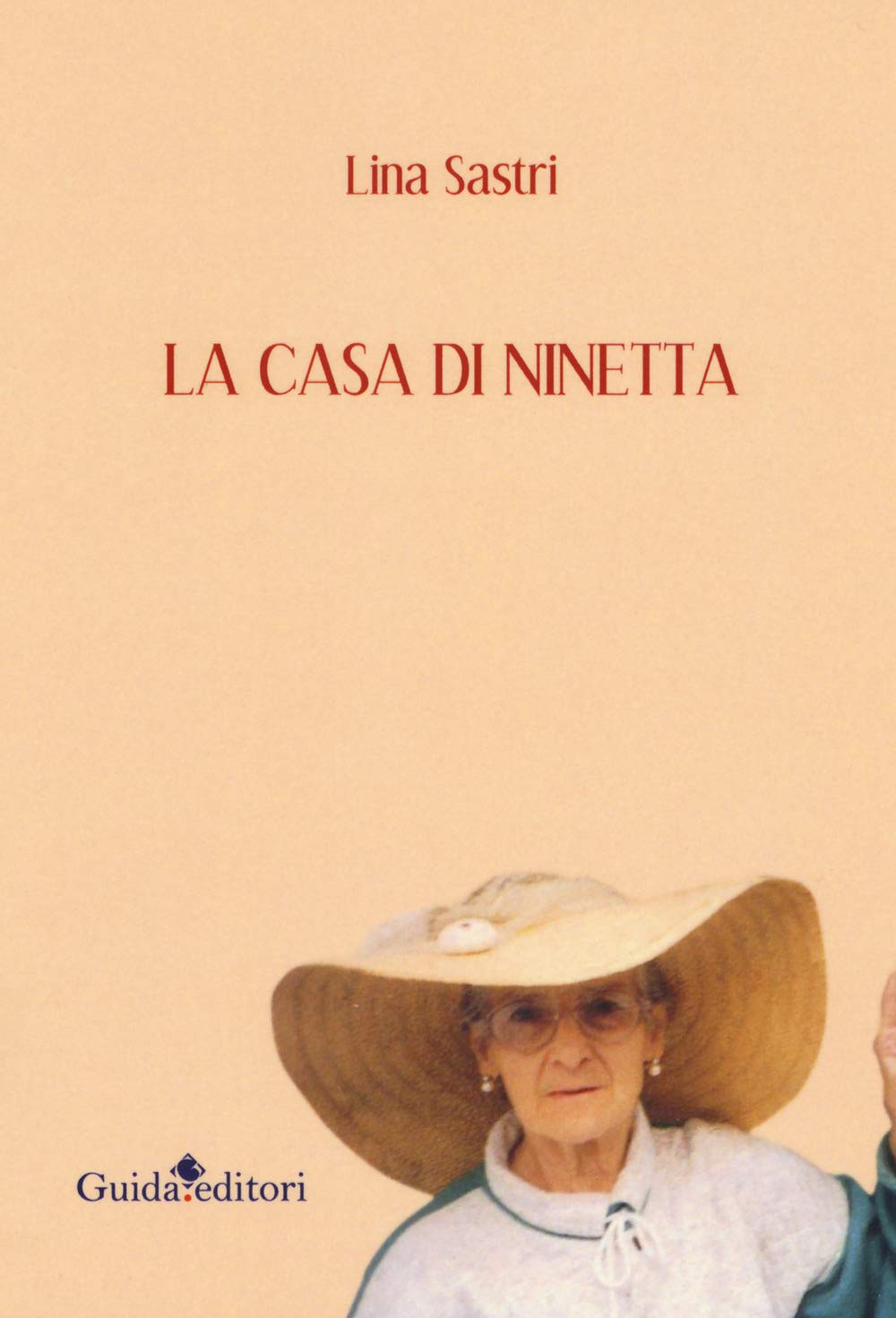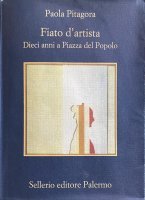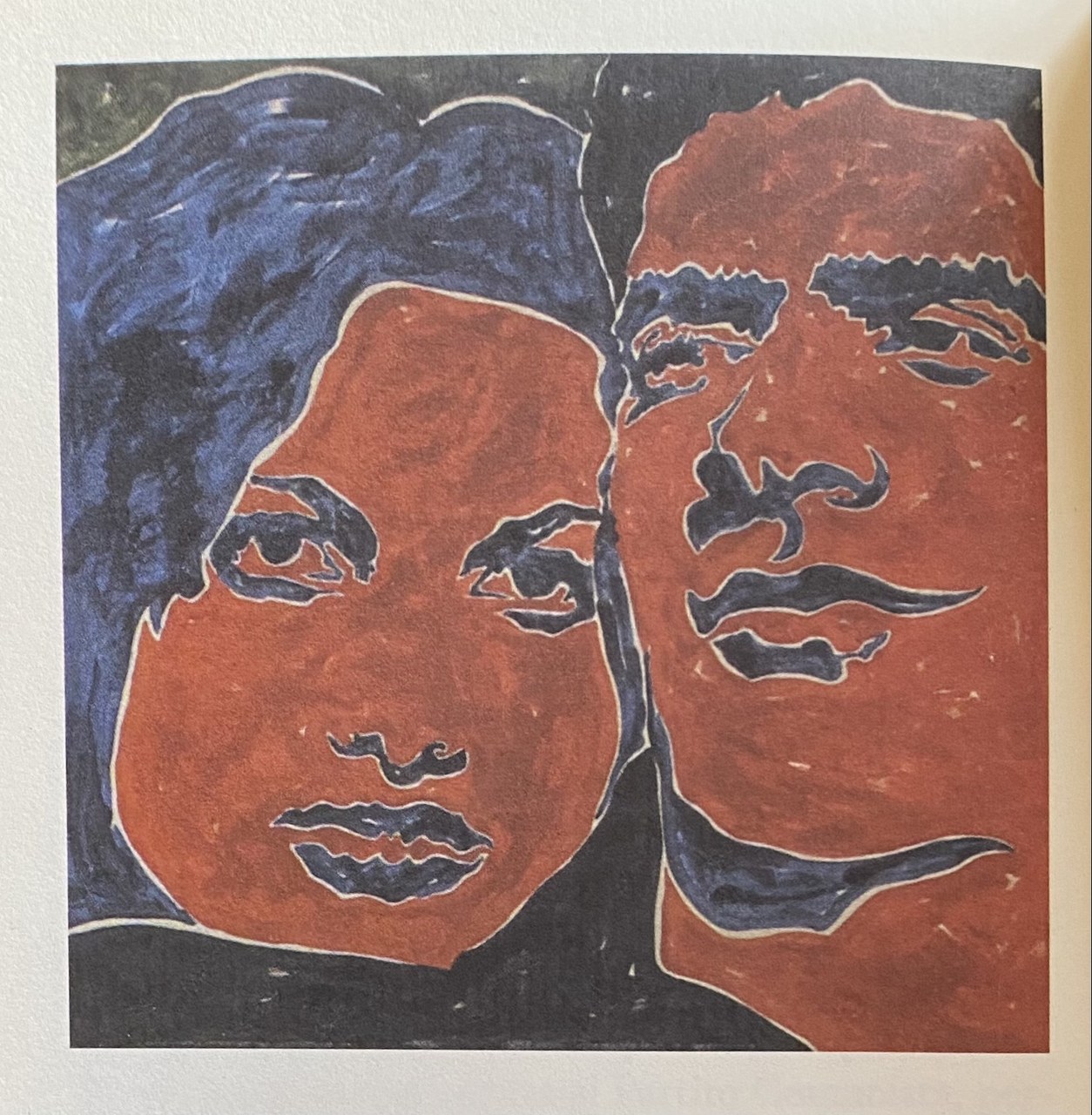1. Introduzione
Gli strumenti di costruzione di una coscienza globale sull’attuale condizione di sfruttamento del pianeta – e sulle relative conseguenze ambientali – sono sovente frutto di un’ampia campagna di informazione pubblica condotta attraverso i media e i nuovi canali dell’informazione digitale. Eppure, il teatro può essere considerato un efficace strumento, non solo divulgativo ma anche persuasivo, per ciò che concerne le urgenti tematiche ecologiche e ambientali contemporanee.
Come temi drammatici, il cambiamento climatico e la crisi ecologica sfuggono al modello di una rappresentazione drammaturgica statica. È pertanto più opportuno approcciarsi ad essi pensandoli come degli hyperobjects, un termine coniato da Timothy Morton[2] per descrivere fenomeni che presentano, rispetto agli esseri umani, una tale dimensione/entità temporale e spaziale da poter essere visti solo in piccole parti – in singoli momenti – e la cui comprensione resta pertanto intrinsecamente difficile. Possiamo sperimentare direttamente il tempo atmosferico, ad esempio, ma il clima come sistema espanso e disperso rimane inaccessibile ai singoli individui, per quanto i potenti mezzi tecnologici attuali possano modellarlo bene. L’esempio di iperoggetto di nostro interesse è senza dubbio il riscaldamento globale, che a sua volta costringe l’essere umano a prendere coscienza che la sua esistenza si svolge di fatto all’interno di una continua serie di iperoggetti, che non esiste ‘un fuori’.