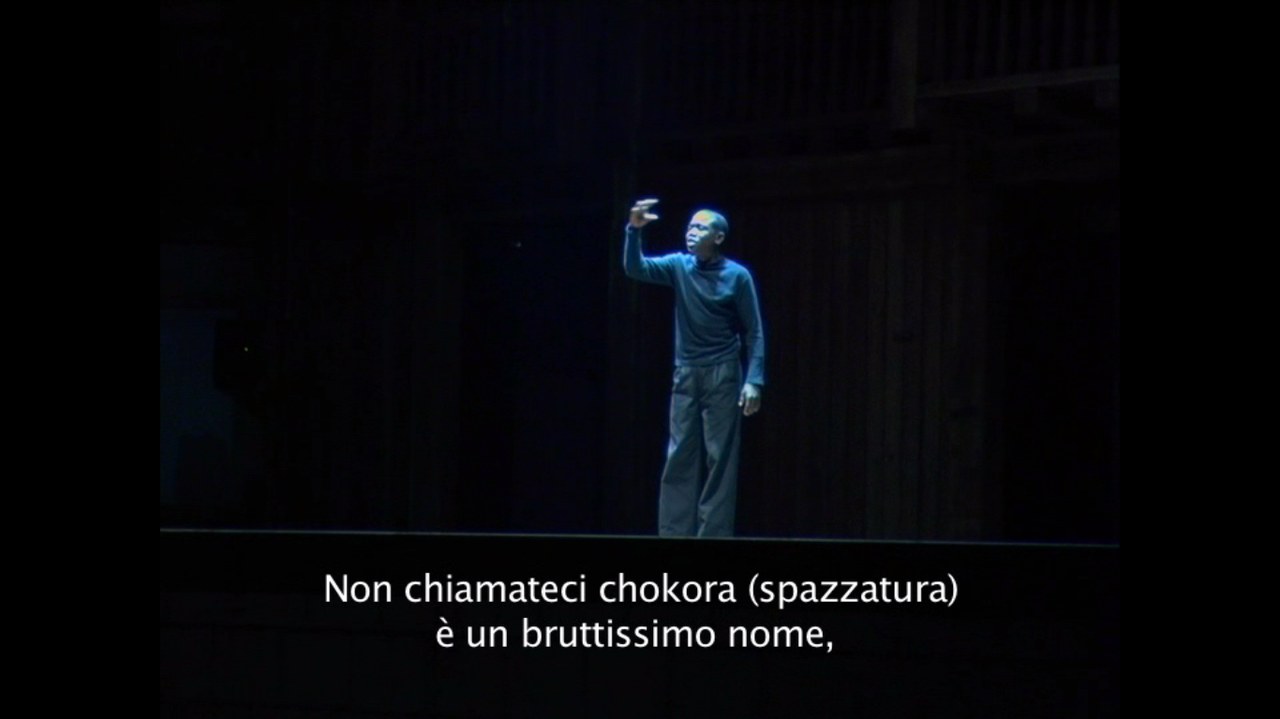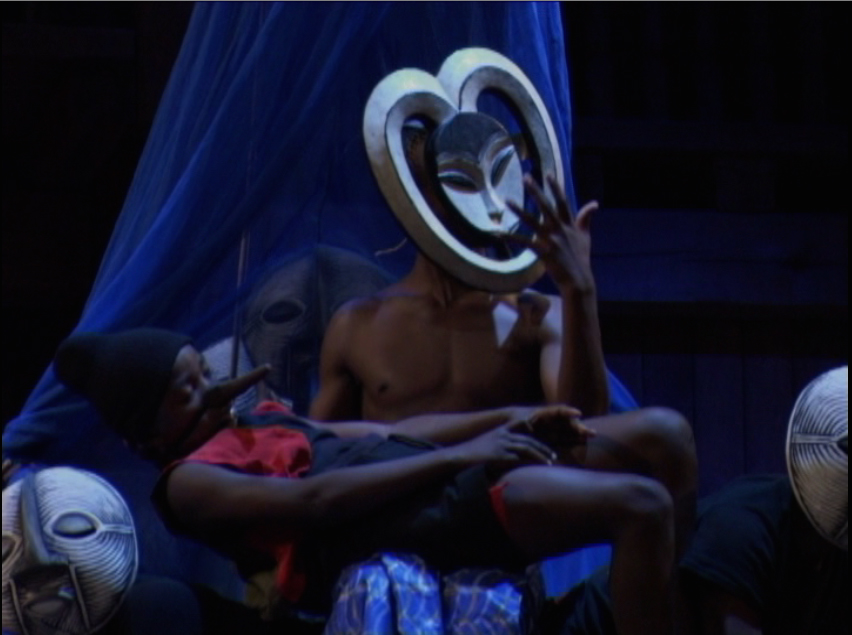Riprese audio-video: Francesco Pellegrino, Ana Duque; fotografia: Francesco Pellegrino; foto di scena: Salvo Grasso; montaggio: Ana Duque.
Qui di seguito la trascrizione integrale dell’intervista.
D: Il numero di Arabeschi che ospita questo ‘videoincontro’ è incentrato principalmente sull’idea di trasformazioni fisiche, di metamorfosi del corpo. A questo proposito, schematizzando, si potrebbe forse distinguere tra un tipo di trasformazioni corporee che potremmo definire ‘di oppressione’, di tipo verticale, subìte dal corpo (un esempio su tutti è il Salò di Pasolini), e un altro tipo di trasformazioni corporee che potremmo invece definire ‘di liberazione’, dunque non subìte ma agite dal corpo stesso (pensiamo magari all’idea della peste in Artaud). Tale polarità potrebbe essere una delle chiavi del tuo teatro, cioè mi sembra che queste due forze di trasformazione fisica e di azione sui corpi e dei corpi sia costantemente presente sulle tue scene. In che modo pensi che questo avvenga nel tuo teatro, sia nel risultato dei tuoi spettacoli che, si potrebbe aggiungere, nel processo creativo, ossia nel rapporto tra azione coercitiva della regia che permette l’azione liberatoria del corpo dell’attore?
R: Ci sono sicuramente due processi che sono legati anche al tempo in cui si protrae l’intenzione di far vivere gli spettacoli. Due tempi: il tempo della creazione e il tempo della vita dello spettacolo. Io faccio un teatro di repertorio, quindi quando nascono i miei spettacoli mi auguro che vivano per almeno dieci anni e così in alcuni casi è stato. Questo cosa significa? Che nel corso di dieci anni i corpi degli attori che li fanno cambiano, quindi non è soltanto un cambiamento legato alla creazione di quello spettacolo ma anche alla vita, al processo di invecchiamento di quello spettacolo, perché il corpo in quel tempo invecchia, quindi la qualità del movimento cambia. Non dico che peggiora, anzi a volte si affina, si mette a punto, diventa ancora più incisiva. Sicuramente quando io lavoro con i miei attori chiedo sempre loro un grande sforzo, legato proprio alla ricerca di un gesto non naturale, che però deve diventare naturale. Questo è molto difficile, forse li mette in una condizione di ‘prigione’ del corpo: sicuramente per arrivare a questa naturalezza è necessario stare dentro dei paletti, dentro un recinto. Però poi, dopo, risulta ‘liberatorio’, quindi alla fine del processo di creazione loro sono liberi. Eppure non lo sono stati durante la creazione, durante la genesi.