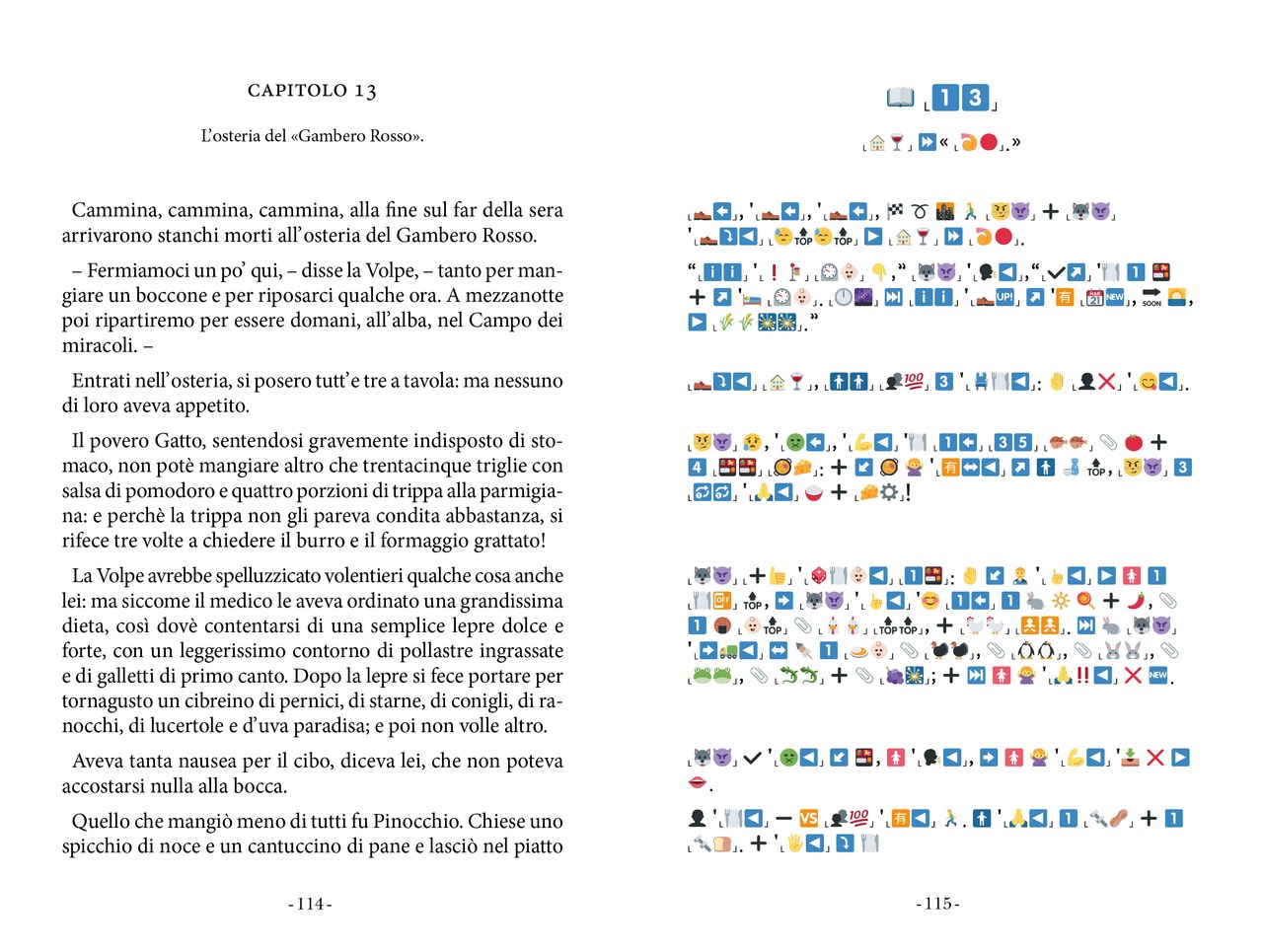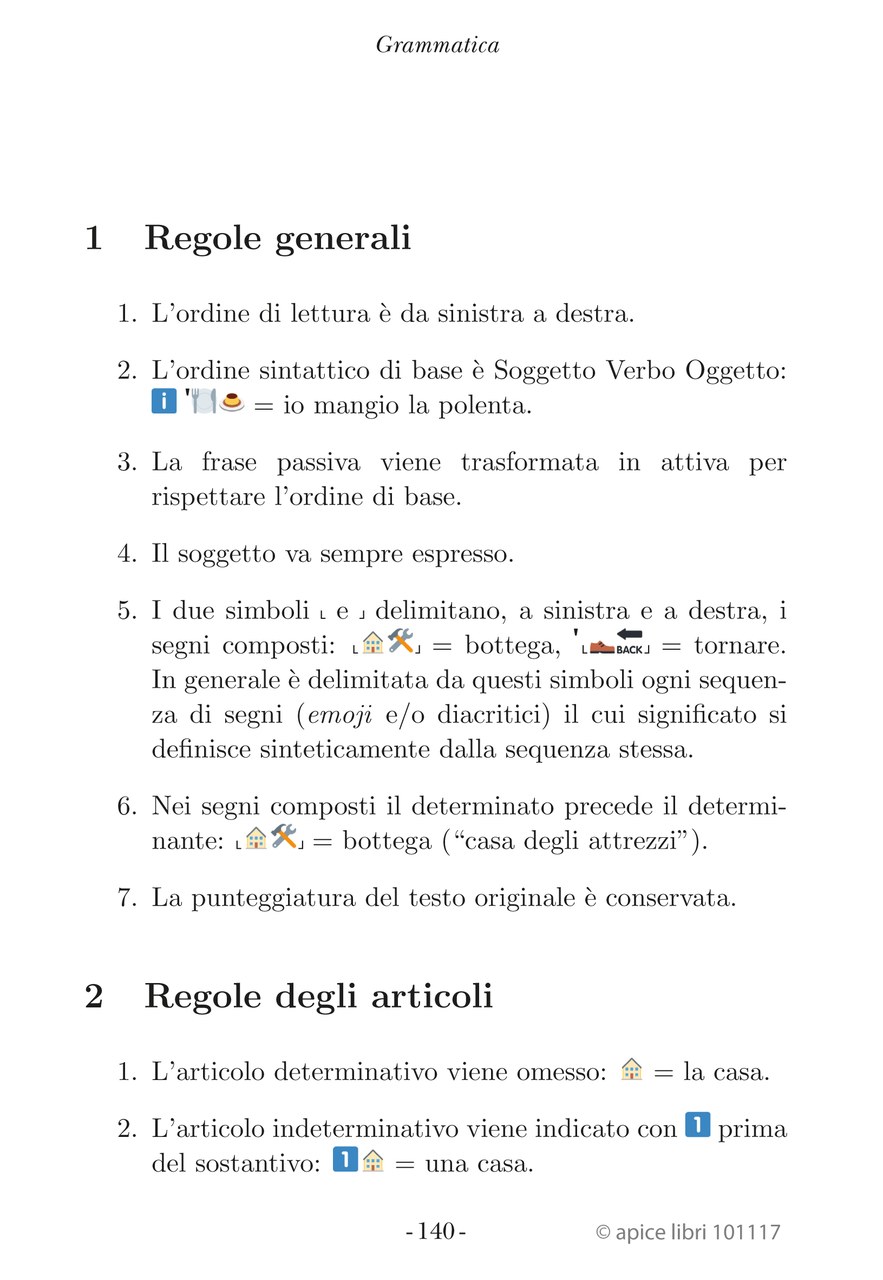«Sai», egli le disse, «che cosa sembra?»
«Che cosa?» disse Berta.
«Che io abbia un incantesimo in te».
«E io in te. Non l’ho anch’io in te?»
«Questa è la nostra cosa».
Elio Vittorini, Uomini e no
Autore centrale per la cultura italiana del secondo dopoguerra, ma poco frequentato rispetto alla sua notorietà intellettuale, Elio Vittorini è oggi al centro di un ritorno di attenzione anche da parte del mondo teatrale. Le ragioni del recente interesse drammaturgico nei confronti dell’opera dello scrittore siciliano vanno ricondotte sostanzialmente a due fattori: da un lato la spiccata inclinazione della letteratura teatrale contemporanea alla riscrittura di romanzi, tendenza a cui si aggiunge la prassi novecentesca volta alla costruzione di spettacoli tratti da testi non drammatici; dall’altro la naturale disposizione al teatro della narrativa vittoriniana, frutto di un uso particolare dei dialoghi, fitti e dallo stile recitativo, e di un registro linguistico visuale, plastico e teso all’evocazione.
Riguardo a questo secondo fattore, principale leva dell’interesse dei teatranti verso la pagina di Vittorini, va detto che un’impronta di ‘teatro nascosto nel romanzo’ è stata rilevata da tempo nella sua opera, specialmente nei testi considerati sperimentali come Conversazione in Sicilia (1941) e Uomini e no (1945). Quest’ultimo romanzo, in particolare, condensa magistralmente la doppia tensione della penna di Vittorini: l’apertura mitico-universale e la concentrazione storico-realistica; le quali, unite a un linguaggio intriso di pulsione visuale, ne fanno un ‘oggetto’ narratologico che ben si presta a una migrazione verso il palcoscenico.