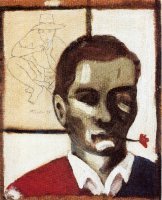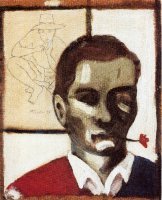Se abbiamo scelto questo noto autoritratto pasoliniano non è certo per tentare l’ennesima analisi critico-stilistica, per la quale rimandiamo agli studi di Achille Bonito Oliva e Francesco Galluzzi, bensì per evidenziare quella che ci è parsa costituire una delle molteplici incursioni dell’immagine nei processi narrativi dell’autore.
A quasi trent’anni dalla realizzazione del dipinto a olio, che segnò una delle ultime tappe dell’attività grafica pasoliniana prima di una temporanea eclissi, Pasolini sembra ispirarsene, in una delle sue consuete transcodificazioni tra generi, nelle pagine del metaromanzo Petrolio. Un’opera che non a caso costituisce un punto di osservazione privilegiato dell’officina pasoliniana, in cui sui travasi appena menzionati si innestano meccanismi di contaminazione definiti da qualche critico come propri di un’identità manieristica pasoliniana.
All’interno della visione del Giardino medioevale (Appunto 65 bis), una delle tappe culminanti dell’apparato allucinatorio di Petrolio, Carlo, il protagonista sdoppiato, specchio dell’autore-narratore, si ritrova dinanzi a uno strano consesso divino in cui figurano, immobili e ieratici, gli antichi «dei dell’Umile Italia», ipostasi allegoriche dei valori di una revoluta civiltà agreste annientata dal genocidio borghese. Tale episodio ci è apparso rappresentativo di quella costante «fuga dalla citazione» messa in atto dall’autore nell’attimo stesso in cui attinge a una fonte iconografica. Se nel preludio al frammento in questione il narratore cita su un tono di parodia didascalica la sua fonte – «per la descrizione delle divinità o idoli, ricorrere a descrizioni di figure sacre fatte da Longhi dalla pittura del Trecento (Cimabue, Stefano Fiorentino, Giotto ‘‘spazioso’’)» –, l’operazione è in realtà più complessa. Più che ai tre saggi longhiani, Pasolini sembra rifarsi piuttosto al Piero della Francesca sempre di longhiana memoria. Al centro del giardino emerge infatti isolata la figura del dio Dulcimascolo, incarnazione del sottoproletariato. Se l’ebano della pelle scura del dio costituisce un’evidente citazione dal Piero longhiano, altri dettagli sembrano riecheggiare ecfrasticamente l’autoritratto del ’47. Il giovane dio viene infatti immortalato disteso «con il gomito puntato a terra e la nuca appoggiata sul palmo della mano, masticando tra i denti qualcosa, forse il gambo lungo e leggero di una spiga».