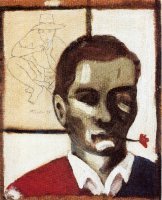L’uovo che compare nella copertina de Il dono di Antonia, l’ultimo romanzo di Alessandra Sarchi, si rivela sin da subito il leitmotiv verbovisivo che percorre l’intera trama del racconto, dalla soglia paratestuale che rappresenta l’opera di Adelaide Cioni (Ab ovo. White egg, 2020) e mostra in epigrafe i versi di Anne Michaels, Fontanelle, alle tante occorrenze del lemma legato a doppio filo al motivo della maternità e della generazione che costituisce il fulcro attorno a cui ruota tutta la storia.
Antonia, la protagonista, vive con la sua famiglia in campagna, in una casa poco lontano da Bologna, dove si dedica all’allevamento di capre, mucche e galline; «circondata di totem di maternità» si trova a fare i conti con il suo essere madre di Anna, la figlia adolescente e anoressica che prova a prendere le distanze da lei, e di Jessie, il quale vorrebbe conoscerla ed è figlio di Myrtha, un’amica conosciuta a Los Angeles quando era ancora studente, a cui ha donato un uovo e la possibilità di essere madre. Le forze di segno opposto esercitate dalle due creature generate da una parte del suo corpo, una che cerca di staccarsi, l’altro che prova ad avvicinarsi, la inducono a interrogarsi sul senso della maternità riallacciando i fili con il suo passato, ricominciando ab ovo appunto, cioè tornando non soltanto al punto in cui ha deciso di dare la vita ad Anna e una possibilità di esistere a Jessie, ma ripensando anche alla sua storia di figlia. Il grumo di gioie e sofferenza, responsabilità e paura, di forza e debolezza, di potere e fragilità, di libertà e vincoli che si dipana non soltanto dall’intreccio della linea diegetica principale, ma anche dai racconti di Alice e Sara (due donne conosciute da Antonia alle riunioni del gruppo di sostegno che frequenta), rende palese come il macrotema della pro-creazione si ponga come il nodo assolutamente centrale dei rapporti umani, in tutte le sue infinite e molteplici sfaccettature. Il dono di Antonia, in realtà, è un romanzo sulla maternità non meno di quanto non sia un apologo sull’amicizia, su quelle relazioni fra donne che danno forma all’immagine di ognuna di noi. «Ho imparato, in seguito, – dice Antonia a Jessie, quando decide di incontrarlo e spiegargli il senso della sua scelta – che accade spesso a una donna di capire chi vuole essere attraverso un’altra donna». Questo è stata Myrtha per lei, questo è stata lei per Myrtha in passato; questo continuano ad essere le due nuove amiche Alice e Sara, che le regalano le loro memorie di madri e di figlie e alle quali vorrebbe parlare di Anna e di Jessie. Con l’una ha spartito un pezzo del suo corpo, con le altre desidera condividere frammenti della sua vita (Antonia sente più volte l’impulso a «confessarsi e ad ascoltare una confessione»). C’è una corrispondenza molto stretta fra la costruzione della propria immagine e il racconto del proprio passato, che afferma inevitabilmente – lo ha detto una volta per tutte Adriana Cavarero in Tu che mi guardi, tu che mi racconti – la dimensione relazionale della soggettività. Tale dimensione in questo romanzo si avvolge e si addensa attorno al tema del materno, dove corpo e racconto si accordano come due tasti di uno stesso strumento. C’è un momento dell’incontro con Jessie in cui ciò appare in modo evidente: