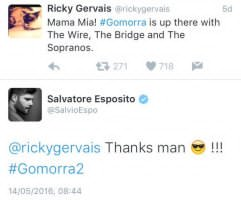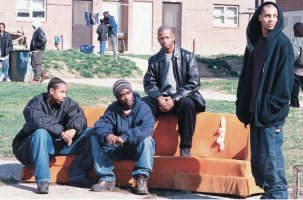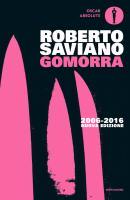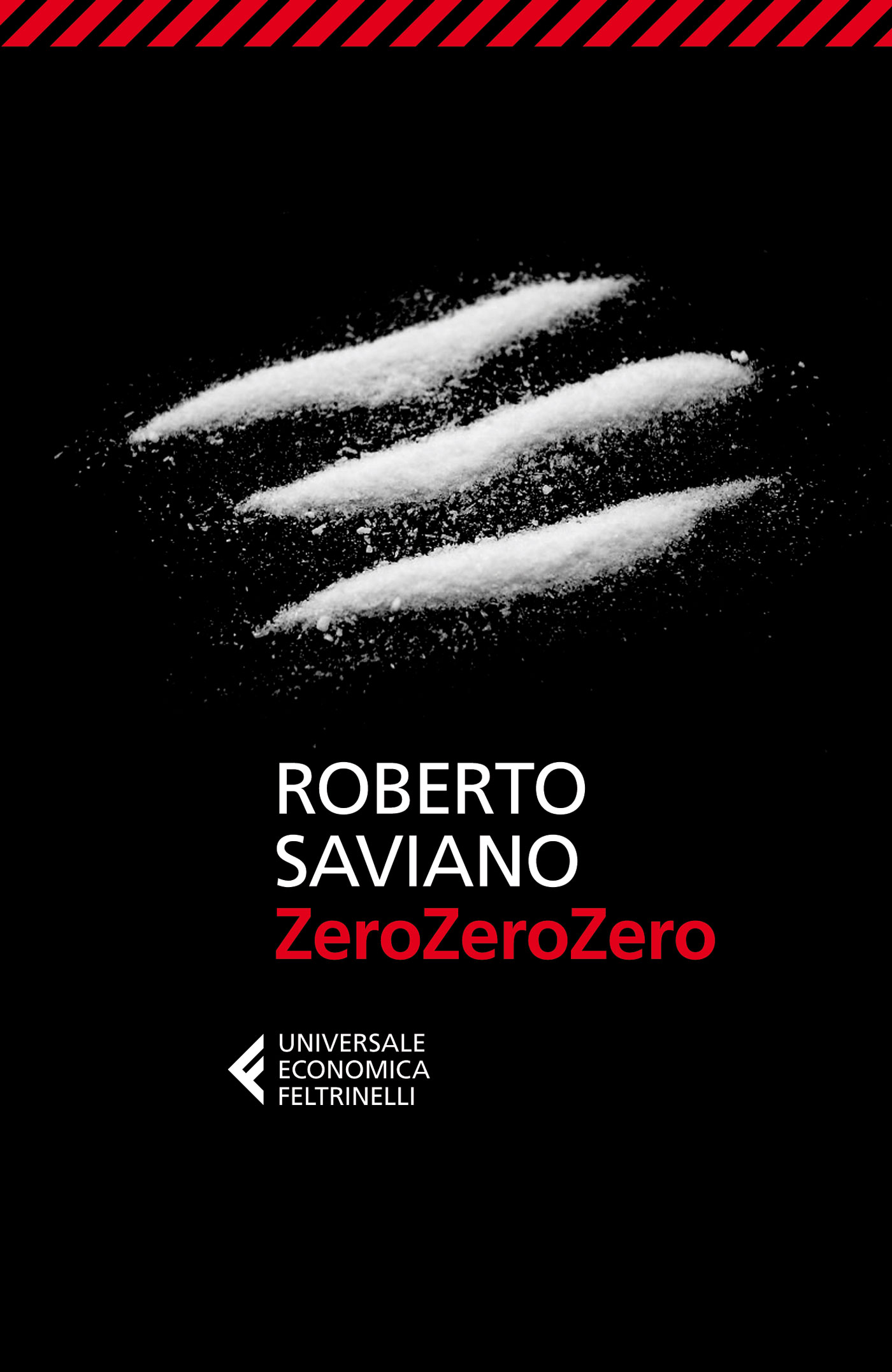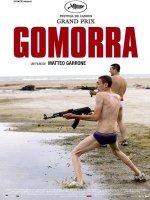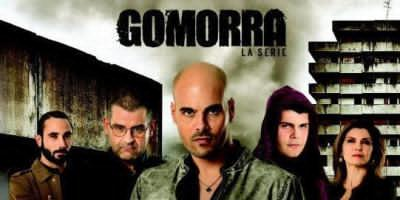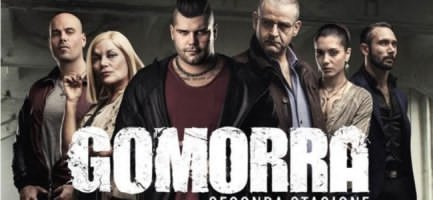Dopo la messa in onda delle prime due puntate in Gran Bretagna, trasmesse da Sky Atlantic nel maggio 2014, il comico britannico Ricky Gervais ha paragonato, con un tweet piuttosto eloquente, la serie italiana Gomorra a tre dei prodotti di maggiore successo della nuova serialità televisiva contemporanea:
The Wire, serie creata da David Simon e prodotta da HBO, trasmessa tra il 2002 e il 2008, per un totale di sessanta episodi in cinque stagioni, è il prodotto televisivo che più di altri è stato paragonato alla Gomorra seriale, creata da Stefano Sollima e ispirata al libro, ormai best-seller, di Roberto Saviano. Tale giudizio di merito, teso a legittimare la presenza di una serie italiana, seppur con appena due stagioni all’attivo, nel novero delle migliori serie televisive mondiali della storia recente, ha trovato un certo riscontro in buona parte della critica televisiva americana e britannica, che ha più volte riproposto il confronto. I primi, nel 2014, sono stati The Guardian («Gomorrah doesn't look a million miles away from the Baltimore of David Simon's superlative The Wire») e Variety («If further developed in this direction, “Gomorrah” might well turn into Italy’s answer to The Wire»), seguiti nell’agosto del 2016, subito dopo la messa in onda delle prime puntate della serie italiana sul canale televisivo via cavo americano SundanceTV, dal New York Times («it’s a grim, detailed, quotidian drama about the inner workings of organized crime – which has drawn comparisons to The Wire») e dall’Hollywood Reporter («Gomorrah won’t be a complete revelation because in many ways it pays homage to the best of American television, particularly HBO’s The Wire», e «the directions Gomorrah goes in that neither The Wire or The Sopranos chose»). Lo stesso Andrea Scrosati, Executive Vice-President Programming di Sky Italia, ha commentato, ancora al New York Times: «I don’t think anybody in Baltimore thinks that criminal activity taking place in the port of Baltimore happened because there was The Wire», collegando idealmente tra loro non solo i contenuti delle due serie, ma anche gli esiti dei dibattiti da esse suscitati.