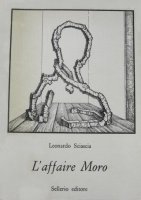Ho sempre visto il ficus come una specie di mostro arboreo: e specialmente a Palermo quello di Piazza Marina, di cui forse anche prima, ma sicuramente nel racconto Porte aperte mi è avvenuto di scrivere. Un pauroso emblema della violenza e dell’imprevedibilità della natura: forse perché a Palermo in Piazza Marina, sta a fronte di quel palazzo in cui tragiche memorie si assommano dell’umana violenza: la violenza dell’anarchia baronale, la violenza del Sant’Uffizio dell’Inquisizione, la violenza dell’amministrazione della giustizia del regno d’Italia.
L. Sciascia, Nota a Ficus (1988)
Sciascia ammira molto Bruno Caruso, pittore che ha assunto gli alberi come proprio modello iconico divenendo un interprete privilegiato di questo soggetto. Non a caso le pagine più belle che l’autore di Racalmuto scrive sugli alberi sono ispirate proprio dalla visione delle acqueforti di questo artista. A colpire maggiormente l’immaginario dello scrittore ci sono prima di tutto i Ficus di piazza Marina che Caruso aveva disegnato e inciso riproducendo con perizia i fusti contorti. Il groviglio di quelle radici attira l’attenzione di Sciascia forse perché gli ricorda il labirinto in cui si perdevano spesso i suoi pensieri e così mentre l’artista si muove con acidi e bulini per riprodurre l’albero sulla lastra metallica, l’inchiostro dello scrittore con uguale violenza lascia il proprio segno nero su bianco, creando un gioco simbiotico di scambi tra i disegni e le parole (importante a tal proposito è lo scritto introduttivo alla cartella I grandi giardini intitolato Gli alberi di Bruno Caruso, che Sciascia scrive nel 1968). Gli alberi di Caruso fanno scaturire nella mente di Sciascia una serie di ricordi e riflessioni, perché sono stati piantati di fronte al palazzo che a Palermo aveva ospitato le carceri inquisitoriali, in cui si erano consumate le atroci violenze del Sant’Uffizio. Per questo il suo immaginario li trasforma in figure mostruose, cresciute da semi di dolore, portatrici di una pesante memoria. Quegli alberi sono effigi dell’efferatezza della storia e delle violenze, che in quei luoghi si sono consumate, e che adesso sembrano dimenticate dagli abitanti di Palermo intenti a godere della frescura senza ricordare il lezzo delle carni che lì erano state bruciate.