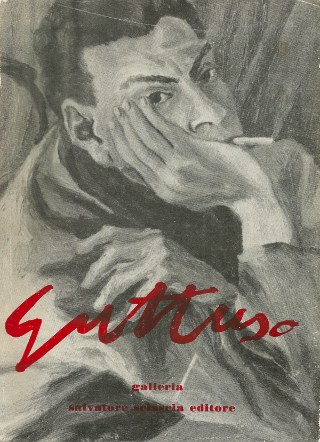Tranchino, stendhalianamente e savinianamente, non lavora […], si diletta: dipinge cioè con diletto, con piacere, come in una prolungata vacanza – tanto prolungata –, continua ed intensa da assorbire interamente la sua vita. E forse appunto da ciò nasce l’attenzione, il sodalizio, l’amicizia che ci lega: dal reciproco riconoscerci dilettanti, proprio nel senso di cui discorreva Savinio per Clerici. E non che il dilettarsi escluda i “latinucci”, la ricerca, l’inquietudine, il travaglio, il guardarsi dentro a volte con sgomento e il guardar fuori con prensile attenzione e a volte avidamente: ma in una sfera, sempre, di “divertimento”, di gioco esistenziale.
L. Sciascia, Dipingere con diletto (1986)
La dimensione ludica e la leggerezza che sembra essere in essa implicita, il gioco esistenziale e il «divertimento» di cui parla Sciascia a proposito della pittura di Gaetano Tranchino non appaiono sempre in modo palese ad una prima lettura delle sue pagine. Invece, proprio nella chiave etimologica suggerita dallo scrittore, l’aggettivo “dilettante” ben si addice alle escursioni sciasciane nel mondo delle arti figurative, all’interno del quale, rivendicando la propria posizione di «appassionato incompetente», egli si sente libero di riconoscere amicizie e sodalizi nati dalla reciproca condivisione del «diletto». La «prolungata vacanza» di Tranchino, e «il piacere di dipingere» che basta a se stesso per Aldo Pecoraino, si incontrano con il piacere di scrivere e di leggere (e di rileggere) di Sciascia (che ha fatto sua la massima di Montaigne «je ne fais rien sans joie») e si pongono sulla stessa linea dello «svagato deambulare di Fabrizio Clerici», identificato inequivocabilmente da Savinio come «indizio sicuro di stendhalismo». Come ha notato giustamente Marco Carapezza (in occasione di un seminario sciasciano dedicato proprio al Piacere di vivere), «è quella di Sciascia e di Clerici un’amicizia tutta interna ad un itinerario saviniano», in cui – aggiungiamo noi – si definisce e viene sempre riproposta quella che potremmo chiamare la ‘funzione Stendhal’. Senza pretendere di sciogliere la complessità e l’importanza che riveste lo scrittore francese per l’opera sciasciana, qui si vuol soltanto sottolineare la dimensione visuale che essa assume e che si specifica accostandosi al mondo figurativo dei pittori più amati dall’autore di Todo modo.