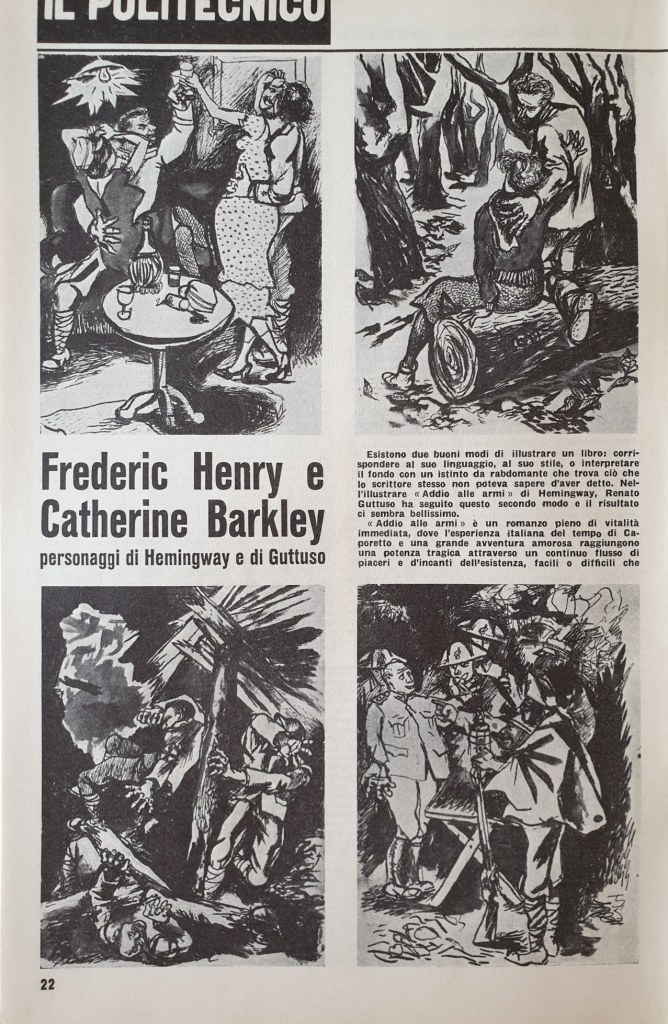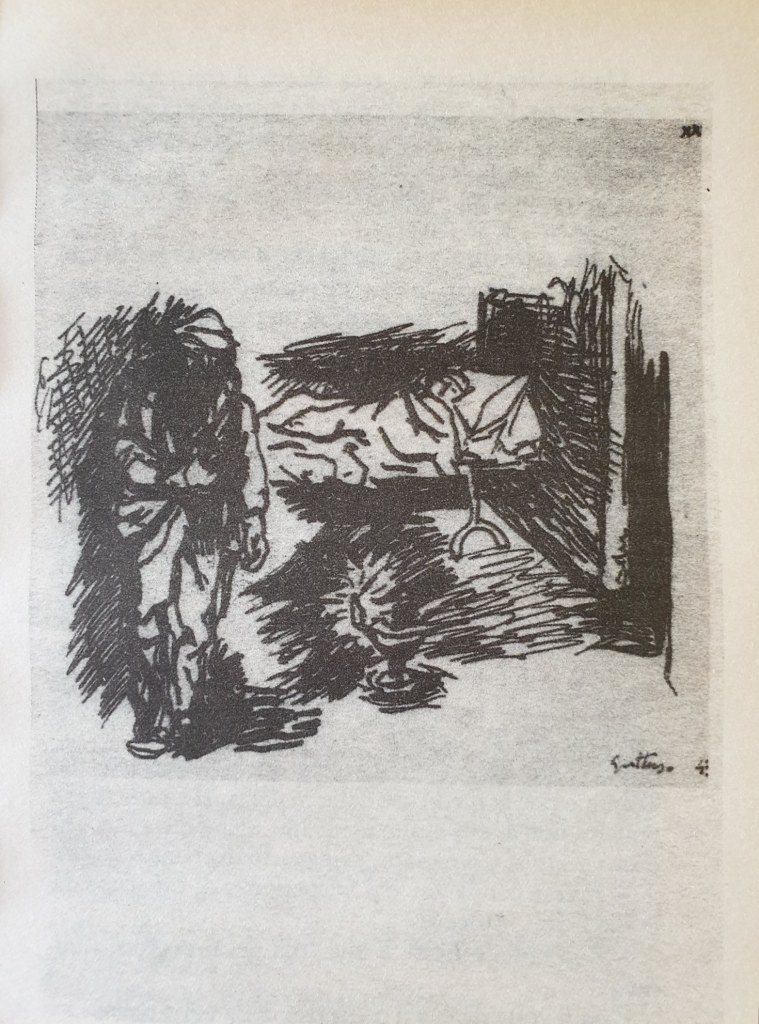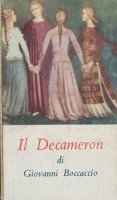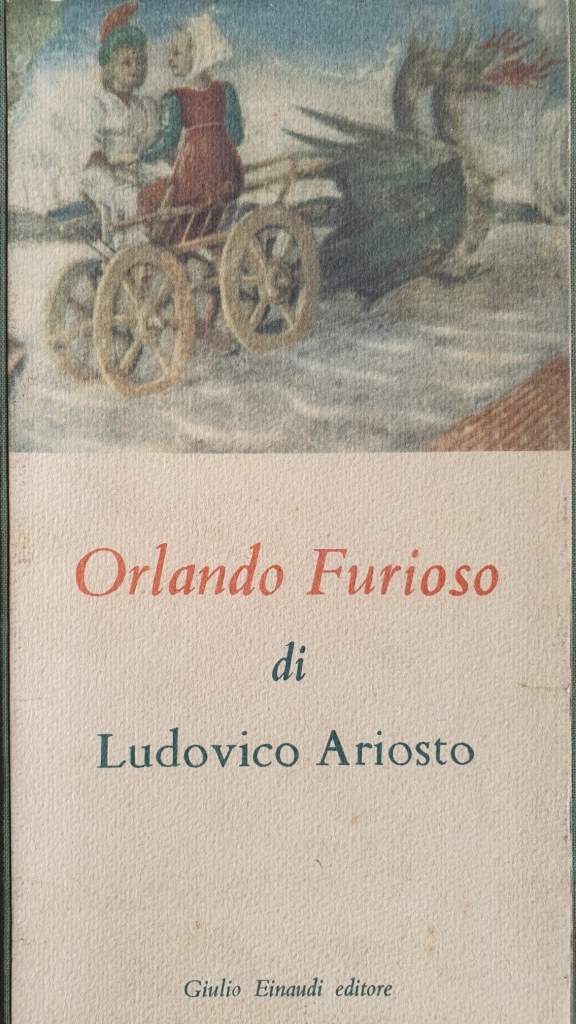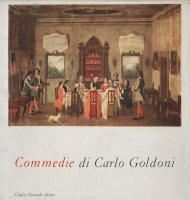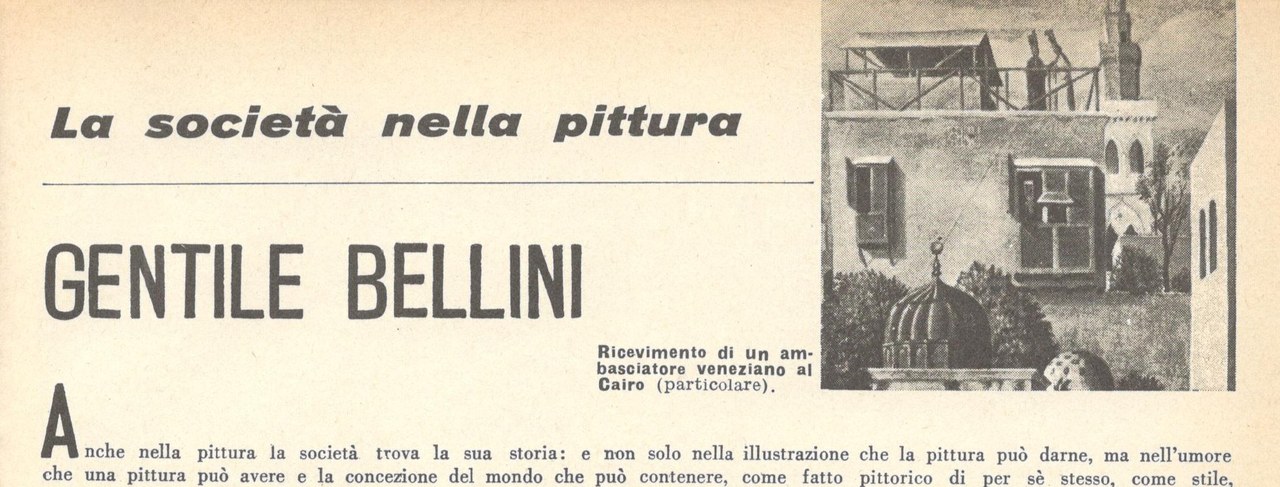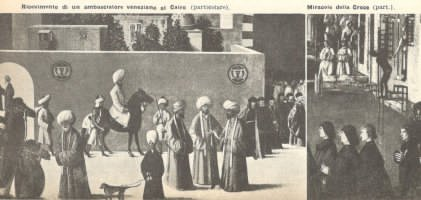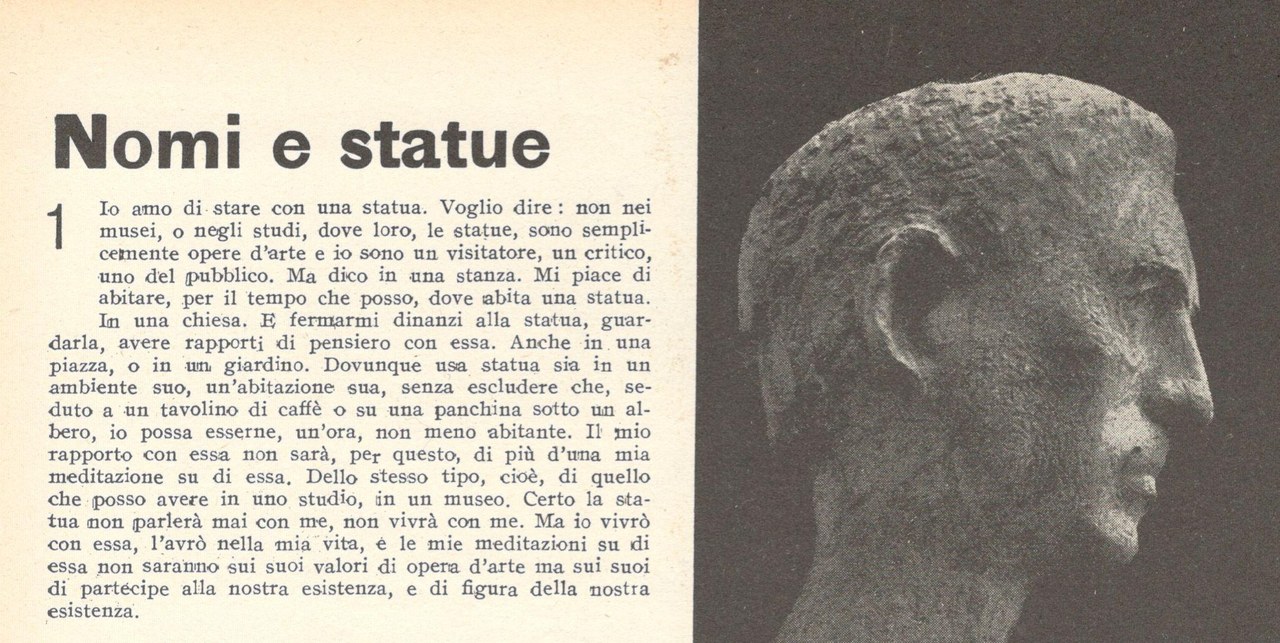In questo libro, come nel suo soggetto, non tutto è come si crede. Anzitutto, inserito in una collana specialistica, la Biblioteca di testi e studi – Storia dell’arte di Carocci, Vita di Luigi Ghirri rifugge il formato, il linguaggio, i mezzi consueti, i segni di riconoscimento scientifico della critica accademica; ne è una prova la voluta assenza di note a piè di pagina, o di una bibliografia specialistica, a fondo volume.
In secondo luogo, e proprio pensando all’agilità del formato – una guida di poco più di un centinaio di pagine, di godibile lettura –, si propone come una biografia, ed è in sé questo, ma anche altro: un avviamento all’estetica fotografica di Ghirri, un’analisi ravvicinata dei suoi modi compositivi, dei suoi periodi, delle tangenze con le altre arti promesse dal sottotitolo: la giovanile scoperta dell’Annunciazione del Beato Angelico, l’appassionamento per la fotografia americana del paesaggio americano, rurale e industriale; l’onnipresente musica, nella sua vita e nei suoi viaggi, Bob Dylan su tutti; le varie e suggestive letture... E questo grazie a un artificio, o contrainte, strutturale: ogni capitolo viene aperto da un testo visuale-finestra, un’immagine che nel corso del racconto viene messa in contesto e analizzata.
Infine, pur nel suo voluto ritagliarsi un ‘a parte’ rispetto ai lavori di critica che nel tempo si sono succeduti (ricorderemo almeno, fra i testi più recenti e innovativi, Luigi Ghirri and the Photography of Place. Interdisciplinary perspectives, a cura di Marina Spunta e Jacopo Benci, del 2017), e anzi puntando sulla personale conoscenza dell’autore, su un ritratto che, nell’evolvere della sua poetica artistica individua coerenti spunti di interpretazione dell’uomo – la figura ritrosa e impacciata; la generosità con gli amici e con le istituzioni cui dona le proprie opere e i propri negativi; il costante sottrarsi al giudizio nei confronti degli altri –, Codeluppi, noto sociologo dei processi culturali e comunicativi e, cosa questa forse meno risaputa, cultore di fotografia sin dagli anni giovanili (nonché, come il compianto Remo Ceserani che all’arte della luce dedicò nel 2011 un libro di tematologia letteraria, L’occhio della Medusa, figlio di un fotografo professionista), riesce nell’intento di offrire un contributo in certa misura originale, non inerte alla bibliografia critica ghirriana.